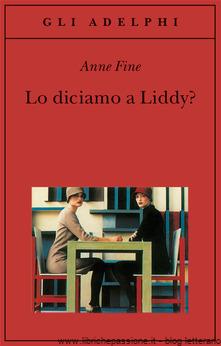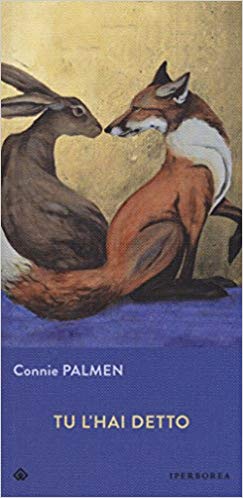
Sinossi
Ted Hughes e Sylvia Plath, la coppia «maledetta» della letteratura moderna, segnata dal suicidio di Sylvia a soli trent’anni nel 1963, ha ispirato ogni sorta di speculazioni e mitizzazioni sulla fragile martire e il suo brutale carnefice. In questo romanzo Connie Palmen dà voce a Ted Hughes e fa raccontare a lui – il poeta, il marito, l’uomo che non può smettere di interrogarsi sulle proprie colpe ma che ha sempre mantenuto un religioso silenzio sulla moglie perduta – la sua verità. Una confessione intima, un incalzante viaggio emotivo che ci risucchia nella spirale di un amore tragico fra due scrittori uniti nel sacro fuoco dell’arte: dal primo folgorante incontro che sembra proiettarli in una sfera magica e rivelarli predestinati uno all’altra, al tempestivo matrimonio, il lungo viaggio nella natura americana, la mondanità letteraria di Londra e l’arrivo dei figli, la brillante carriera di lui e la lotta incessante di lei contro i propri demoni. Sylvia, l’irresistibile enfant prodige delle lettere americane, acuta, passionale, ma in realtà una bambina con l’anima di vetro che chiede aiuto, piena di incubi e paure, capace di vivere solo di assoluti, ossessionata dalle aspettative nei suoi confronti fino a includere anche la maternità nella sua ansia di successo, vittima di una mitologia personale che le impone il sacrificio sull’altare della poesia, il martirio come destino, liberazione e rinascita. Ted, l’intellettuale europeo affascinato dai reami dell’inconscio, che in lei trova una musa e una compagna di vita, che a lei dà tutto se stesso per cercare di salvarla dal suo lato oscuro, ritrovandosi intrappolato in un legame di mutua dipendenza sempre più viscerale, esigente, predatorio, e scoprendosi incapace di starle accanto.
Estratto
L’OPINIONE DELL’EDITORE
Ted Hughes e Sylvia Plath, la coppia «maledetta» della letteratura moderna, segnata dal suicidio di Sylvia a soli trent’anni nel 1963, ha ispirato ogni sorta di speculazioni e mitizzazioni sulla fragile martire e il suo brutale carnefice. In questo romanzo Connie Palmen dà voce a Ted Hughes e fa raccontare a lui – il poeta, il marito, l’uomo che non può smettere di interrogarsi sulle proprie colpe ma che ha sempre mantenuto un religioso silenzio sulla moglie perduta – la sua verità. Una confessione intima, un incalzante viaggio emotivo che ci risucchia nella spirale di un amore tragico fra due scrittori uniti nel sacro fuoco dell’arte: dal primo folgorante incontro che sembra proiettarli in una sfera magica e rivelarli predestinati uno all’altra, al tempestivo matrimonio, il lungo viaggio nella natura americana, la mondanità letteraria di Londra e l’arrivo dei figli, la brillante carriera di lui e la lotta incessante di lei contro i propri demoni. Sylvia, l’irresistibile enfant prodige delle lettere americane, acuta, passionale, ma in realtà una bambina con l’anima di vetro che chiede aiuto, piena di incubi e paure, capace di vivere solo di assoluti, ossessionata dalle aspettative nei suoi confronti fino a includere anche la maternità nella sua ansia di successo, vittima di una mitologia personale che le impone il sacrificio sull’altare della poesia, il martirio come destino, liberazione e rinascita. Ted, l’intellettuale europeo affascinato dai reami dell’inconscio, che in lei trova una musa e una compagna di vita, che a lei dà tutto se stesso per cercare di salvarla dal suo lato oscuro, ritrovandosi intrappolato in un legame di mutua dipendenza sempre più viscerale, esigente, predatorio, e scoprendosi incapace di starle accanto.
We think we’re writing something to amuse, but we’re actually saying something we desperately need to share. The real mystery is this strange need. Why can’t we just hide it and shut up? Why do we have to blab? Why do human beings need to confess? Maybe if you don’t have that secret confession, you don’t have a poem – don’t even have a story. Don’t have a writer.01
Ted Hughes
01 Da «Ted Hughes, The Art of Poetry No. 71», in The Paris Review, n.134, Spring 1995. (N.d.T.)
Per la maggior parte delle persone esistiamo solo in un libro, la mia sposa e io. Negli ultimi trentacinque anni ho dovuto assistere con impotente ribrezzo a come le nostre vite reali sono state sommerse da un’onda fangosa di racconti apocrifi, false testimonianze, pettegolezzi, invenzioni, leggende; a come le nostre reali, complesse personalità sono state sostituite da stereotipi, ridotte a immagini banali tagliate su misura per un pubblico di lettori affamati di sensazionalismo.
E così lei era la fragile santa e io il brutale traditore.
Ho taciuto.
Fino ad ora.
In lei c’era una sorta di fanatismo religioso, l’aspirazione a una forma superiore di purezza, la sacra e violenta vocazione a immolare la vecchia e falsa se stessa, a ucciderla per poter rinascere, pura, libera e soprattutto vera.
Nei sette anni trascorsi insieme non la vidi mai con nessuno – neanche con i nostri figli – com’era realmente, come io la conoscevo, la donna con la quale vivevo, la donna che scalciando come una giumenta in calore mi aveva morso a sangue la guancia al primo appuntamento.
Non ci eravamo abbracciati, ma saltati addosso.
Sbuffando come un animale – di piacere, di gioia – le strappai dai capelli la fascia rossa, le tirai via dai lobi gli orecchini d’argento, e più di ogni altra cosa avrei voluto stracciarle il vestito, spogliarla di tutti quegli orpelli di decoro, sottomissione e civiltà, di falsità.
È stato crudele, doloroso.
È stato vero.
Ognuno era preda dell’altro.
Neanche quattro mesi dopo l’avevo sposata.
Di una donna che invece di baciarti ti morde avrei dovuto capire che per lei amare qualcuno equivaleva a combatterlo. Di me avrei dovuto capire che rubandole i gioielli avevo strappato solo dei fronzoli, appropriandomene come trofei. Chi inizia così un amore sa che vi si cela un cuore di violenza e distruzione. Finché non sopraggiunge la morte. Uno di noi era spacciato fin dall’inizio.
Era o lei o io.
Nella furia divoratrice chiamata amore, avevo trovato la mia pari.
Io l’amavo, non ho mai smesso di amarla. Se il suicidio era la trappola con cui voleva catturarmi per fagocitarmi, inglobarmi in sé e fare di noi un solo corpo, ci è riuscita. Uno sposo ostaggio della morte, legato in eterno alla sua sposa in un matrimonio postumo, inseparabile come voleva che io fossi per lei.
Il suo nome è il mio nome.
La sua morte è la mia morte.
Io credo all’esistenza del vero sé, e so quanto è raro sentirlo parlare, vederlo liberarsi da quel bozzolo di falsità e insignificanza, le finte apparenze che presentiamo agli altri per incontrare la loro approvazione, per ingannarli. Più il vero sé è pericoloso, più raffinate sono le maschere. Più corrosivo il veleno che vorremmo schizzare sugli altri – per paralizzarli, ucciderli – più è dolce il nettare con cui li attiriamo verso di noi, li spingiamo a starci accanto, ad amarci.
Lei era un’ampolla odorosa piena di veleno.
Non avevo mai incontrato una persona per cui amore e odio fossero tanto vicini, quasi da confonderli. Non desiderava altro che amare qualcuno, ma odiava farlo davvero. Non desiderava altro che essere amata, ma ha punito senza pietà chiunque abbia mai provato amore per lei.
Dietro una facciata di incontenibile allegria si nascondeva una lepre timorosa con l’anima di vetro, una bambina piena di paure, incubi di amputazioni, reclusioni, elettroshock. E io – lo sciamano innamorato – adoravo la fragile bambina ferita, il suo vero sé; volevo fare ciò che l’amore dell’amante esige: infrangere il suo ritratto come un tenero iconoclasta. Poiché l’amavo era mio compito strapparle via quell’involucro di falsità, come donna e come scrittrice, spingendola a far sentire la propria voce. La voce impaurita, la voce rabbiosa, la voce piagnucolosa con cui si lagnava di sciocchezze, la voce smorzata con cui umiliava e minacciava, la voce proibita con cui, come un’erinni furibonda, lanciava maledizioni contro chiunque la ferisse. La sua lingua di pietra doveva poter danzare al ritmo della sua anima, l’anima nera che lei – a ragione – temeva. Toccava a me farla resuscitare da quella morte.
Ciò che allora non capivo è che anch’io nel frattempo mi stavo liberando.
La sua follia è la mia follia.
Già dai tredici anni avevo la testa piena di miti, saghe, racconti popolari, un mondo segreto di conoscenza magica abitato da dèi crudeli che divoravano i propri figli e poderose dee dalle cangianti sembianze di vergine, madre, mostro. Mia sorella aggiunse a tutto questo l’astrologia, i tarocchi, la tavola Ouija. A vent’anni ero in grado di calcolare un oroscopo completo della mia famiglia, degli amici, delle ragazze con le quali potevano condividere il cielo o dalle quali dovevano tenersi il più possibile alla larga. Ogni mattina osservavo la posizione di stelle e pianeti per capire cosa avessero da dirmi.
Se il giorno del nostro incontro avessi ascoltato ciò che gli astri non mi sussurravano bensì urlavano a gran voce, quella sera mi sarei chiuso in camera mia, non sarei andato alla presentazione del primo – nonché ultimo – numero della nostra rivista di poesia e non l’avrei mai conosciuta, o forse solo in un altro momento, quando nelle stelle non era scritto che quel
giorno mi aspettava un incontro disastroso, una collisione esplosiva di energia astrale che mi avrebbe cambiato la vita per sempre.
Sono un indovino scettico, non ci credetti abbastanza.
E andai.
C’era una calca, un frastuono, un fumo come all’inferno. Tra gli esistenzialisti col dolcevita e le pallide donne inglesi, a me fin troppo familiari, apparve come una dea dalle lunghe gambe. All’università la sua fama l’aveva preceduta, sapevo già chi era, l’esuberante americana con varie pubblicazioni a suo nome.
Mi vidi davanti una donna alta e splendidamente raffinata, un’apparizione dalla terra promessa. Appena sfiorata la sua pelle di marmo avrei raggiunto attraverso l’Atlantico la letteratura americana. Con il suo volto di luna e la pelle di seta ramata somigliava a un’attrice di Hollywood. Un sorriso di madreperla, denti bianchi come quelli di uno squalo, che brillavano tra labbra carnose dipinte di rosso sangue, capelli ondulati biondi come raggi di sole, tutto ciò che in lei c’era di selvaggio e impetuoso era costretto in un vestito attillato rosso e nero, i colori dello scorpione. Ballava con il mio migliore amico Lucas, un po’ troppo disinibita, un po’ troppo sfacciata, all’apparenza per metà in trance, ma non lo era, voleva che io assistessi a quel corteggiamento. Nel breve silenzio in cui la musica del mondo tace, la natura trattiene il fiato e raccoglie le forze per un devastante uragano; mosse qualche passo dondolante nella mia direzione – la mia dea ebbra –, due febbricitanti occhi scuri pronti all’accoppiamento.
Le andai incontro, la chiamai per nome.
Dissi: «Sylvia.»
Sorpresa di essere riconosciuta, avrebbe dovuto gridare per sovrastare il jazz infuocato e il vociare eccitato degli uomini, e lo fece, gridò, come Ecate mi abbaiò contro i miei stessi versi, intere strofe di poesie che aveva appena letto nella nostra rivista, esclamò: «L’ho fatto io, io.»
Era circondata da un dolciastro profumo artificiale di gigli e fiori di primavera, ma quando la presi e la portai via dalla pista da ballo sentii il suo vero odore, penetrante come muschio, agrodolce come il sudore di una cerva in calore.
Con l’impronta dei suoi denti sulla guancia me ne andai nella notte come un uomo marchiato a fuoco.
Era il 25 febbraio 1956.
Ero suo.
Il nostro giorno bisestile arrivò non quattro ma ventisette giorni più tardi, quel discutibile dono degli dèi, un’eccedenza di ventiquattr’ore che deve far tornare i conti dell’eternità. Le rimaneva un solo giorno prima di cominciare un viaggio attraverso l’Europa. E lo regalò a me. Fu il venerdì che avrebbe determinato il mio passato, presente e futuro.
Cambridge è un paesino, un focolaio di pettegolezzi e maldicenze. Per vie traverse era venuta a sapere che insieme a Lucas per ben due volte, verso la mezzanotte, ero andato sotto la sua finestra e – ubriachi, cantando forte il suo nome – avevamo lanciato manciate di terra contro i vetri del terzo piano, quelli sbagliati, scoprimmo poi. Fallita questa pantomima da Romeo di campagna, incaricai il mio amico di accompagnarla nella mia stanza a Londra. Lucas, che era originario del Tennessee e provava imbarazzo per quanto riconosceva in lei di tipicamente americano – la sfacciata superficialità, l’affettazione chiassosa e la presunzione invadente – mi supplicò di non fargli fare da intermediario di un amore destinato a fallire, rendendolo complice di tutto ciò che sarebbe accaduto.
Non diedi retta al mio messaggero.
Lui la portò da me, me la consegnò al 18 di Rugby Street, e scomparve.
Sul tavolino c’erano i trofei del primo giorno. Entrò svolazzando come un uccello, flessuosa, eccitata, nervosa, avvolta da una singolare aura color cobalto. Mugolò il mio nome come un sospiro.
Disse: «Ted.»
Vide la fascia per capelli, gli orecchini e – come se pronunciando il mio nome avesse svelato troppo desiderio – aggiunse: «Il predone nero.» Ricoperto da questo epiteto mi sentii il cattivo di una favola, ma pochi minuti dopo capii che in quell’immagine mi catturava in un’autocitazione. Sempre con la fretta del viaggiatore disse che nelle ore successive al nostro incontro aveva scritto per me una poesia. Si sedette, tirò fuori due pagine fitte – intravidi la sua grafia, le rotondità adolescenziali di una ragazzina – e con un accento americano mi presentò l’immagine che aveva di me, un rapace seduttore, una pantera nera che la inseguiva.
«“Un giorno me ne verrà morte.”»
«Spero tu non sia chiaroveggente», scherzai quando ebbe finito e mi guardò di colpo intimorita.
«Oh, certo che lo sono», rispose lei serissima.
Centinaia di volte avrei visto confermata questa affermazione, la sua inquietante capacità di leggere i pensieri altrui, di prevedere gli eventi, di fiutare il pericolo, di sapere a chilometri di distanza cosa stessi facendo, pensando, vivendo. Poiché avevo ereditato le stesse doti da mia madre, non mi feci spaventare da quel talento. Mi dava la sensazione di essere di nuovo guidato da un angelo custode, in contatto spontaneo con gli assenti.
Seduti uno di fronte all’altra, parlando, ascoltando, scoprimmo tutta una serie di affinità sorprendenti, la passione condivisa per Yeats, Blake, Lawrence, Dostoevskij. Si era laureata con lode discutendo una tesi sul tema del doppio nell’opera dello scrittore, e parlava rapita del demoniaco io-ombra, la parte oscura di noi, la nostra rovina, la nostra morte. E che al momento si occupava di Racine, della passione fatale in Fedra, che ovviamente era anche l’opera continentale che più amavo. Prima di rendercene conto iniziammo a scambiarci battute citando i nostri alessandrini preferiti, lei nel ruolo di Fedra la folle suicida, io in quello di Ippolito ingiustamente accusato – presagio già allora di una funesta assegnazione di ruoli. Ridendo raccontò che tre settimane prima il suo mentore e docente prediletto a Cambridge le aveva riconsegnato un saggio su Fedra. A margine vi aveva apposto una nota in cui rilevava la visione un po’ troppo limitata della sua studentessa sulla passione fatale in quella tragedia, tutto sommato Racine non ne aveva fatto l’ecatombe che lei vi vedeva.
Poiché sapevo che noi poeti siamo attratti dai territori che un altro poeta ha occupato e marcato con il proprio odore, le dissi che in quel momento si trovava dove una volta era stato seduto anche Dylan Thomas, a ubriacarsi col padre del mio amico Daniel. Lei si alzò, s’inginocchiò, baciò il pavimento di legno. E io, che così a lungo ero stato nemico dell’amore, in quelle ventiquattr’ore che mi regalò fui conquistato sempre di più, fui conquistato da lei, da quella bellezza mobile, impossibile da fissare, dal suo accento del Massachusetts, dal mio doppio. Dopo l’inchino davanti al bardo, quando si alzò per rientrare in albergo, la strinsi a me, la sollevai, la feci volteggiare, la baciai, sentii il fremito della sua forte eccitazione, inspirai profondamente il suo odore di muschio.
«Resta», dissi.
«Vieni con me», rispose.
Andai con lei. Era impensabile che insieme – senza essere sposati – potessimo entrare nella sua stanza d’albergo e allora passeggiammo lentamente, abbracciati, per le strade di Londra, fermandoci a ogni albero e cespuglio a baciarci, parlare, frugarci addosso.
Mi accarezzava continuamente il marchio sulla guancia con cui mi aveva fatto suo, sussurrava: «L’ho fatto io, io.» Spiritosa, euforica, mossa dall’impellente bisogno di rivelarsi, raccontò di quando ventisette giorni prima era uscita nella notte senza di me, barcollando al braccio del suo accompagnatore, con l’aiuto del quale si era arrampicata sulla cancellata a punte che circondava il campus. Quei chiodi rovesciati le avevano lacerato le mani.
«Sei stato la mia crocifissione», disse – radiosa, sorridente – mostrandomi i palmi aperti, «ma le mie stimmate non sanguinavano.»
Nel breve tempo in cui l’avevo vissuta come un tempestoso miracolo, avrei dovuto immaginare il ruolo che mi era stato assegnato nella drammatica narrativa della sua esistenza, ma il preludio di quell’opera aveva un ritmo che non riuscivo a tenere, i suoi occhi mi immobilizzavano come un coniglio catturato da un fascio di luce, la sua voce mi rendeva sordo al clamore dei cembali e al pianto delle stelle. Ciò che più m’incantava erano le sue doti alchemiche di fondere fatti di piombo e forgiarli come lava dorata in una storia di martirio. Tirò in ballo il Cocktail Party di T.S. Eliot, dicendo che in cima a quei puntali si era sentita la crocefissa Celia Coplestone che «aveva scelto un modo di vivere che doveva condurla alla morte».
Fin da bambino leggo il mondo come un libro pieno di segreti, di segni eloquenti, e ogni particolare di quella sera lo interpreto come il presagio di un legame celeste tra un uomo e una donna che vivono per poter scrivere. Lei è una poetessa, è bella e spiritosa, colta e sensuale, talentuosa e cupa, è geniale e pericolosa.
Io ascoltavo, sorridevo, la incoraggiavo – non aver paura, raccontami tutto. Lei mi guardava da sotto in su, solo un paio di centimetri, alta quasi quanto me. Le scostai dal viso la folta frangia bionda e improvvisamente scoprii la punteggiatura della sua genesi, le virgolette sulle tempie che ancora ignoravo corrispondessero al punto esclamativo sotto l’occhio destro. Ora che avevo leccato via lo strato di trucco, vidi il luccichio color seppia della cicatrice al chiarore del lampione. Per un attimo sembrò spiazzata, intimidita, ma l’alcol, re dell’indifferenza, ebbe la meglio.
«Due anni e mezzo fa mi sono suicidata», disse allegra, «ed eccomi qui, praticamente come nuova.»
Avrei potuto congedarmi lì, fuggire da questa storia, dal suo autore, dal leitmotiv del mio personaggio, dare ascolto alla voce che mi metteva in guardia dalle inevitabili conseguenze, indotte dalla logica dell’intrigo, e invece venni risucchiato ancora più a fondo, attirato dal pericolo, irresistibilmente sedotto dal canto delle sirene.
Arrivati sulla porta dell’albergo non potei assolutamente lasciarla andare. Era impensabile che trascorressimo la notte separati, eravamo legati in un abbraccio indissolubile, e in quel modo, incollato a lei, chino e coperto dal suo impermeabile, mi fece entrare di nascosto sotto il naso di un portiere sonnecchiante, ridendo nervosa come un’adolescente troppo cresciuta.
Facemmo l’amore come titani, a morsi, con voracità. Impaziente cercavo le delizie di quel suo corpo splendido, liscio, agile, sinuoso come un serpente, …
L’AUTORE
Nome di spicco del panorama letterario olandese contemporaneo, Connie Palmen è nota soprattutto per il suo romanzo d’esordio, Le leggi (Feltrinelli 1993), con cui si è subito imposta all’attenzione di pubblico e critica, in patria e all’estero. I suoi libri traggono spesso ispirazione da fatti e persone reali e indagano con fine sensibilità il rapporto tra identità individuale e mondo esterno, tra la verità sempre sfuggente e il peso che hanno lo sguardo e le parole di chi la interpreta. Con Tu l’hai detto ha vinto nel 2016 il Premio Libris, il più prestigioso riconoscimento letterario olandese.