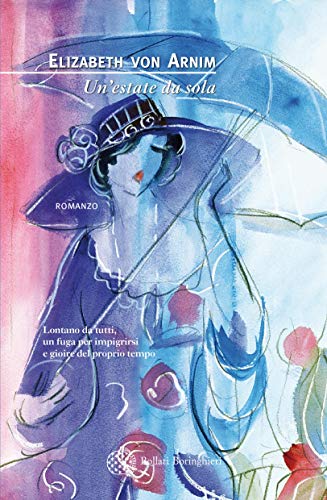Trama
Teresa custodisce da sempre un segreto di cui è ormai l’unica depositaria. È vecchia, ostinata, e quando intuisce che la sua mente e la sua memoria si sono fatte labili, decide di non mettere a repentaglio ciò che ha tenuto nascosto per una vita intera. Così una sera si sdraia nel letto e non si alza più: per dieci anni, “zitta e immobile, fissava quello che gli altri chiamavano vuoto e che lei aveva imparato a interpretare”.
La sua famiglia però, ostinata, porta il letto al centro del salotto e dell’esuberante vita della casa, che è tutta al femminile: oltre a Teresa, ci sono le figlie, Irene e Flora, la cugina Rusì, la badante peruviana Pilar e Nina, la nipote. È lei a raccontare la loro storia, che inizia nel momento in cui la nonna si sta spegnendo e le cinque donne le si stringono intorno per vegliarla. Prima di andarsene, Teresa regala loro quattro oracoli – uno portato dal vento (come quello che indicò a Ulisse la via del ritorno), uno scritto sulla sua pelle (come la tradizione tramanda sia avvenuto a Epimenide), uno fatto di nebbia e di poesia (come al cospetto della Pizia di Delfi), uno che diventa fulmine (secondo la tradizione della Sibilla Eritrea)… Sono oracoli che sciolgono il nodo che blocca le loro esistenze, liberandole dalle paure, dal senso di colpa, dal passato, dall’incapacità di affacciarsi sul proprio futuro. E, liberando le loro esistenze, Teresa libera finalmente se stessa.
Soltanto un’antropologa come Arianna Cecconi, che studia i sogni notturni e le pratiche rituali, poteva raccontare questa storia di cose invisibili e oracoli casalinghi, con la sua scrittura e il suo immaginario al contempo realistici e magici.
Estratto
Fermati e ascolta
La saggezza oracolare della Sibilla Cumana è nata dall’amore e dalla fretta, dai desideri e dall’incapacità di vedere oltre.
Quando era ancora donna, Apollo se ne innamorò perdutamente e lei accettò il suo amore in cambio di una vita lunga tanti anni quanti i granelli della sabbia che teneva tra le mani. Ma per la fretta si scordò di chiedere, insieme all’immortalità, l’eterna giovinezza e così diventò vecchissima, rinsecchita e minuscola. Il suo corpo si raggrinzì come quello di una cicala, al punto che fu depositata in un vaso da cui si sentiva solo la sua voce sussurrante profezie, che terminavano sempre con le parole “voglio morire”.
Non so se la Sibilla Cumana invidiasse Cassandra – anche lei Sibilla, anche lei toccata dall’amore di Apollo e condannata, per non averlo ricambiato, a non essere mai creduta, le sue parole troppo vicine alla verità per essere ascoltate.
Non so quando Apollo posò gli occhi su mia nonna Teresa.
Questa è una storia di cose invisibili, di profezie e oracoli casalinghi, di libertà e del caso, della difficoltà di decidere, di scegliere, di amare, di crescere e di morire. È una storia di famiglia, una storia di silenzi, di segni e della difficoltà di interpretarli.
Prima di leggerla, sono necessari alcuni piccoli accorgimenti, una sorta di tributo all’imperscrutabile e un gesto di rispetto verso l’intimità delle cose che ancora non si vedono ma che tra poco si vedranno, verso coloro che qui sveleranno la propria storia e i propri segreti. Un esercizio di attenzione per evitare la sorte della Sibilla Cumana.
Innanzitutto è necessario sedersi davanti a una finestra e sfilarsi le scarpe. Sentire bene la terra sotto i piedi e chiudere gli occhi. E poi provare a rispondere a questa domanda. Come scegli ciò che scegli?
Non so se vi racconto tutto questo per prendere tempo o per l’incidente appena accaduto in cucina. Stavo tagliando un pezzo di formaggio, la crosta era dura e la lama del coltello è scivolata nel centro del palmo della mia mano. Stavo pensando a Teresa, o almeno credo. Ora sono costretta a scrivere molto più lentamente e provo dolore ogni volta che con la sinistra schiaccio i tasti della f,e,r,m,a,t,i,a,s,c,o,l,t,a. Le cose invisibili e i segreti non perdonano mai la distrazione e la fretta.
Non si può ascoltarli facendo altro.
Teresa non aveva mai creduto a coloro che pretendono di leggere nei solchi della tua carne un destino già scritto. Come chi viaggi tutta la vita in paesi sconosciuti perdendosi e chiedendo indicazioni, per poi accorgersi di avere la mappa disegnata sulla mano. Lei le mani le aveva usate sempre per lavorare, lavarsi, mangiare, per fare una carezza, e non credeva che avrebbe mai scoperto di potervi leggere dell’altro. Ma se il destino non esisteva, su che cosa fosse la libertà mia nonna voleva spiegazioni.
Siamo liberi di determinare la nostra vita, dicono alcuni, ma Teresa si era accorta presto di avere un viso e un corpo che erano quelli lì e non li aveva scelti, così come non aveva scelto la famiglia che l’aveva messa al mondo – un padre contadino, duro come il muro che si era costruito intorno, e una madre morta troppo presto perché lei potesse ricordarsene.
Era cresciuta nella cascina Benvenuta tra sei fratelli ingombranti, con la nebbia tra settembre e marzo a nascondere i contorni delle cose; aveva sposato Antonio abbassando la testa, e le sue due figlie, mia madre Irene e mia zia Flora, erano arrivate senza che se l’aspettasse.
Per alcuni il panorama delle scelte è così vasto da far venire le vertigini e per altri la bussola delle possibilità è grande come un sassolino, lo puoi mettere sotto il guanciale e dormirci sopra, che tanto domani sarà uguale a oggi.
No, nella vita di Teresa non sembrava esistere neanche la libertà. Eppure né lei né nessuno della nostra famiglia seppe mai se fu libertà o destino a darle quella forma di felicità che appariva a tratti come un fremito di luce nello sguardo, un gorgoglio che le riempiva la risata.
Teresa custodiva un segreto che portava sempre con sé.
Ci sono i tesori di famiglia che passano di mano conservando luccicori e speranze, ci sono gli scheletri di famiglia che stanno nascosti negli armadi, ci sono gli odori di famiglia, i primi a essere riconosciuti e gli ultimi che si scordano, e poi ci sono i segreti di famiglia.
A volte tutti li conoscono. A volte è uno soltanto che li custodisce dentro la bocca. Teresa il suo lo aveva tenuto per tanti anni stretto tra i denti, anche quando quelli erano caduti e li aveva rimpiazzati con una dentiera di smalto e oro per non correre il rischio di farselo scappare. Ma quando si era accorta che la vecchiaia avrebbe potuto scioglierle le labbra, Teresa aveva deciso di smettere di parlare.
La memoria di mia nonna aveva cominciato a bucarsi come un colino. Qualcuno dentro la sua testa si divertiva a cancellare i volti dalla foto di famiglia, lei non li trovava più e all’inizio cercava di recuperarli. Tornavano a riaffiorare e poi svanivano di nuovo.
Il primo a scomparire fu nonno Antonio, e poi tutte noi, una dopo l’altra. Teresa ripescava da qualche parte dei nomi: Nina, Flora, Irene, Rusì, Pilar. Ma erano nomi senza volto.
Anche gli oggetti della casa perdevano via via la loro storia per trovare nuove collocazioni: la guida del telefono sotto al cuscino, tra le posate gomitoli di lana, nel forno una spazzola rotta, il frigorifero una scarpiera.
Allora le mettevamo delle molliche di realtà nelle tasche del vestito o dentro alla borsetta: l’indirizzo e il numero di telefono di casa, la sua carta d’identità. Una volta ci aveva chiamato la cassiera del supermercato che aveva trovato Teresa con tre vasetti di miele in mano, non sapeva come pagare né dove portarli.
Mentre la memoria della nonna si sbriciolava, erano arrivate le parole aggressive, le parole maleducate che non si addicono a una nonna dagli occhi azzurri. Parolacce che uscivano all’improvviso – “bagascia”, “cornuta” – e a pranzo, sedute attorno al tavolo della casa del fico, ci guardavamo, a volte trattenendo le risate, altre con lo sguardo fisso nel piatto. Le pensava veramente? Chi stava diventando, Teresa? La nonna sembrava posseduta da una divinità furiosa e arrabbiata.
Poi erano arrivate le parole senza senso, filastrocche e cantilene ripescate da chissà quale ripostiglio della memoria. Parole che resuscitavano ricordi bambini, dove il presente aveva la forma del passato, i vecchi ritornavano giovani, i figli diventavano pesci, il mondo era di nuovo popolato dagli amici d’infanzia e dagli strampalati abitanti della cascina. I morti tornavano in vita.
Infine anche il fiume di filastrocche si era prosciugato. La lingua della nonna si era crepata come un geroglifico e il suo aspetto si era adattato alla metrica di quel nuovo silenzio. Teresa aveva assunto le sembianze di un’antica statua scolpita nella pietra. Gli zigomi perfetti, il mento triangolare, gli occhi azzurri di ghiaccio.
Aveva smesso di parlare di colpo, un pomeriggio mentre sbucciavamo i fagiolini sedute in cucina. Mi aveva detto: “E tu chi sei?”.
“Nonna, sono Nina, tua nipote.”
Aveva chiuso gli occhi per cercare dentro di sé il significato della parola nipote. Ma non l’aveva trovato.
“Un cafficchio anche a micchio non ce ’n occhio.” I suoi ritornelli se li ricordava di più della mia faccia.
Poi i suoi occhi erano diventati umidi, proprio come i miei. Aveva guardato fuori dalla finestra, facendo finta di niente.
Quella sera si era sdraiata nel letto una volta per tutte e il corpo aveva smesso di muoversi. Non si era mai più alzata: zitta e immobile, fissava quello che gli altri chiamavano vuoto e che lei invece aveva imparato a interpretare.
Avevamo portato il suo letto al centro del salotto, dove c’era sempre qualcuna di noi a posare uno sguardo, stendere una coperta, pettinarle i capelli e riavvolgerle lo chignon. Il salotto era luminoso, con i soffitti alti e una finestra che dava sul giardino: eravamo riuscite a incastrare il letto fra le due poltrone blu, la madia di legno, il mobile con sopra il televisore e il grande tavolo ovale.
Ci eravamo abituate presto a quella presenza, tanto che ci sarebbe stato ormai impossibile immaginare il salotto senza quel letto. Non era lo stesso in cui dormiva con nonno Antonio –
quello, in legno d’ulivo, era rimasto al piano di sopra. Il dottore aveva consigliato un letto speciale, un modello che potesse alzarsi e abbassarsi con i pulsanti.
Pilar fu la prima ad appendere una conchiglia alle sbarre in metallo, dietro alla testa di Teresa. Una grande conchiglia bianca e marrone con striature rosa, che veniva dalla foresta di Puerto Maldonado, nell’Amazzonia peruviana. “È per la buena suerte,” mi aveva spiegato. “Viene data ai caciatori prima di partire per la foresta.”
Dopo qualche giorno, accanto alla conchiglia dell’Amazzonia, Rusì appese con un filo di cotone una statuina di Padre Pio. La conchiglia e Padre Pio penzolavano insieme e ogni tanto il gatto faceva agguati all’una e all’altro, lasciando graffi sul collo del frate. Qualche settimana dopo si aggiunse una boccettina di un liquido verdastro, il giorno successivo la boccetta era sorvegliata dallo sguardo di santa Lucia e via così finché negli anni il letto della nonna si tramutò in un albero di Natale fuori stagione, un santuario di tutte le divinità. Pezzettini di corteccia, semi rossi e neri, l’immagine di san Martino, un calzino di bimbo, la foto delle stigmate, ampolle d’acqua di luoghi santi, Gesù crocefisso ai piedi del letto che sfiorava un piccolo lama di stoffa. Un mattino era apparso anche un ovetto bianco: un baco da seta, come quelli che si allevavano alla Benvenuta quando la nonna era giovane. Nessuna ammise mai di averlo portato.
Poco alla volta smettemmo di lottare, abbandonando le cure al fosforo e i rituali che davano piacere – ripescare i suoi ricordi, leggere per lei ad alta voce, pettinarle a lungo i capelli. Salvare la memoria della nonna aveva perso sempre più il fascino dell’impresa, e in cambio ci eravamo abituate ai nuovi equilibri.
Capitava allora che appoggiassimo sul letto di Teresa una pila di asciugamani, un libro, la grande zuppiera di ceramica a fiori. Restavano lì anche tutta la giornata senza che ce ne accorgessimo. Il letto era diventato uno dei tanti mobili del salotto e Remigio nascondeva sotto il lenzuolo i suoi trofei: una lucertola senza coda, una farfalla gialla, le piume delle galline. Un pomeriggio ero salita in camera a fare una telefonata, lasciando il giornale ai piedi della nonna. C’erano le finestre aperte e il vento aveva sparpagliato tutte le pagine sul letto. Scendendo, avevo ritrovato la nonna ricoperta dalla “Repubblica”. Sul suo volto una grande foto del gol del Milan nel derby.
Ci si abitua a tutto. Al silenzio, al disordine, all’amore o alla solitudine. Noi ci eravamo abituate a una nonna senza memoria, che c’era ancora e non c’era più. Sedute a tavola, parlavamo tra noi dimenticandoci che lei era lì dietro, sdraiata, in ascolto.
Per dieci anni se ne è rimasta distesa, con gli occhi chiusi. Quando li apriva, guardava il soffitto. Mia nonna vedeva gli spiriti.
Se oggi ti penso, Teresa, e ti penso spesso, la prima immagine che ho di te è di notte.
Vecchia, bianca nel volto e nei capelli come la collanina di perle che avevi sempre al collo, a pancia in su nel letto in mezzo alla sala da pranzo. Mezza viva mezza morta, mezza nonna mezza spirito tu stessa, li vedevi camminare sospesi nell’aria, arrampicarsi sulle pareti, aggrovigliarsi al lampadario. Davanti a te il confine fra la vita e la morte si spostava con il vento. Ma non dicevi nulla, omertosa, e noi di nulla ci accorgevamo. Osservavi con i tuoi occhi di ghiaccio il tempo passare e le nostre vite che avrebbero voluto cambiare e che invece non cambiavano mai. La casa del fico era il nostro carillon, giravamo su noi stesse, senza mai smettere ma restando ferme.
Prima che tu diventassi un oracolo, nessuno aveva insegnato alle donne della mia famiglia come scegliere, così avevamo trovato da sole il modo per farlo:
Rusì, tua cugina, seguiva i precetti del cristianesimo.
Irene, la primogenita, ascoltava i sogni.
Flora, la tua seconda figlia, cercava nei libri, anche se era un serpente argentato a guidarla.
Pilar, che era arrivata per prendersi cura di te, lasciava andare le cose per il loro verso, sapendo che era così la vita nella terra da cui proveniva: il Perù.
Io, tua nipote Nina, non sceglievo, facevo scegliere al caso.
Ci portiamo addosso il passato come le balene che nel grasso della pancia conservano le ossa di quando camminavano. Mentre nuotano, enormi balene, i pesci le guardano senza sospettare che quei grandi animali al loro fianco un tempo respiravano aria e camminavano sulla terra. Forse neanche le balene lo ricordano, ma lo sanno dentro. Lo sa il loro corpo e quel segreto lo custodiscono nella pancia, sedimentato nel grasso di quella nuova vita.
Anche Teresa si portava addosso il suo segreto. E, se le balene non dormono mai e nuotano per tutta la vita, Teresa a un certo punto aveva scelto il letargo. Si era sdraiata nel letto e non si era più alzata.
Ma il letargo, si sa, è proprio del grasso che si alimenta, è grazie all’eccesso della propria carne che si può dormire dei mesi, delle stagioni, degli anni interi. Anche la nonna, come gli animali, si era addormentata nutrendosi di sé stessa. Tutto si riduce all’essenza, cuore non battere forte che se no mi svegli.
Gli esseri umani sperimentano in genere piccoli letarghi, che durano una notte – o un viaggio. Teresa per diventare un oracolo era entrata in un sonno lunghissimo, durato dieci anni.
Ora che tutto il grasso si era consumato, che era diventata pelle e ossa, il suo potere e il suo segreto non potevano che uscire allo scoperto.

Jenny