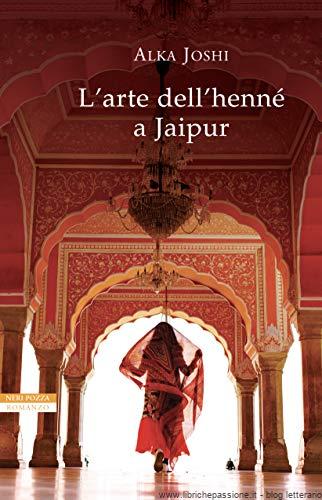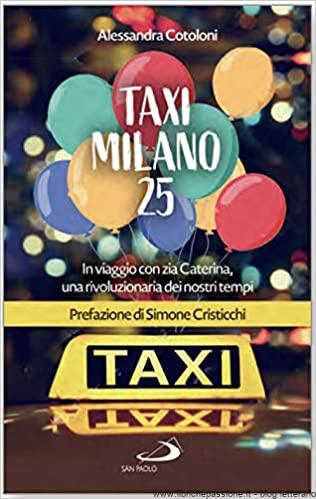Trama
«Angela Marsons è la nuova regina del giallo.» Antonio D’Orrico
Quando, durante uno scavo archeologico, vengono rinvenute alcune ossa umane, uno sperduto campo della black country si trasforma improvvisamente nella complessa scena di un crimine per la detective Kim Stone. Non appena le ossa vengono esaminate diventa chiaro che i resti appartengono a più di una vittima. E testimoniano un orrore inimmaginabile: ci sono tracce di fori di proiettile e persino di tagliole da caccia. Costretta a lavorare fianco a fianco con il detective Travis, con il quale condivide un passato che preferirebbe dimenticare, Kim comincia a investigare sulle famiglie proprietarie e affittuarie dei terreni del ritrovamento. E così, mentre si immerge in una delle indagini più complicate mai condotte, la sua squadra deve fare i conti con un’ondata di odio e violenza improvvisa. Kim intende scoprire la verità, ma quando la vita di una sua agente viene messa a rischio, dovrà capire come chiudere al più presto il caso, prima che sia troppo tardi.
Una serie da oltre 3 milioni di copie
Pubblicata in 26 lingue
Numero 1 in Italia e Inghilterra
La verità è stata sepolta a lungo. Fino a ora.
Hanno scritto di lei:
«Angela Marsons è proprio brava. L’avevo candidata al trono di Regina del giallo lasciato vacante da Patricia Cornwell e riconfermo la nomination.»
Antonio D’Orrico
«Kim Stone è una detective che dovete assolutamente conoscere.»
D La Repubblica
«Angela Marsons è paragonabile al campione americano del thriller James Patterson.»
Il Corriere della Sera
«Un giallo superbo. Trama e scrittura sono semplici e afferrano il lettore come vuole la tradizione britannica. Solo che stavolta, al posto della campagna inglese, c’è la cruda realtà delle periferie. L’adrenalina è sino alla fine, per oltre 300 pagine. E non è facile, di solito.»
Il Fatto Quotidiano
Estratto
Questo libro è dedicato alla mia compagna, Julie Forrest
che ogni giorno mi tiene per mano.
E prima o poi capirai quanto sei preziosa per me.
Prologo
Justin abbassò lo sguardo sulla lama sospesa sopra il polso. Il coltello apparteneva alla madre; ma la mano che tremava era la sua.
Per un secondo fu sopraffatto dagli aspetti pratici del gesto che aveva deciso di compiere. Aveva scelto il coltello giusto? Ce n’erano così tanti. Nel cassetto delle posate. Nel ceppo di legno. Più un set di coltelli in argento, ancora conservati nella confezione decorata.
Il coltello che stringeva in quel momento non era stata la sua prima scelta. All’inizio aveva optato per il più grande e minaccioso tra quelli contenuti nel cassetto. Con la lama seghettata. Una fila di denti aguzzi, come le creste di una catena montuosa.
Il manico gli aveva dato una bella sensazione, ma l’idea di quelle zanne che gli laceravano la pelle l’aveva fatto desistere. Era buffo: pur essendo sul punto di togliersi la vita, aveva paura del dolore.
L’aveva rimesso nel cassetto per prenderne un altro. Lungo ed elegante, con il manico più spesso, più consistente. L’aveva visto tante volte in mano a sua madre, che lo usava per affettare l’arrosto della domenica.
Si sentì trapassare da una fitta di tristezza, mista a rammarico.
Ricordò come, la domenica, sedeva sempre accanto alla sua sorellina, aspettando con ansia il pasto più atteso della settimana. La madre metteva in tavola ogni piatto con grande attenzione, quasi fosse una cerimonia. Con un’espressione orgogliosa. Justin sentì un nodo alla gola quando realizzò che sua madre non avrebbe più provato orgoglio pensando a lui.
Restò con il coltello sospeso a mezz’aria mentre si chiedeva se c’era un modo per tornare a quei giorni: ai primi anni dell’adolescenza, quando gli bastava sentirsi parte della famiglia. Le gite, le vacanze al mare, la rosticceria e i film la sera.
Provò a deglutire, a fatica.
Ormai non era più quel ragazzo. Non lo era da cinque anni. La rabbia che giaceva sopita in lui era divampata come un incendio.
Sapeva cosa doveva fare.
Gli si piantò nella mente il volto di sua madre. L’angoscia che provava era una sensazione quasi fisica.
Lanciò uno strillo quando passò la lama lungo il polso.
Tracciò un graffio che andava a incrociare alcuni dei patetici tentativi fatti in precedenza: questa volta almeno fu ricompensato da una bollicina di sangue all’estremità di una riga sottile come un filo di cotone. Era pur sempre un passo avanti.
Il volto della madre campeggiava ancora nella sua mente; un volto animato da comprensione e perdono. La stessa espressione che gli aveva rivolto quando era stato sospeso a scuola per aver preso a pugni un ragazzo, durante la ricreazione. O quando aveva rubato la bici di un amico e aveva rotto la ruota anteriore. Quelli erano stati errori, e lei l’aveva perdonato.
Ma questa volta era tutto diverso.
Mai prima di quel momento, in diciotto anni di vita, aveva provato il desiderio di portare indietro le lancette dell’orologio. Da un paio di giorni non pensava ad altro, ora dopo ora. Ma non era per sé che provava rammarico. Non si sarebbe mai sposato. Non avrebbe mai portato una ragazza a casa per farle conoscere sua madre. Non avrebbe mai avuto figli. Eppure, era per sua madre che provava dispiacere. Stava per toglierle ogni speranza di avere un nipote.
Nella mente, il volto di lei cambiò, divenne perplesso, confuso, quasi titubante.
E Justin si sentì dilaniare dal dolore di sua madre.
Perché lei avrebbe dubitato di sé stessa. Si sarebbe chiesta dove aveva sbagliato, se non fosse tutta colpa sua.
E, al pensiero, Justin sentì le lacrime che gli bruciavano gli occhi.
«È tutto sbagliato», sussurrò, cominciando a scuotere il capo.
Non sopportava l’idea che sua madre potesse prendersela con sé stessa. Non era affatto colpa sua. Aveva fatto tutto da solo.
Lasciò andare il coltello e rovistò nel primo cassetto del comodino, per tirarne fuori un taccuino e una penna.
Sapeva di non avere alternative. Lo sapeva da due giorni. Ma la madre non doveva passare il resto della vita nella vergogna a causa delle sue scelte. Justin non si sarebbe mai perdonato per ciò che aveva fatto e, per quanto potesse provarci, neanche lei ci sarebbe riuscita.
Si fermò al ricordo del volto impotente e terrorizzato che lo guardava, pieno di confusione, in cerca di un motivo, di una ragione per quello che lui stava facendo. Era una domanda alla quale, all’improvviso, non era in grado di rispondere, una domanda che lo nauseava nel profondo. E quegli occhi, oddio, quegli occhi, pieni di paura, avevano smascherato la vergogna nel suo cuore. Solo in quel momento aveva davvero capito cos’era diventato. L’oscurità della sua stessa anima gli aveva tolto il respiro. Si era trasformato in un mostro.
E non sarebbe finita con lui. In realtà, era solo l’inizio. Sarebbero arrivati l’odio e la morte, e Justin era troppo vigliacco per fermarli.
Mise il messaggio per la madre sul cuscino e riprese il coltello.
Con impugnatura ferrea e mano salda, si concentrò sulla vena del polso.
Squarciò la pelle con la lama.
Questa volta, faceva sul serio.
1
«Bryant, svolta a sinistra», esclamò Kim quando udì le sirene in lontananza.
Con un grande stridore di freni, l’auto affrontò la curva in derapata ed entrò in una zona industriale.
«Ma non stavamo tornando a casa?», borbottò l’agente.
Kim ignorò il collega e fece saettare lo sguardo a sinistra, in avanti, a destra e poi indietro, attenta a cogliere un eventuale guizzo tra gli edifici bui.
«Capo, lo sai, vero, che ci sono anche altri poliziotti a West Mid…».
«Siamo a meno di un chilometro da una rapina a mano armata con dei feriti, e tu pensi solo al pasticcio di carne con il purè?», lo interruppe brusca lei. D’altro canto, era colpa di Bryant se aveva lasciato la radio accesa.
«Hai ragione», ammise il sergente. L’idea della cena contava ben poco al cospetto di un innocente che stava perdendo litri di sangue per una coltellata allo stomaco.
«Scommetto che è qui, da qualche parte», disse Kim socchiudendo gli occhi per scrutare nell’oscurità.
In base alla descrizione, sospettava che l’uomo che stavano cercando fosse Paul Chater, prolifico taccheggiatore diciannovenne che lei stessa aveva più volte portato in centrale sin da quando di anni ne aveva undici.
Il ragazzo era stato bandito da tutti i centri commerciali e i negozi del centro, uniti in una rete di informazioni all’interno della quale la sua foto aveva ottenuto più visualizzazioni del video porno di una star dei reality show.
«Perché mai si sarebbe spinto fin qui?», chiese Bryant.
«Perché è come un paesino», rispose lei. «In questo posto ci sono più di duecento edifici e quasi cinque chilometri di strada».
Si trovavano a meno di trecento metri dal negozio, e il giovane guidava un motorino tutto scassato con la marmitta ormai inservibile. Di sicuro avrebbe fatto in modo di allontanarsi quanto più in fretta possibile dalle vie principali.
«Potremmo girare entrambi per un’ora senza incontrarci», aggiunse Kim.
«Quindi sa anche che lo cercheremo qui?», domandò il collega.
«Non a bordo di una Astra Estate», gli rispose. «Farà più attenzione a quelle maledette sirene».
Da qualche anno, Paul Chater limitava l’esercizio della sua professione ai piccoli negozi, con poche telecamere a circuito chiuso o nessuna. E le frequenti sortite in carcere erano per lui un rischio del mestiere, nonché un meritato riposo; ma l’uso del coltello rappresentava un’escalation.
Kim abbassò il finestrino nella speranza di cogliere il ronzio della motoretta, ma gli ululati delle sirene sempre più vicine non aiutavano.
«Capo, non lo trovere…».
«Eccolo», esclamò lei puntando il dito oltre il parabrezza.
Bryant pigiò l’acceleratore.
«No, non lo inseguire», lo ammonì Kim. «Sta cercando un posto dove nascondersi. Se lascia il motorino e scappa a piedi, non lo beccheremo mai».
Si sforzò di pensare in fretta. «Arriva in fondo alla strada, gira a destra e poi a sinistra».
Se Chater aveva un minimo di buon senso, si sarebbe diretto verso l’estremità occidentale di quella zona, che finiva a ridosso di un argine ripido dal quale si accedeva all’alzaia del canale, ma per arrivarci doveva prima percorrere circa ottocento metri di rettilineo.
Quando attraversarono il parcheggio di una ferramenta per piombare in strada, Chater entrò nella loro visuale: era diretto proprio dove aveva previsto lei.
«Raggiungilo», ordinò Kim.
Bryant schiacciò l’acceleratore.
Chater si guardò alle spalle.
«Più veloce», esortò lei.
Il suono delle sirene le comunicò che le autopattuglie erano arrivate nel quartiere, ma sapeva che ormai non potevano raggiungerlo.
«Vagli accanto», disse, mentre abbassava il finestrino.
Mancavano duecento metri all’argine.
«Capo, cosa stai…».
«Accosta», gridò Kim quando si trovò in parallelo con Chater. «Accosta», ripeté, faccia a faccia col giovane stupito.
Centocinquanta metri.
«Capo, non fare nulla di…».
«Ferma questa cazzo di carretta», strillò lei.
Tra cento metri, il ragazzo avrebbe gettato via il motorino per scappare a piedi.
Il vecchio trabiccolo proseguì a scatti.
«Portami più vicino», disse Kim, col fiato corto.
«Non vorrai mica…».
«Bryant, gliel’ho già chiesto con le buone», lo interruppe lei, girandosi a guardarlo.
Cinquanta metri, e ormai erano all’altezza del suo avambraccio sinistro.
Kim esitò solo per un istante, poi ripensò al messaggio radio sul signor Singh che continuava a perdere sangue nel suo negozio.
Venticinque metri.
Afferrò la maniglia e aprì la portiera, colpendo piano una coscia del giovane.
Bryant frenò e il motorino cadde a sinistra, lontano dalla loro auto.
Kim spalancò la portiera e corse fuori. Chater si alzò e partì a tutta velocità verso l’argine.
Il suono delle sirene proveniva ormai da ogni direzione quando lei coprì i tre metri che la separavano dal ragazzo.
Saltò in avanti mentre lui stava per arrivare in cima al rialzo.
«Beccato», esclamò atterrandogli addosso. La cerniera della giacca da motociclista le premette contro il ventre e, allo stesso tempo, affondò nella schiena di Chater.
Lui, con un gemito, provò a scrollarsela di dosso.
Kim lo rigirò e lo guardò in faccia, oltre la visiera del casco.
«E va bene, stronzetto», fece e gli si mise a cavalcioni sullo stomaco. «Che hai combinato questa volta?»
«Levati di dosso, stronza», rispose lui, dimenando il bacino come Ricky Martin.
Kim gli serrò le cosce contro le costole. «Dov’è il coltello, Paul?»
«Non c’era nessun coltello», protestò Chater.
La bocca fu rapida a formulare la risposta, ma gli occhi smentivano le parole.
«Dov’è, Paul?», chiese lei, stringendogli un polso.
«Te l’ho detto, non c’era nessun cazzo di coltello», gridò il giovane, ora che era riuscito a farsi coraggio. «Volevo solo qualche sigaretta, hai capito?».
Kim si sentì pervadere dalla rabbia al pensiero di un uomo innocente che stava morendo dissanguato nel suo negozio. La vita appesa a un filo, perché quel coglioncello non voleva pagarsi le cicche.
«Allora trovati un lavoro e compratele», gli rispose, stringendo ancor più la presa mentre un’autopattuglia parcheggiava di sghembo sul marciapiede.
Guardò il suo collega, ora fermo in piedi accanto alla loro vettura, con le braccia conserte. «Sai, Bryant, li odio davvero quelli convinti che gli sia tutto dovuto».
«Lo portiamo in centrale, detective?», chiese uno degli agenti appena arrivati, mentre sopraggiungeva una seconda volante.
Lei annuì e si raddrizzò in tutto il suo metro e ottanta di altezza, per togliersi poi un rametto dai capelli neri a spazzola. Tornò a rivolgersi al giovane riverso al suolo. «Sei sempre stato un cazzone, Paul, ma ora sei un cazzone con un coltello, e ciò significa che resterai al fresco per un bel pezzo», sibilò prima di consegnarlo agli agenti. «L’arma sarà da qualche parte qui nel quartiere, ragazzi», aggiunse.
«I vostri problemi non finiscono mica qua, porci», dichiarò Chater con disprezzo. «Ce ne sono un sacco come me, in strada, e stanno per arrivare…».
«Oh, questo lo so, ma… come si dice: un passo per volta».
Tornò dal collega che la stava aspettando e scuoteva il capo in silenzio. Kim si ripulì le mani dalla polvere e sorrise: una canaglia in meno in giro per le strade.
«Okay, Bryant. Ora puoi tornartene a casa e pensare alla cena»
2
La dottoressa A scrutò i volti in fila davanti a sé e si sforzò di trattenere un gran sospiro. La sua collega della Aston University era in viaggio verso Dubai, per istruire un gruppo di matricole della polizia sulle prime fasi di scavo in una scena del crimine.
Mentre lei si trovava nel mezzo di un campo della Black Country, con un manipolo di studenti apatici con la tipica faccia da lunedì mattina che lei, professionale com’era, non mostrava. Oh, dov’erano finite le giovani menti ansiose di sapere, i cervelli come spugne pronte ad assorbire nuove conoscenze? Se così fosse stato, il suo nuovo incarico sarebbe stato molto più facile. Ora, davvero le spettava di diritto la prossima consulenza archeologica in un paese dal clima mite e soleggiato.
«Va bene, accoglietevi qui intorno», disse, indicando con le mani davanti a sé.
«Voleva dire “raccoglietevi”», la aiutò Timothy, il suo assistente.
Lei lo guardò increspando le labbra. Sì, a volte confondeva alcune parole, ma se quei ragazzi non avevano capito una frase così semplice, allora prevedeva grandi problemi.
Mentre lei era occupata a tracciare i contorni dell’area, due metri per uno, i quattordici studenti si erano dispersi, formando piccoli gruppi serrati, le mani in tasca, le spalle incassate per fronteggiare una temperatura che, agli inizi di novembre, raggiungeva comunque i sette gradi. Il vento era freddo, ma non era certo insopportabile. Le sarebbe piaciuto portare quei giovani a casa sua in Macedonia, nella penisola balcanica, dove le masse di aria fredda provenienti dalla Russia restavano sospese nelle vallate facendo sprofondare la colonnina di mercurio fino a meno venti.
«Chi mi sa elencare gli strumenti di un archeologo forense?», chiese, aprendo la borsa accanto alle pale.
«Macchina fotografica», rispose uno degli studenti, sbadigliando.
«Matite e quaderno per i disegni», propose un altro.
«Pinzette e tamponi», aggiunse lo sbadigliatore.
«Una torcia».
Lei continuò ad annuire man mano che le venivano offerte le risposte più ovvie. L’entusiasmo ebbe vita breve, perché ora le giovani menti dovevano cambiare marcia per trovare altre soluzioni.
«Non dimenticate che siamo su una scena del crimine», suggerì la dottoressa.
«Nastro per delimitarla».
«Indumenti usa e getta».
Lei annuì di nuovo e abbassò lo sguardo sul rettangolo d’erba.
«Allora, siamo pronti per cominciare?», chiese, allungandosi a prendere una vanga.
I ragazzi si guardarono l’un l’altro mentre avanzavano.
«Da mu se nevidi», sussurrò lei.
Lanciò poi un’occhiata a Timothy, che ricambiò il suo sguardo: aveva imparato abbastanza la lingua macedone da sapere che era uno sfogo per la sua frustrazione.
«C’è qualcos’altro che dovremmo fare, prima?», domandò ancora la dottoressa.
«Pulire gli attrezzi», rispose uno studente.
«C’è da sperare che siano già puliti», ribatté lei, secca.
Iniziava ad augurarsi che nessuno di quei ragazzi scegliesse di entrare nella scientifica.
Prese a scavare pensando che era giunto il momento di imbeccarli un po’.
«Di solito si esamina per prima la zona in superficie. Qui non è stato commesso nessun reato, quindi partirò subito con lo scavo mentre vado avanti con la lezione».
Timothy si mise accanto a lei e cominciò a scavare a sua volta.
Alcuni studenti si avvicinarono, allettati dalla possibilità di fare qualcosa.
«Nei siti archeologici, gli strati rilevanti di solito sono completamente sepolti. Sulla scena di un crimine, anche lo strato di superficie acquisisce importanza. Le opere di scavo si estendono in realtà fino al terreno esterno. Ciò vuol dire che il suolo che calpestate, anche solo per recarvi sulla scena, fa parte del sito e la vostra presenza potrebbe alterare o distruggere un possibile reperto».
Fece una pausa in attesa di eventuali domande. Visto che nessuno parlava, proseguì con la lezione, come da programma. «Le prove di un reato sono ancor più delicate. Un archeologo forense deve saper trarre indizi da radici tagliate, foglie secche, vegetazione morta, segni di strumenti, impronte di scarpe e persino di dita».
Appena oltre il confine delimitato dalla vernice bianca, cominciò a formarsi una pila di terriccio.
«I reperti sulla scena di un crimine sono spesso di natura deperibile, e raramente si incontrano anche in un sito archeologico: carta, tessuti, tabacco, presenza di insetti, capelli, unghie e altri tessuti molli».
La dottoressa A si guardò intorno quando lo scavo raggiunse quasi mezzo metro di profondità, ma vide solo volti annoiati.
Passò la pala a una giovane dai capelli castani al suo fianco e fece cenno al ragazzo accanto a lei di prendere quella di Timothy.
«Continuate voi, prego», disse, e attese che i due si mettessero all’opera prima di riprendere a parlare.
«C’è anche la possibilità di imbattersi in materiali contaminati o pericolosi…». Esitò. «Come una pistola ancora carica».
Esitò di nuovo. Quell’ultima frase aveva improvvisamente attirato l’attenzione di tutti.
Annuì rivolta al gruppo. «Sì, è successo».
Si spostò dietro ai due studenti addetti allo scavo e con un cenno disse loro di passare le vanghe ai colleghi. Era arrivato il momento di dare una svegliata a quei ragazzi.
Intrecciò le dita dietro la schiena mentre continuava a camminare e a parlare.
«Tutte le prove rinvenute devono poi seguire il corretto protocollo per la preservazione e le analisi. Intanto scambiatevi pure le pale, per favore. Bisogna registrare ogni reperto e conservarlo finché non si potrà ufficialmente…».
Lasciò la frase sospesa quando diede un’occhiata nel fosso.
«Fermi», urlò a gran voce.
Tutti i presenti fecero un passo indietro, spaventati.
«Allontanatevi», ordinò lei, senza distogliere lo sguardo dallo scavo.
Si spostò verso il lato lungo e si mise in ginocchio.
Guardò con più attenzione, allungando la mano destra. Da bravo assistente, Timothy capì subito cosa doveva fare.
Le depositò sul palmo un pennello a setole morbide.
«Mi state coprendo la luce, ragazzi», gridò, con lo sguardo sempre fisso sull’oggetto che aveva catturato la sua attenzione.
Lo spazzolò con cura, mentre il cuore le batteva sempre più forte.
Quando la forma liscia e tondeggiante cominciò a emergere dal terreno, tutt’intorno a lei si levarono dei versi di stupore. Evidentemente quegli studenti qualcosa capivano, in fondo.
La dottoressa A si fermò per rivolgersi al suo collega.
«Timothy, fai allontanare tutti dalla zona. Poi mettimi in contatto con il medico legale e con la detective Stone».
3
Stacey Wood faticò ad analizzare la scena: tutto quel sangue, che aveva raggiunto ogni superficie della stanzetta sul retro di quella piccola abitazione, era osceno. Ma non era l’unico problema; non era certo la prima volta che vedeva tanto sangue: a turbarla era un ricordo che si era sempre sforzata di tenere rinchiuso nei recessi della mente.
Incrociò lo sguardo di Dawson in quella cameretta in cui erano sparpagliate scarpe da ginnastica e da calcio, magliette e riviste di motori.
La tipica stanza di un adolescente, se non fosse stato per il corpo del ragazzo accasciato contro una parete e le pozze di sangue sulla moquette. L’odore metallico del sangue contrastava con quello acre di sudore che impregnava alcuni indumenti.
Il ragazzo aveva la testa reclinata all’indietro e gli occhi sgranati fissavano la chiazza di sangue sul soffitto, quasi stesse ammirando le stelle o stesse guardando stupito il risultato del suo gesto. La pelle liscia e giovane era segnata solo da una cicatrice bianca, sotto l’occhio sinistro. Una manica della felpa era arrotolata fino al gomito, a mostrare la ferita letale. I jeans grigi e stretti erano coperti di sangue, ormai quasi secco.
Il coltello da cucina era caduto a pochi centimetri dalla mano destra.
Stacey si sforzò di mantenere il respiro calmo e controllato mentre continuava a fissare il coltello. Non voleva che Dawson la ritenesse incapace di cavarsela sul campo…
Angela Marsons
ha esordito nel thriller con Urla nel silenzio, bestseller internazionale ai primi posti delle classifiche anche in Italia. La serie di libri che vede protagonista la detective Kim Stone prosegue con Il gioco del male, La ragazza scomparsa, Una morte perfetta e Linea di sangue. Vive nella Black Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller. I suoi libri hanno già venduto più di 3 milioni di copie.