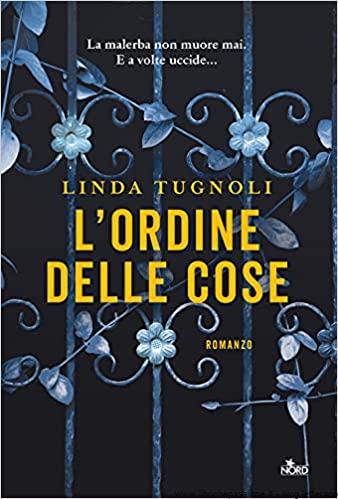Trama
«Un romanzo così bello, intenso e vivo sul giappone non si vedeva dai tempi di Memorie di una Geisha» The Bookseller
Giappone, 1957. Il matrimonio combinato della diciassettenne Naoko Nakamura con il figlio del socio di suo padre garantirebbe alla ragazza una posizione sociale di prestigio. Naoko, però, si è innamorata dell’uomo sbagliato: è un marinaio americano, quello che in Giappone viene definito un gaijin, uno straniero. Quando la ragazza scopre di essere incinta, la comprensione e l’affetto che sperava di trovare nei genitori si rivelano soltanto un’illusione. Ripudiata da chi dovrebbe starle vicino, Naoko sarà costretta a compiere scelte inimmaginabili, per qualunque donna ma soprattutto per una madre.
Stati Uniti, oggi. Tori Kovač è una giornalista. Mentre si prende cura del padre, anziano e gravemente malato, trova una lettera che getta una luce sconvolgente sul passato della sua famiglia. Alla morte del padre, decisa a scoprire la verità, Tori intraprende un viaggio che la porta dall’altra parte del mondo, in un villaggio sulla costa giapponese. In quel luogo così remoto sarà costretta a fronteggiare i demoni del suo passato, ma anche a riscoprire le proprie radici.
Estratto
A mio padre, David Gaydos
(1936–1988)
Basta incontrarsi e parlarsi per diventare sorelle.
PROVERBIO GIAPPONESE
Prologo
Il mio nome da nubile è Naoko Nakamura. Sposandomi sono diventata Naoko Tanaka. E una volta, per un breve periodo di tempo, c’è stato un altro nome, un nome insolito che mi fu attribuito nel corso di una cerimonia non convenzionale celebrata sotto un vecchio albero carico di luci tremolanti.
Non fu un sacerdote a officiare il rito. Non ci sposammo in un tempio sacro e io non feci i consueti tre cambi d’abito.
Ma ero innamorata.
Quella sera il buio ricopriva le piccole case del villaggio avvolgendole in un manto nero, ma a ovest il cielo striato di arancione sembrava indugiare curioso, facendo capolino all’orizzonte. L’aria umida mi accarezzava le guance mentre scendevo i gradini del portico fino al giardino, e quando svoltai l’angolo, rimasi senza fiato.
Il vialetto acciottolato era punteggiato di lanterne di carta e delle sfere dorate illuminavano gli alberi come hotaru, le lucciole che sciamano dopo le abbondanti piogge di luglio. Erano così tante che camminando sotto i rami e alzando lo sguardo, mi sembrava di essere sovrastata da enormi ombrelli che mi riparavano da centinaia di stelle cadenti.
Con un sorriso feci scorrere la mano sul mio abito per tastarne la piacevole morbidezza. Non mi ero mai sentita così bella o così agitata. Trepidavo di eccitazione, come se una stellina pirotecnica crepitasse dentro di me, trasmettendomi una vibrazione che mi attraversava dalle dita dei piedi ai polpastrelli.
Davanti a me, in mezzo alla piccola folla in attesa, c’era colui che di lì a poco sarebbe diventato mio marito. La luce delle lanterne si rifletteva nei suoi occhi, accendendoli di lamelle bianche che danzavano come vele in un oceano blu, e io mi sentii naufragare dentro quegli occhi. Dentro di lui. In quell’istante.
Ogni passo che facevo mi avvicinava sempre più al mio futuro e mi portava lontano dalla mia famiglia. Erano due estremi opposti, contrastanti in tutti i sensi, ma in qualche modo avevo trovato il mio posto fra l’uno e l’altro. Era quello che Buddha definiva la via di mezzo. Il giusto equilibrio della vita.
Io lo definivo felicità.
Una vita piena d’amore è felice. Una vita per l’amore è insensata. Una vita fatta di “se solo…” è insopportabile. Nei miei settantotto anni, le ho vissute tutte e tre.
Mia nonna ripeteva spesso: «Il dolore è così. E lo stesso vale per la felicità. Prima o poi passano». Ma nonostante gli anni che ho sulle spalle, quando chiudo gli occhi, riesco ancora a vedere il tremolio distante di migliaia di minuscole luci.
1
America, oggi
Perfino di notte con il personale ridotto, il Taussig Cancer Hospital seguiva sicuro la sua rotta, come l’omonima nave. Con il dottor Amon al timone, pregavo che mio padre riuscisse in qualche modo a superare la tempesta, ma la sua salute precaria mi spingeva a rimanere al suo capezzale, attenta a ogni minimo segnale.
Sebbene avessi abbassato le luci e il volume del televisore, papà si agitava nel sonno. Il silenzio era rotto soltanto dal ronzio delle macchine e dal bip regolare dei monitor, e le conversazioni provenienti dal corridoio si riversavano come onde nella stanza. Qualcuno fischiettava.
«Stuzzicare il vento fischiettando era rischioso» diceva papà ricordando i tempi in cui andava per mare. «Poteva essere foriero di forti burrasche e acque agitate.» L’ospedale non era la nave di quando prestava servizio in Marina negli anni Cinquanta, ma pur ritenendo quell’omonimia una coincidenza improbabile, non me la sentivo di ignorare le superstizioni nautiche. Mi alzai e andai a chiudere la porta.
«Cosa…» Papà agitò le braccia facendo sbattere i tubicini della flebo come cime contro l’albero maestro. «Tori?»
«Sono qui, papà.» Mi avvicinai al letto e posai una mano sul suo braccio. «Sei all’ospedale, ricordi?» Si svegliava un po’ frastornato nell’ultima settimana, fra intervalli di riposo sempre più brevi. Era diventata la norma ormai.
Fece una smorfia di dolore nello sforzo di tirarsi su, così gli sostenni la schiena e cercai di sistemarvi dietro un cuscino. Infilando le mie braccia sotto le sue lo aiutai a sollevarsi, sorprendendomi di quanto fosse diventato leggero. Scherzando aveva detto di non essere più “neanche la metà” dell’uomo che era stato un tempo, ma io non avevo riso. La realtà era tutt’altro che divertente e la battuta era ben lontana dal vero. Lui era ancora il mio straordinario papà.
Gli porsi il bicchiere di plastica. Lo agitò facendo sbattere i cubetti di ghiaccio rimasti e bevve un sorso d’acqua. Questo bastò a scatenare la reazione: una tosse insistente difficile da tenere a bada. Gli tolsi il bicchiere di mano, gli passai qualche fazzoletto e attesi che la crisi passasse. Dopo un ultimo colpo di tosse, papà si abbandonò sul cuscino e chiuse gli occhi, stremato.
«Tutto a posto?» Parole vuote, perché era chiaro che non stava bene, ma lui mi rassicurò comunque con un cenno del capo.
Poi sospirò, un sospiro profondo e rauco attraverso il quale le parole tentavano di farsi strada. «Ti ho mai parlato della famosa Blue Street? Fu la prima cosa che vidi quando sbarcai dalla nave in Giappone.»
«E la ragazza che rimase colpita dai tuoi occhi fu la seconda, giusto?» Mi illuminai, felice che mio padre fosse lucido e sperando che lo rimanesse abbastanza a lungo per ripetere il suo racconto ancora una volta.
«Be’, all’epoca avevo un aspetto migliore.»
«Ce l’hai anche adesso.» Era vero. Aveva ripreso un po’ di colore sulle guance e il suo sguardo era vivace e concentrato. Anche i movimenti erano migliorati. La cosa mi appariva meravigliosa e sconfortante al tempo stesso. Il dottor Amon mi aveva avvertito circa la possibilità di una “fugace ripresa” prima che mio padre imboccasse l’ultima curva.
Per lui, l’ultimo urrà. E per me, l’epilogo di una storia.
Dalla sedia accanto al suo letto, mi protesi in avanti e appoggiai il mento sulle mani chiuse a pugno. «E così facesti un passo avanti, ti chinasti per sfiorare le pietre luccicanti incastonate nel selciato e…?»
«E quando mi rialzai, lei era là.»
«Che ti fissava.»
«Sì. E io la fissai di rimando, vidi il mio futuro e mi innamorai all’istante.» Papà piegò la testa di lato con un sorriso dolce sulle labbra.
Sebbene quella fosse la versione ridotta, ancora una volta rimasi rapita dalla sua storia perché sapevo che avrebbe portato a tutte le altre.
«Ogni volta che arrivavo al porto, la trovavo là ad aspettarmi» continuò. «Ma io andavo e venivo in continuazione. Funzionava così. Eravamo due navi che si incrociano nella notte, come nella poesia di Longfellow.» Inspirò a fatica.
Cercai la sua mano lentigginosa e gliela strinsi.
«Dopo il periodo di servizio a bordo rimasi di stanza a Detroit e iniziai a bere. Ma poi conobbi tua madre, e lei mi salvò.» I suoi occhi erano inchiodati ai miei. «E c’è una cosa che devi sapere. Mi stai ascoltando?»
«Certo.» Pendevo da ogni singola parola.
«Tua madre è stata l’amore della mia vita, ma prima di quella vita, ne ho vissuto un’altra. È ciò che stavo cercando di dirti.» Contrasse le labbra.
Quando? Quando aveva cercato di dirmelo? La mia mente ripercorse ogni momento delle ultime settimane, tentando di decifrare che cosa mi era sfuggito. Non capivo neppure cosa potesse significare “vivere un’altra vita”. Non ero sicura di volerlo capire.
«Sarebbe più semplice se leggessi la mia lettera. Ho bisogno che tu lo faccia adesso, okay, Tori? È arrivato il momento.»
È arrivato il momento?
D’un tratto mi sentii gonfiare il petto. Una bolla emotiva che premeva contro le costole e mi serrava il cuore. Provai a controllarla con una serie di rapidi respiri, temendo che esplodesse. Non riuscivo a muovermi.
Mio padre allungò la mano e diede dei colpetti sulla mia. «È tra le mie cose. Vai a prenderla.»
Trovai la sua borsa dietro la porta del bagno, la posai sul tavolo e aprii la cerniera. Con le mani tremanti rovistai tra i suoi vestiti finché, sentendo la carta sotto le dita, mi bloccai. Tirai fuori la busta, poi indugiai un istante a fissarla.
Inchiostro rosso. Caratteri kanji. Fogli spiegazzati.
Mentre tornavo da mio padre, i nostri occhi si incrociarono.
Un uomo in fin di vita. Una figlia con il cuore spezzato.
«Vieni qui, siediti» disse. «Va tutto bene.»
No, non andava tutto bene. Perché non è possibile rimandare un addio. Non ero pronta a quel congedo, né volevo sentire quello di mio padre. Non potevo.
Un grumo di dolore mi premeva in fondo alla gola. «Io…» Feci un passo verso di lui, poi mi fermai. Avevo bisogno che tutto rallentasse e prendesse fiato, così da poterlo fare anch’io. Lo stress degli ultimi mesi, l’angoscia suscitata dal lento declino di mio padre, il cancro inesorabile, e ora… un groppo mi serrò la gola mentre gli occhi si riempivano di lacrime. Mi avvicinai alla porta con passi affrettati.
Papà disse qualcosa, ma io ero già in corridoio, dove lui non poteva vedermi. Mi coprii la bocca e presi dei respiri lunghi e profondi, cercando di respingere l’ondata di emozione che mi soffocava. Come eravamo arrivati a quel punto? Avevamo studiato le terapie più adatte, tentato qualsiasi rimedio domestico, consultato uno specialista, eppure non era bastato. La confusione e il senso di colpa gravavano sulle mie spalle, e mi sentivo schiacciata da quel peso. Lanciai un’occhiata alla busta. A ripensarci, avrei dovuto aprirla il giorno in cui era arrivata.
Mio padre guardava la partita in soggiorno. «Tori, sei tu?»
«Sì, sono io.» Lanciai le chiavi e la posta sul tavolo, sorpresa che mi avesse sentito entrare con il televisore a un volume così alto. «C’è una lettera per te.» Feci capolino in soggiorno e gliela mostrai sventolandola.
I suoi occhi rimasero incollati allo schermo. I miei caddero sulla valigia vuota accanto alla sua sedia. Non si era ancora preparato per andare in ospedale e l’avrei dovuto accompagnare l’indomani mattina. Anche se era stato quasi un miracolo che lo specialista fosse riuscito a trovargli un posto in reparto, capivo bene lo scarso entusiasmo di mio padre.
Odiavo il cancro.
Non soltanto si era mangiato il suo corpo, aveva divorato il suo spirito e consumato il mio. Mi ero disperata come una bambina, una bambina di trentotto anni.
Lo lasciai alle prese con la sua partita, una delle poche cose che ancora gli procuravano piacere, mi versai una tazza di caffè, poi mi apprestai ad affrontare quella montagna di corrispondenza. Le buste erano state raccolte con spessi elastici di gomma e infilate nella sua cassetta della posta, come se lui fosse rimasto fuori per un mese e avesse dimenticato di sospendere il servizio. Solo che non era andata così. Gli era semplicemente sfuggito di mente di farmi controllare.
Bevvi un sorso di caffè e mi ritrovai a fissare la lettera. Simboli asiatici stampigliati qua e là. Spesse righe rosse che barravano l’indirizzo. Sopra questo, in caratteri latini, la scritta PARTI. Parti? Feci saltellare la busta sulla mano, la girai sul retro e poi tornai a guardarla sul fronte. Era stata piegata più di una volta e il bordo era sfilacciato, come se fosse rimasta impigliata nello smistalettere automatico; strano che fosse stata recapitata comunque.
La giornalista investigativa che era in me moriva dalla voglia di aprirla.
La alzai verso la plafoniera del soffitto e la osservai controluce. In quella posizione riuscii a vedere il profilo di un biglietto piegato e una specie di cordino. Provai a scuoterla, ma la busta non aveva peso. La rigirai e spianandola mi accorsi di una parola familiare sbaffata nella piega.
Japan.
C’era una sbavatura d’inchiostro sulla “J”. Ne seguii il contorno con la punta del dito. Chi conosceva ancora mio padre in Giappone? Era stato di stanza laggiù durante il servizio in Marina e raccontava storie inverosimili di quel periodo oltremare, ma risalivano a cinquant’anni prima. Non c’erano emblemi né insegne militari, perciò non si trattava dell’annuncio di una convocazione ufficiale. Forse una rimpatriata informale? Aveva giocato a baseball quando era arruolato, anche in Giappone.
Una volta la Settima Flotta della Marina statunitense aveva sfidato in un’amichevole gli Shonan Searex, la squadra locale di Yokosuka. Ogni volta che ne parlava, papà si metteva una mano a coppa sulla fronte, come a scrutare la folla in uno stadio. «Neanche un posto vuoto si riusciva a vedere. Ma te lo immagini, Tori?»
Sì, me lo immaginavo. Sempre.
L’arena scoperta, il tappeto erboso perfettamente curato e mio padre, così giovane, così nervoso, che si scaldava sulla pedana del lanciatore.
«Non hai idea del chiasso» raccontava papà. Invece degli applausi si sentivano i colpi delle mazze di plastica colorate sbattute sugli schienali dei sedili – pam pam pam. I capitani della tifoseria correvano su e giù dagli spalti suonando i tamburi e incitando la loro squadra del cuore con cori che inneggiavano
alla vittoria. Alcuni gruppi organizzati di sostenitori che occupavano settori riservati, urlavano slogan attraverso i megafoni e cantavano inni creati su misura. Papà sosteneva che il baseball aveva dato uno scossone alla tranquilla cultura giapponese degli anni Cinquanta.
Sebbene fosse un’amichevole, la partita contro gli USA aveva un sottofondo pesante: in sostanza, il Paese del Sol Levante intendeva, se non cancellare, almeno sbiadire il rosso, il bianco e il blu delle stelle e strisce avversarie.
«Quasi desideravo che la nostra squadra perdesse» ripeteva sempre papà. «C’era la famiglia della mia ragazza sugli spalti e non volevo che si sentissero offesi prima ancora di conoscermi.»
Parlava sempre della “sua ragazza” quando mi raccontava queste storie. Non avevo mai saputo il suo nome. E se c’era mia madre in giro, non c’erano neppure i racconti. Quando gli chiedevo qualche dettaglio in più, lui scuoteva la testa e gonfiando le guance si limitava a dire: «Era speciale, davvero».
Lo era anche lui. E io lo adoravo.
Un uomo che aveva ereditato l’abitudine di bere brandy alla frutta dal padre slovacco, sapeva imitare la camminata spavalda di John Wayne e tesseva racconti colorati come nessun altro.
Anche se, come succedeva nella maggior parte dei casi, era difficile capire quanto ci fosse di vero. «Cos’è la verità se non una storia che raccontiamo a noi stessi?» diceva. Poi mi strizzava l’occhio, mi dava un buffetto sul naso e mi lasciava a discernere la realtà dalla fantasia. Una cosa che stavo ancora facendo.
Ma quella lettera dal Giappone … quella era reale…
Biografia
Nata e cresciuta a Detroit, Ana Johns ha studiato giornalismo e lavora da oltre vent’anni nel campo delle arti creative. La donna dal kimono bianco, tradotto in 18 Paesi, è il suo romanzo d’esordio, basato su eventi realmente accaduti, anche alla sua famiglia.