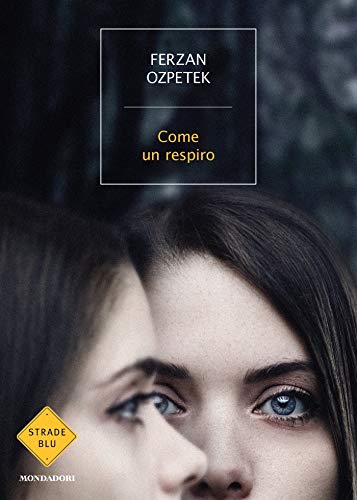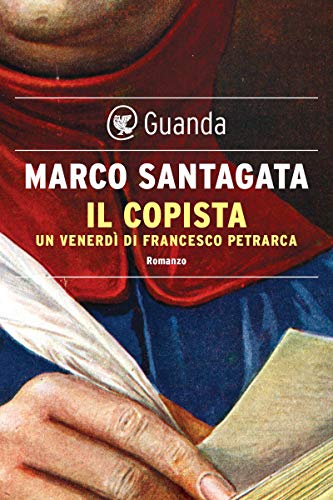
Sinossi
In un freddo e nebbioso venerdì di ottobre, Francesco Petrarca si sveglia afflitto da dolori allo stomaco. Il cantore di Laura è intento a scrivere una canzone destinata a confluire nel libro delle rime. Tuttavia, la composizione si trasforma ben presto nella personale e tormentata via crucis di un uomo ormai invecchiato e logorato dalle perdite della sua vita. La morte del figlio Giovanni e del nipotino Francesco, portati via dalla peste (come prima la stessa Laura), e poi la fuga del giovane copista Giovanni Malpaghini lo lasciano sempre più solo nella casa di Padova, con l’unica compagnia della serva Francescona. Così, a mano a mano che i versi prendono forma, Petrarca si rivela una persona inquieta e contraddittoria, che ha perdutola fede fino ad essere incapace di credere alla sopravvivenza dell’anima. Con una narrazione malinconica e a tratti impietosa, Marco Santagata trasforma in romanzo la fantasia di una giornata di Petrarca, di cui restituisce un ritratto profondamente umano.
Estratto
1
E con quello erano quattro. Quattro giorni che pioveva.
«Qui, o si crepa di caldo o si gela dal freddo» brontolò.
Rabbrividendo cercava di sollevarsi dal letto. «Non ci sono vie di mezzo, qui.»
Ripensò con nostalgia alla Provenza.
«Città schifosa!»
Era riuscito a mettersi seduto sulla sponda. Fece ancora uno sforzo, si tirò la coperta di lana sulle spalle e faticosamente si alzò in piedi. La schiena era rigida, le giunture anchilosate, ogni piccolo movimento gli procurava dolore. Sentiva il peso dei suoi sessantaquattro anni.
Restò immobile, in equilibrio precario. L’ulcera allo stomaco si era svegliata insieme a lui. Fumi acidi risalivano l’esofago. Uno stimolo al basso ventre: ecco cosa restava della sua virilità. Per raccogliere il vaso avrebbe dovuto chinarsi…
Durante la notte allungava un braccio sotto il letto, afferrava il recipiente e svuotava la vescica restando sdraiato. A volte si bloccava a causa di un’improvvisa sensazione di freddo alla punta del pene: il vaso era pieno.
Lì in piedi, con una mano stringeva la coperta sul petto, con l’altra palpava l’appendice che aveva estratto dai mutandoni di lana.
In testa gli ronzava un confuso desiderio di orinare, di dormire rannicchiato in una culla, di versare il seme dentro al corpo di una sconosciuta. Un peto lungo e silenzioso allentò la pressione sulla
vescica: l’immediato sollievo in basso lo staccò dal dormiveglia.
«E c’è pure la nebbia… schifosissima città!» borbottava irritato.
La camera era buia, le imposte delle finestre chiuse, l’alba ancora lontana. Il cigolio dei primi sporadici carri tra le case di Padova aveva l’eco inconfondibile delle notti nebbiose.
Si era concentrato sul suono chioccio che il suo stentato zampillo produceva colpendo dall’alto la superficie del vaso ormai quasi colmo. A tratti, una rosa di tiepidi spruzzi sulle caviglie, seguiti da uno scrosciare più vivace, lo avvertiva che stava pisciando sul pavimento. Se non fosse stato per quei segnali, non si sarebbe nemmeno accorto che si stava liberando. E fu proprio il silenzio in cui era di nuovo piombata la stanza a fargli capire che l’operazione era finita. Fece ancora aria, stavolta con rumore. Per la miseria, si disse, mi scappa… e adesso chi ci va in quella ghiacciaia? Ruttò, con le unghie grattò i peli radi del pube e infine mosse il primo passo verso la porta.
Una lama di luce rossiccia filtrava dalla fessura tra l’uscio e il pavimento. Al di là della porta, dallo studio, proveniva un fruscio di passi strascicati. All’improvviso echeggiò il suono secco di un oggetto metallico lasciato cadere sull’impiantito. Anche quella notte la vecchia Francescona aveva preceduto il padrone. Gli sembrava di vederla quella vecchietta gobbuta, alta poco più di due braccia, piegata fin quasi a toccare terra con il naso, mentre strisciava sotto il tavolo per sistemare lo scaldino davanti allo scranno. Dopodiché con i suoi passettini da topo sarebbe scivolata verso la cucina a bollire il latte. La Francescona, beata lei, non pativa né il caldo né il freddo. In quella schifosa città lei c’era nata.
La Francescona! Chi mai aveva stabilito che lui dovesse passare la vita intera
circondato da Franceschi e da Giovanni? Al pensiero dei Giovanni ebbe un mancamento. Era come l’ulcera, quel pensiero: i due compagni della sua vecchiaia. Come con l’ulcera, si era abituato a conviverci. Tranne quando era debilitato o in preda alla malinconia.
Annaspò nel vuoto, ma non trovò alcun appiglio. Fu lì lì per cadere. Sebbene il pavimento gli ballasse sotto i piedi, ritrovò l’equilibrio. Ma i giramenti di testa non erano cessati. «Francesco, fatti chiamare Francesco» farfugliava a non si sa chi, «Giovanni è un nome maledetto». Ridacchiava come un demente, e intanto tirava avanti e indietro quell’arnese insensibile che ancora pendeva dalle mutande. E così individuò un interlocutore. «Vero, Franceschino?» gli diceva con una voce in falsetto, da vecchio che bamboleggia. «Vero che ci siamo divertiti? Racconta, dillo, di’ quanto abbiamo ballato, noi due. Il mio caro Franceschino, il mio bel flautino, il poetino delle dame!»
All’improvviso gli apparve il cadavere di Franceschino: era composto in un canestro, bianco di fiori e di veli, appoggiato, dentro a un cerchio di candele, sul tavolo lungo nella casa di Pavia. Lui non l’aveva visto, da morto: ma sui racconti ascoltati aveva elaborato una sua scena, che nel tempo, a ogni riapparire dell’immagine, arricchiva di particolari. Era uno scheletrino minuto, sotto i riccioli biondi il viso era ridotto a un piccolo teschio rifilato: gli occhi incavati, il nasino appuntito, dalla bocca socchiusa spuntavano due incisivi da leprotto, appena accennati. Dio, quanto aveva amato quel bambino! Quel sacchettino d’ossa e di peli, quell’involucro bianco, era stato il suo nipotino, il suo frugolo, il suo Ceschino.
Retrocedette nel buio e si rimise a sedere sul letto. Nonostante il freddo, sudava. Ma sentiva ritornare le forze, e con l’energia cresceva la sua irritazione, la sua rabbia contro tutti, contro il mondo…
Nessuno aveva capito. Non riuscivano a spiegarsi la sua affezione per un animaletto incapace di camminare e di parlare. Ci scherzavano sopra. L’età, l’età, anche il sommo Francesco s’era rammollito! Passi per i colleghi, quei quattro grammatici convinti di essere pozzi di scienza perché scandivano le sillabe dei versi, ma gli amici, che delusione! Nessun amico sa leggerti nel cuore. Se lui fosse nato in casa Colonna, in casa Correggio, se avesse avuto soltanto un decimo delle rendite di quegli zotici superbiosi davanti ai quali si era inchinato per tutta la vita, eh no, perdio, no che non avrebbe preso i voti. Castità! Dite pure solitudine. Sterilità è il suo vero nome, ipocriti. A lui sarebbe piaciuto mettere su famiglia, una bella nidiata di figli e una moglie da esibire ingioiellata alle feste. A questo aveva rinunciato, questo era stato il prezzo della libertà: ecco quanto pagava, lui, alla poesia! E quei letterati scodinzolanti inneggiavano alla sua suprema serenità!
Gli si inumidirono gli occhi. Represse un singhiozzo. Era da sempre facile alle lacrime, ma con l’età gli bastava un nonnulla per commuoversi.
Franceschino era stato la sua ultima speranza. Quante volte con la fantasia aveva galoppato in avanti nei secoli, ad ascoltare i discorsi dei posteri. «Il primo virgulto cresciuto all’ombra del grande Senior, dell’immensa quercia che da secoli alimenta un bosco frondoso di poeti, di storici, di consiglieri di principi e repubbliche»: questo dicevano i posteri del suo Franceschino.
Non si contenne più e scoppiò in un pianto dirotto.
E l’aveva voluto lui quel nome. L’aveva imposto a Francesca. Lei aveva provato a opporsi: «Babbo» gli diceva con il suo fare remissivo, «pensa che impiccio… Francesca la madre, Francescuolo il padre, Francesco il nonno… non sarebbe meglio un altro nome?» Ma lui non aveva sentito ragioni: doveva essere Francesco. «È bello e porta fortuna.»
Senza accorgersene si era alzato in piedi e aveva lasciato cadere la coperta. In camicia da notte gesticolava nel buio. Ogni tanto si asciugava le lacrime con il dorso di una mano.
Due anni prima – era una limpida mattina di febbraio – un corteo di donne era entrato nel suo studio a Venezia e gli aveva presentato un fagottino che guaiva. La sua reazione era stata quasi scomposta. La gioia che l’aveva invaso era incontenibile. Con le braccia tese aveva sollevato al cielo quell’involucro e lo aveva palleggiato ridendo a bocca aperta. E tra le risa, con voce tonante, che lo udissero i passanti sulla Riva, declamava:
«Francesco, Franceschino, Ceschino… Franciscus Junior, tu sarai il secondo poeta laureato della famiglia».
Ma non dimenticava di gettare qualche occhiata a Giovanni, che dal solito angolo dove stava copiando le sue lettere familiari osservava la scena con un sorriso indecifrabile. Quella mattina lui voleva bene a tutti e voleva che tutti fossero felici: così, nel guardare Giovanni, aveva assunto una fisionomia paternamente rassicurante. «Anche tu» sembrava dirgli con gli occhi, «anche tu sei un ramo della grande quercia.»
Rimase con le braccia sollevate, le mani aperte ad afferrare l’aria. Dopo pochi istanti prese coscienza della posizione in cui si trovava. Un tremito di collera lo squassò da capo a piedi. «Poeta laureato?» gridò verso la striscia luminosa sotto la porta. Chiuse i pugni, abbassò di scatto le braccia e si colpì le cosce facendosi male.
Al di là dell’uscio la vecchia Francescona udì un tonfo e una orribile bestemmia. Si fece il segno della croce e con un fruscio lieve zampettò verso la cucina. Era l’ora di bollire il latte per il padrone.
2
Il 13 ottobre del 1368 Francesco Petrarca si era dunque svegliato di pessimo umore. Da molti anni i suoi risvegli si erano fatti difficili. Non era sempre stato così. Anzi. Fin verso i quaranta, puntualmente, apriva gli occhi due ore prima dell’alba e si buttava di slancio giù dal letto: alacre e voglioso si precipitava al tavolo di lavoro. Allora il tempo non gli bastava mai. Lo divorava un desiderio bruciante di gloria. Era capace, in quegli anni, di restare seduto al tavolo da una notte all’altra. Leggeva e rileggeva le opere dei grandi latini fino a sentirle sue. Cicerone, si diceva, mi ha salato il sangue. Il sangue, in quegli anni felici, gli fluiva cantando nelle vene: la poesia ne sgorgava copiosa, fresca, originale… Di quel fervore di un tempo da alcuni anni ormai gli era rimasta solamente l’abitudine di svegliarsi prima che sorgesse il sole. E quel risveglio nel cuore delle tenebre gli costava sempre più fatica. Eppure non desisteva. Era un cordone che lo legava a una giovinezza carica di aspettativa, a una maturità felicemente operosa, e a cui ancora si aggrappava. Reciderlo sarebbe stata l’ultima resa. Sarebbe rimasto sommerso dal gorgo lento, dalla polla di indolenza che, anno dopo anno, lo stavano risucchiando. Per questo si ostinava ad aprire gli occhi nel buio di una stanza, nel silenzio sinistro di una notte disabitata, dominata dal vento, dalla pioggia, dalle nebbie. I suoi servi avevano l’ordine tassativo di alzarsi prima di lui e di coricarsi dopo di lui. Non sopportava di perdersi nel sonno se una presenza umana non teneva in vita la casa, e non avrebbe retto all’impatto del risveglio se altri esseri umani non lo avessero preceduto e non fossero lì, testimoni muti ma non silenziosi, a certificare che quella nuova vita era la stessa temporaneamente sospesa.
Sì, i risvegli si erano fatti difficili. Un torpore animalesco gli impediva di aprire gli occhi; la mente, vuota di stimoli, non lo contrastava. Restava nel letto immobile e in attesa. Non provava avversione per la vita attiva, sentiva però un incoercibile desiderio di avvoltolarsi nel dormiveglia, di riannodare il filo dei sogni appena spezzato. E a volte ci riusciva ad afferrare il sogno, giusto in tempo perché non svanisse, e così a intervalli, sempre più brevi e confusi, scacciava la coscienza che reclamava i suoi diritti. In quei primi momenti non riusciva a immaginare altra forma di vita che non fosse quella della spugna. Assorbiva le sensazioni del corpo e si imbeveva delle fantasie che trascorrevano labili tra gli occhi e la mente. La corrente dei ricordi lo trascinava in una deriva nella quale si amalgamavano immagini, suoni, parole provenienti da epoche diverse della sua vita passata.
Intorno a lui era un coro ammirato e stupito: tutti lodavano la sua straordinaria capacità lavorativa. Il numero delle opere poetiche, storiche, morali, enciclopediche, delle lettere, delle invettive, delle orazioni – per sé, per i prìncipi, per le repubbliche –, quello dei consigli e delle assemblee ai quali aveva preso parte, delle ambascerie presso papi, imperatori o semplici signorotti, delle mediazioni diplomatiche che aveva tessuto, in una parola, l’insieme delle sue attività pratiche e intellettuali non poteva che suscitare invidia. E lui non poteva fare a meno di chiedersi cosa mai avrebbero pensato e detto i suoi tanti ammiratori se avessero saputo quante ore del giorno trascorreva indolente, seduto a guardare nel vuoto, a inseguire fantasmi.
Si compiaceva di questo suo segreto.
Con il passare degli anni la pigrizia del risveglio si era dilatata fino a coprire l’intero arco del giorno. Ne misurava il progredire come se fosse una grande chiazza di alghe morte che i flussi subacquei pazientemente allargano sulla superficie di un mare in bonaccia. Eppure la sua produttività non era diminuita, anzi, era addirittura cresciuta. Ogni sua pagina incontrava un grande favore, i suoi scritti venivano accolti come avvenimenti da commentare, discutere, elogiare in pubblico e in privato. Gli era venuto il sospetto che i suoi estimatori non fossero del tutto sinceri, o quanto meno, che nelle nuove opere applaudissero ancora le vecchie. Per deferenza, forse, ma più probabilmente perché lui ormai poteva essere considerato un uomo potente. Troppi indizi, però, confermavano la loro buona fede. Del resto, c’era da stupirsi se quanto usciva dalla penna di Francesco Petrarca era apprezzato fin quasi alla venerazione? Gli uomini sono un gregge privo di discernimento, guidato per lo più dalla campanella della fama e del sentito dire, un gregge belante dietro ai valori consacrati. Meglio così, si diceva, molto, molto meglio così. Perché lui sapeva che le sue pagine non erano più toccate dalla grazia di un tempo, era consapevole dei piccoli trucchi e dei veri e propri sotterfugi a cui ricorreva: frasi ritrite, con abilità, certo, ma pur sempre ritrite, ritmi e inarcature talmente suoi che gli venivano da soli: senza sforzo, ma senza originalità. Non provava più la voglia di esplorare strade nuove, rifuggiva dalle fatiche dell’invenzione. Riscriveva e riscriveva… Ma quel ruminio era un sostituto della creatività, un vizio che lo lasciava insoddisfatto. Il getto di idee e di immagini che un tempo gli sprizzava dal cuore si era lentamente, ma inesorabilmente, assottigliato. «Caro Francesco» si diceva ridacchiando, «tu petrarcheggi, sei la scimmia di te stesso.» Se lo diceva senza amarezza, …