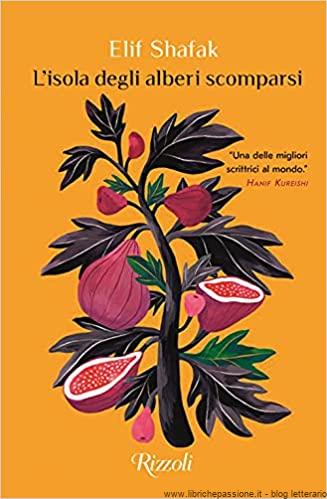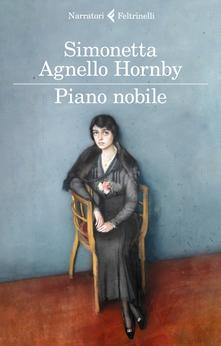
Trama
Palermo, estate 1942. Come in un lucido delirio, il barone Enrico Sorci dal suo letto di morte vede passare davanti agli occhi la storia recente della sua famiglia. Vede la devozione della moglie e i torti che le ha inflitto, vede le figlie Maria Teresa, Anna e Lia, i figli Cola, Ludovico, Filippo e Andrea; e vede Laura, la nuora prediletta, con il figlio Carlino, per il cui futuro si inquieta. Poco prima di morire il barone ordina che la notizia del suo trapasso non venga immediatamente annunciata e infatti, ignari, i parenti si radunano intorno alla tavola per un affollatissimo pranzo che si tiene fra silenzi, ammicchi, messaggi in codice, tensioni, battibecchi, antichi veleni, segrete ambizioni. È come se il piano nobile di palazzo Sorci fosse il centro del mondo, del mondo che tramonta – fra i bombardamenti alleati e la fine del fascismo – e del mondo che sta arrivando, segnato da speranze ma anche da una diversa e più aggressiva criminalità. Uno dopo l’altro, i protagonisti prendono la parola per portare testimonianze, visioni, memorie che si avviluppano in una spirale di fatti e di passioni, vendette e tradimenti, componendo un quadro privato e collettivo degli eventi che segnano Palermo fino all’aprile del 1955. Offesa dalla guerra e dall’occupazione, la città si apre con sventato entusiasmo a una nuova ricchezza e a nuove alleanze con la politica e la malavita; nelle pieghe della famiglia Sorci si consumano amori, fughe, ribellioni, rovine. E tutto fluisce, incessante. Agnello Hornby sgomitola storie che sono anche episodi della storia di tutto il Paese e dilatano quella capacità di allacciare la visione d’insieme e la potenza del dettaglio che i lettori hanno già imparato a riconoscere nei suoi romanzi. Con “Piano nobile” prende vita il secondo capitolo della saga familiare cominciata con “Caffè amaro”. Le famiglie sono famiglie, e chissà ancora per quanto impediranno, nasconderanno, confonderanno.
Estratto
Parte prima
GIUGNO 1942
1.
Dice Enrico Sorci
La luce. La luce. Voglio più luce. Cerco dentro questa stanza tutto ciò che mi è familiare. Non mi era mai parsa tanto grande questa stanza. È come se il soffitto a cassettoni si fosse sollevato, sembra la volta ogivale di una cappella: altissimo. La dormeuse ai piedi del letto si allontana, e così le due poltrone e il comò. Anche il tempo si allarga, non capisco dalla luce che entra dai balconi se è giorno o sera. La strada, qui sotto, potrebbe essere una piazza, e non la via che attraversa longitudinalmente la città. E il mio letto sembra una parete su cui sto immobile come un geco. Ascolto il mio respiro affannato e il fiatare dei pensieri che arrivano da lontano e che il respiro accelera, incendia, incatena alla luce.
Elio mi ha letto le prime pagine dei quotidiani per giorni e giorni. Lui legge e io ascolto. Per dirgli di smettere devo fargli segno, perché ci sente poco, ma è una consolazione averlo accanto al letto, seduto in pizzo allo sgabello che si è portato dall’anticucina, mentre regge quasi con fatica i fogli grandi della stampa. Ci passa quel po’ di mondo che si può conoscere, per quelle pagine: siamo in guerra, la stampa è irreggimentata, pura propaganda, ma si citano nomi stranieri, generali, politici, luoghi, e sarebbe tutto solo noia se non li sentissi uscire dalle labbra sottili di Elio, ognuno irto di difficoltà, nomi stranieri che lui pronuncia a modo suo, non sempre azzeccandoci, con la voce forte di chi è debole d’orecchio. I giornali sono passati da quattro pagine a due, le notizie mascherate, incerte.
Elio dice Churchill, dice Rommel, dice Montgomery, e ogni volta che il nome gli esce in qualche modo dalla bocca leva contento gli occhi verso di me, poi incespica sui russi, Aleksandr Vasilevskij, Georgij Žukov, che gli si fermano in gola. Per non parlare dei nipponici, oscuri fonemi che tuttavia tornano e tornano perché dall’anno scorso sono i protagonisti assoluti – Pearl Harbor, detto da lui, diventa un arabeggiante Pellàibbor –, e si rilassa su nomi che addirittura potrebbero suonare italici, come Sebastopoli, Stalingrado, ma figurano rari nella prosa di questa guerra. Mussolini dice di tener duro in Africa mentre gli inglesi avanzano verso Tripoli. Siamo in mezzo al disastro. Solo quattro anni fa certi nomi erano esotici, ora sembra che tutto il mondo ci precipiti in casa, amici e nemici, senza più sapere chi siano gli uni e chi gli altri. Elio legge diligente e spegne con la sua voce forte ma pacata i toni reboanti di una nazione che continua a credersi un impero e di un impero che sembra uscito da un’operetta fin-de-siècle. Elio, caro Elio, non smettere di leggere, anche quando il mio sguardo si perde.
Vedo ancora bene. Vedo i muri con la carta da parati a ramages – oro, amaranto e verde, nello stile moderno che mi piace tanto – e le spesse tende dei balconi che riprendono il disegno; carta e tessuto che ricevemmo direttamente dalla ditta Liberty di Londra.
L’ordinazione l’avevo fatta su consiglio di Babs Farrar, cognata del segretario dei Whitaker. Non potevo non frequentarli i Whitaker, imprenditori vinicoli inglesi a Palermo da generazioni. Ma Babs era Babs, avanzava con tutto il biondo dei suoi capelli nel corridoio di casa Whitaker e mi riceveva. I primi tempi si limitava a farmi strada, a seconda delle occasioni, nel salotto grande o nello studio di Pip, ma poi cominciò a guardarmi con occhi diversi, e io pure, e così ne sortì una cosuzza, una cosuzza breve, ma bastò a rallentare il suo passo nel corridoio, a farla uscire in una risatina lunga e compiaciuta, a farla muovere verso mete che non erano né lo studio né il salotto. Babs, meravigliosa Babs, che pareva venuta giù da certi grandi quadri a soggetto storico che allora andavano per la maggiore, con fimmine pietose, eroiche, scarmigliate e grondanti di abbondanti capigliature e mantelli e pellicce. Babs era una Ginevra larga di petto e di sorrisi, un trionfo di forme così rare nell’isola di Albione. La nostra cosuzza breve si trasformò in vera amicizia duratura e continuammo a frequentarci anche al di là di Pip Whitaker. Con le inglesi non era difficile.
I Whitaker si erano costruiti a fine Ottocento una bellissima villa con giardino, Villa Malfitano. Noi Sorci avevamo il nostro palazzo settecentesco, ma i palazzi evocano gloria e autorità soltanto se delle pietre ci prendiamo cura, come mi disse mio padre quando mi fece venire a Palermo per occuparmi dei lavori di restauro. Anche per questo ho voluto aggiungere alle nostre proprietà un palazzo nuovo: ho buttato giù e ricostruito un caseggiato all’Albergheria, congegnato secondo un disegno che privilegiasse accessibilità e utilità rispetto al tradizionale bisogno di rappresentare.
Era una grande Palermo quella che conobbi allora con gli occhi di un diciassettenne che tutto aveva da apprendere. Il porto era un movimento costante di bastimenti e di genti, vi si parlavano tutte le lingue, vi si scaricavano merci con gran schianti metallici, roteare di gru, stridere di carri, tonfi di sacchi e cordame. Era una città dove veniva voglia di vivere e di conoscere. Come lo stile degli arredi, anche lo stile di vita chiedeva aggiustamenti, trasformazioni.
Tolta la concessione alla tappezzeria britannica, l’arredamento della mia camera è siciliano, dalla mobilia ai quadri. I paesaggi campestri e le marine sono opera di Francesco Lojacono, Antonino Leto e Michele Catti, appassionati della nostra isola e validissimi pittori, di cui divenni amico in gioventù.
Per mia moglie Rosaria era scandaloso appendere paesaggi in camera da letto. Credeva – così le era stato insegnato, così aveva visto in tutte le camere da letto di famiglie rispettabili – che dovessero esserci soltanto quadri di santi, oltre al crocifisso.
Mi impuntai, e le proposi un compromesso: lei avrebbe appeso santi, crocifissi e la Vergine Maria sulla parete del capezzale e su quella accanto al suo lato del letto, io avrei avuto mano libera su quella di fronte. Era docile, la mia Rosaria, e col tempo imparava.
Le piacque assai il dipinto a olio di Monte Pellegrino all’alba, visto dal mare di Sant’Erasmo. La luce mattutina spuntava dietro le montagne, sorvolava la piana di Palermo e colpiva la cima di Monte Pellegrino, lasciando intatte, sulle falde basse, le ombre della notte, azzurre, blu e viola; poi scivolava dalla cima del promontorio su mare e cielo, colorandoli di un rosa struggente, come se fossero un tutt’uno.
Rosaria mia, non ti dissi mai che il giovane Michele Catti, così sedotto dai morbidi colori della natura, così capace di restituirli, era un grande bevitore e morì anzitempo alcolizzato. Ti avrebbe sconvolto quella notizia, e non avresti più saputo apprezzare la purezza del dipinto.
Questa camera era il tuo regno. Per me, dopo la tua morte, ventidue anni fa, divenne l’ultimo avamposto della mia vita mortale. Nella morte ti rispettai più di prima; da allora non portai altre fimmine sul nostro letto – lo facevo d’estate, quando tu rimanevi in campagna e io di tanto in tanto mi allontanavo. Adesso, entreranno qui soltanto le tre che mi hanno offerto conforto negli anni senza di te; una è figlia mia.
I miei occhi perciano tempo e spazio. Sento tutti i rumori. Io sono io; e io sono il palazzo. E io sono la famiglia. Per quanto ancora? Avverto un’impalpabile presenza, una mano che si allunga dentro di me, e mi invita all’abbandono.
“Elio! Elio!” vorrei chiamare, ma in effetti non ne ho bisogno, ed è meglio che sia così, perché tanto Elio non ci sente. Eppure avrei domande. Vorrei sapere. Più il tempo si consuma e più mi sento esposto a due tentazioni: quella di sprofondare nell’indifferenza e quella, contrapposta, di sapere, di sapere tutto, come fossi – e lo sono stato – un giovane frequentatore di barbierie e caffè dove in un quarto d’ora ti sciorinano nelle orecchie quel che bisogna e quel che non è necessario sapere.
Chi c’è di là? Che fanno? Lo so chi c’è. Lo so. La mia vita si allunga come un treno, come una strada polverosa, bianca, afosa. Una folla c’è. O forse no, non c’è ancora nessuno. Che vengano avanti adagio. Dietro la porta sento una calca, un battere di piedi. Tutti vogliono entrare. Elio non è capace di contrastare quegli occhi, quelle mani che premono. Vorrei urlare: “Aspettate il vostro turno!”, “Rispettate un uomo che sta per morire!”, “Vi chiamo io, se e quando voglio!”, “Ubbidite! Come ho ubbidito io, da giovane, agli ordini di mio padre!”.
E me lo vedo tutto intero il padre nostro, quello che sta in terra, il padre che mi aveva ordinato, figlio cadetto, di occuparmi dei restauri di palazzo Sorci, a due passi dai Quattro Canti e dalla Cattedrale. Che cosa poteva fare un ragazzo di diciassette anni? Chissà che pensava mio padre, ma qualcosa pensava, e dal suo punto di vista pensava bene. Avanzava nel salone riccamente arredato con il passo sicuro del patriarca – dalle vetrate entrava la luce dorata del tardo pomeriggio –, avanzava e io leggevo nei suoi gesti il mio imminente destino.
Teneva un sigaro spento fra indice e medio, di tanto in tanto lo portava alle labbra ma senza mai accenderlo. Aveva occhi di carbone e sopracciglia cespugliose che gli salivano in fronte come neri rettili araldici. C’erano altre figure nella sala, certamente l’avvocato Tricase, nico nico, con un vestito marrone in cui sembrava svanire. Mio padre annunciò che era tempo di pensare al futuro della famiglia. L’erede era Nicola, Nicola era il maggiore, si sarebbe preso quel che gli spettava, e avrebbe dovuto sposarsi presto.
Era stata scelta per lui Mariastella Tripputi, erede della Zirritta, una fiorente miniera di zolfo, e dei terreni circostanti, oltre che di tante altre terre e tanti ex feudi comprati all’asta dei beni della Chiesa e del regno Borbone, confiscati dai Savoia nel 1866. Nicola, il primogenito, sarebbe rimasto ad assistere chi governava terra e miniere, e io sarei venuto qui, a Palermo. Avevo completato gli studi alla Regia Scuola Agraria di San Placido Calonerò, a Messina, ero giovane e privo di idee sul mio futuro, sapevo soltanto cosa volevo, e forse i denari di mio padre non mi sarebbero bastati mai: volevo godermi la vita, da ricco. E ci stavo bene, a sovraintendere i restauri di palazzo Sorci; ero speranzoso.
Allora, alla metà degli anni settanta, Palermo si svegliava. E io pure mi svegliavo, e anche gli affari: bisognava investire, importare macchine agricole, togliere le campagne al passato, perché l’agricoltura e i nuovi macchinari agricoli con motori a nafta e perfino elettrici erano il nostro futuro, avremmo guadagnato bene dalle esportazioni in tutto il mondo, non soltanto in Europa. Non sognavo, vedevo. E godevo. “Il figlio del barone Sorci” mi chiamavano, e bastava questo ad aprirmi le porte delle fimmine dei ricottari. Venivano dalla provincia i ricottari, e si guadagnavano da vivere gestendo puttane per un’ampia clientela di benestanti. Ma le loro non erano puttane qualsiasi, ciascuno aveva le sue, una proprietà da salvaguardare, e loro facevano da compagni e magnaccia. Spesso diventavano ricottari i ragazzi di provincia venuti a studiare in città. Imparavano presto a trovare per le loro puttane la clientela migliore, uomini facoltosi ai quali si vedevano i denari in tasca. Ogni ricottaro imparava anche a tenerne una tutta per sé, un giorno la settimana: dopo aver fatto l’amore con la sua bella – perché bella doveva essere, a suo maggior decoro, segnale di dominio e di intelligenza di mercato – la portava a fare il passìo sulla Marina, tutti e due vestiti a festa, a braccetto, pavoni, abili nell’esibire i privilegi del piacere.
I ricottari imparavano il mestiere e io imparavo a farmeli amici. Frequentavo osterie e postriboli, dimentico dei lavori al palazzo, dove lasciavo il capomastro a gestire gli operai. E fu così che la malavita vide l’opportunità di penetrare nel palazzo che avrei dovuto sorvegliare, senza che me ne rendessi conto. Perché, intanto, scialavo nei bordelli. Quanta seta, quante fimmine, quanto splendore. Le maniavo tutte, quelle del Nord, quelle delle isole, quelle più abili, le vecchie e le giovani. Quanto godimento. E rivedo volgersi di scatto verso di me la smagliante Estrella. Sì, è così che faceva: si muoveva sinuosa dandomi le spalle, nel chiuso del bordello o sotto il sole del passìo, e, come mi sentisse, felino, non perdere un suo passo, non si fermava, non rallentava, si limitava a piegare il collo, calare la testa, e rialzarla a guardia delle spalle, spingendo una taliata impudica verso di me, una taliata che pareva tornare in gabbia solo quando lei accelerava l’andatura, per indurmi a seguirla.
Trovavamo sempre un posto in cui stare. Io la maniavo e la baciavo mentre ancora lei si liberava con un sospiro di lacci e ganci. Estrella. Qualcuno aveva inventato quel nome per lei, forse il suo Peppino Muzzica, e le stava benissimo. Con lei mi piaceva fare l’amore di giorno, con le finestre aperte, appena protette di mussola ricamata, vederla maestosa e accogliente, i seni pieni di luce. Nelle belle pause dei corpi la facevo cantare, perché aveva una voce gentile, intonata, e sapeva certe canzoni di campagna che si era portata nella memoria, canzoni che aprivano quei pomeriggi ad altro piacere. Ma quelli erano anche i momenti in cui la mia Estrella diceva cose che sapevo già sui lavori nel palazzo di mio padre, e altre che il suo ricottaro non gradiva che io sapessi. Finché una sera mi mise in guardia anche da lui, dal suo uomo. Io le chiusi la bocca con un bacio a lingua lunga.
Qualcuno ben più potente di Peppino Muzzica non vuole che si facciano lavori, e quel qualcuno fa esplodere nel cortile del palazzo una bomba fatta in casa.
L’ Autrice

Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo nel 1945.
Vive dal 1972 a Londra ed è cittadina italiana e britannica.
Laureata in giurisprudenza all’Università di Palermo, ha esercitato la professione di avvocato aprendo a Brixton lo studio legale “Hornby&Levy” specializzato in diritto di famiglia e minori. Ha insegnato diritto dei minori nella facoltà di Scienze Sociali dell’Università di Leicester ed è stata per otto anni part-time Presidente dello Special Educational Needs and Disability Tribunal.
La Mennulara, il suo primo romanzo, pubblicato da Feltrinelli nel 2002 è stato tradotto in tutto il mondo. Da allora ha pubblicato diversi libri tra cui La zia Marchesa (Feltrinelli, 2004), Boccamurata (Feltrinelli, 2007), Vento scomposto (Feltrinelli, 2009), La monaca (Feltrinelli, 2010), Camera oscura (Skira, 2010), Il veleno dell’oleandro (Feltrinelli, 2013), Il male che si deve raccontare (con Marina Calloni; Feltrinelli, 2013), Via XX Settembre (Feltrinelli, 2013), Caffè amaro (Feltrinelli, 2016) e, con Massimo Fenati, la graphic novel de La Mennulara (Feltrinelli, 2018).
Ha inoltre pubblicato libri di grande successo legati alla cucina con una fortissima componente narrativa: Un filo d’olio (Sellerio, 2011), La cucina del buon gusto (con Maria Rosario Lazzati; Feltrinelli, 2012), La pecora di Pasqua (con Chiara Agnello; Slow Food, 2012) e Il pranzo di Mosè (Giunti, 2014).
Ha anche pubblicato La mia Londra (Giunti, 2014), una guida/memoir personalizzata di Londra e il racconto per ragazzi Rosie e gli scoiattoli di St. James (con George Hornby; Giunti, 2018).
Tutti i suoi libri sono stati best seller e hanno venduto in Italia più di un milione di copie.
È frequente ospite alla radio, alla televisione e sulle maggiori testate giornalistiche italiane.
Simonetta Agnello Hornby ha sempre cercato di legare la professione di avvocato e la sua scrittura all’impegno per sostenere le cause dei minori, delle vittime di violenza domestica e degli emarginati.
Il 2 giugno 2016 Il Presidente della Repubblica le ha conferito l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Grande Ufficiale.
Nel 2014 è stata protagonista, con sua sorella Chiara Agnello, della trasmissione “Il pranzo di Mosé”, su Real Time. Nel 2015 è apparsa con il figlio George Hornby, su Raitre, nel documentario reality show Io & George, un viaggio da Londra alla Sicilia per aumentare la consapevolezza dei problemi affrontati dai disabili.
Ha girato un docu-film per laeffe, Nessuno può volare, titolo anche del nuovo libro uscito per Feltrinelli nel 2017.
Nel 2017 ha contribuito con un racconto alla raccolta Un anno in giallo, Sellerio, insieme a Andrea Camilleri, Esmahan Aykol, Gian Mauro Costa, Alicia Giménez-Bartlett, Marco Malvaldi, Antonio Manzini, Santo Piazzese, Francesco Recami, Alessandro Robecchi, Gaetano Savatteri, Fabio Stassi.
Il 17 luglio del 2018 ha ricevuto dal Centro Regionale di Sant’Alessio, istituzione che fin dall’ottocento realizza attività volte all’inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, la Stella di Sant’Alessio “per aver saputo valorizzare, con il suo documentario Nessuno può volare, il mondo della disabilità e della disabilità sensoriale, attraverso l’incontro con le persone e le testimonianze storiche conservate negli archivi del Centro Regionale Sant’Alessio di Roma”.
Simonetta, figlia di un disabile e madre di George affetto da Sclerosi Multipla Primaria Progressiva, lo considera il premio più importante e significativo che le sia stato conferito.