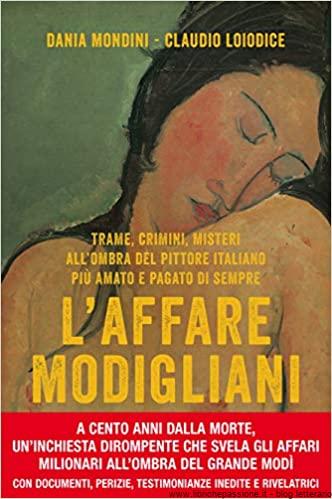Trama
Dieci anni possono cambiare una persona.
Sei sicura di essere ancora la stessa?
È passato un decennio da quando Nicolette Farrell ha lasciato la cittadina in cui è cresciuta per non tornarvi più, ma adesso il passato sembra chiamarla: forse perché è il momento di occuparsi di suo padre, ormai anziano e sprofondato nelle nebbie dell’età, da cui solo ogni tanto si risveglia. O forse perché il presente nasconde qualche insidia di troppo. Fatto sta che per Nicolette è il momento di rimettere piede a Cooley Ridge, anche se è un posto con cui non ha mai fatto davvero pace. Tutta colpa di Corinne. La sua migliore amica di allora. L’amica scomparsa. Il suo trauma mai elaborato.
Il ritorno a casa è un vero tuffo nel passato: Nic rivede dopo anni non solo il fratello Daniel, ma anche il suo ex Tyler, e quello che allora era il fidanzato di Corinne, Jackson. Erano solo dei ragazzi, all’epoca. Ed eccoli adesso, dieci anni dopo. Non sembrano cambiati: stesse dinamiche, stessi legami, stessi segreti sepolti nel passato. Ma quando un’altra ragazza, Annaleise, scompare in città, l’incubo di tanti anni prima ritorna. Perché la scomparsa di Annaleise ha più punti in comune con quella di Corinne di quanto chiunque riesca a immaginare…
Raccontato a ritroso, con un magistrale controllo di ritmo e plot, questo romanzo è stato una rivelazione in patria, e un grandissimo successo di pubblico, ancora oggi in classifica a distanza di più di due anni, e ha consacrato Megan Miranda come una delle stelle più brillanti del thriller psicologico americano.
Estratto
Ai miei genitori
PARTE 1
TORNARE A CASA
L’uomo si meravigliò anche di se stesso, per il fatto di non poter imparare a dimenticare e di essere continuamente legato al passato: per quanto lontano, per quanto rapidamente egli corra, corre con lui la catena.
FRIEDRICH NIETZSCHE, Considerazioni inattuali II
Cominciò con una telefonata, apparentemente innocua, facile da ignorare. Il ronzio sul comodino di Everett, la luce dello schermo, troppo forte nella camera che lui teneva completamente buia, con le tapparelle abbassate fino al davanzale e i vetri scuri come seconda linea difensiva contro il bagliore del sole e della città. Vedere il nome, silenziare il cellulare, girarlo a faccia in giù accanto all’orologio.
Però. Ormai sveglia, a chiedermi perché mio fratello telefonasse così presto di domenica. Passare in rassegna le possibilità: papà, il bambino, Laura.
A tentoni mi feci strada al buio, le mani che sfioravano gli angoli netti dei mobili fino a trovare l’interruttore della luce del bagno. I piedi nudi sulle piastrelle gelide mentre sedevo sul coperchio del water, il telefono premuto contro l’orecchio e la pelle d’oca che mi risaliva lungo le gambe.
Il messaggio di Daniel echeggiò nel silenzio: «I soldi sono quasi finiti. Bisogna vendere la casa. Però papà non vuole firmare i documenti». Una pausa. «È messo male, Nic.»
Non chiedeva il mio aiuto perché sarebbe stato troppo diretto. Non era da noi.
Cancellai il messaggio e scivolai di nuovo sotto le lenzuola prima che Everett si svegliasse, controllai con la mano che fosse accanto a me, per sicurezza.
Ma più tardi, appena rientrata a casa mia, presi in mano la posta del giorno prima e trovai la lettera indirizzata a Nic Farrell con la calligrafia a me familiare, in inchiostro blu; l’indirizzo invece l’aveva scritto qualcun altro, con una penna diversa e più scura.
Papà non mi telefonava più. I telefoni lo rendevano ancora più disorientato, troppo lontano dalla persona che stava cercando di identificare. Persino quando si ricordava chi stava chiamando, appena rispondevamo scivolavamo via dalla sua mente, nient’altro che voci incorporee nell’etere.
Aprii la lettera: una pagina d’agenda con il margine strappato, la sua scrittura che sconfinava oltre le righe un po’ inclinata a sinistra, come se avesse corso per fissare i suoi pensieri sulla carta prima che gli sfuggissero.
Niente convenevoli.
Devo parlarti. Quella ragazza. Ho visto quella ragazza.
Niente firma.
Richiamai Daniel, la lettera che ancora mi tremava in mano. «Ho appena ricevuto il tuo messaggio» gli dissi. «Torno a casa. Ho bisogno di sapere cosa sta succedendo.»
Giorno 1
Controllai un’ultima volta l’appartamento prima di caricare l’auto: valigie in attesa accanto alla porta; chiavi in una busta sul bancone della cucina; una scatola ancora aperta con dentro gli oggetti che avevo buttato dentro di corsa la sera prima. Dalla zona cucina potevo vedere ogni angolo dell’appartamento, eppure mi restava la fastidiosa sensazione di essermi dimenticata qualcosa.
Avevo sistemato tutto in gran fretta, concludendo le ultime settimane dell’anno scolastico mentre tenevo testa alle telefonate di Daniel e cercavo qualcuno a cui subaffittare casa mia durante l’estate: non avevo tempo per fermarmi a riflettere, per rendermi conto che lo stavo facendo davvero. Tornare a casa. Tornare là. Daniel non sapeva della lettera. Sapeva solo che sarei andata a dare una mano, che avevo a disposizione due mesi prima di riprendere la mia vita di qui.
Adesso l’appartamento era praticamente vuoto. Un contenitore industriale, spogliato di ogni calore, in attesa del giovane dottorando dall’aria vagamente affidabile che l’avrebbe occupato fino a fine agosto. Gli avevo lasciato i piatti, perché sarebbero stati complicati da imballare. Gli avevo lasciato il futon, perché me l’aveva chiesto e perché mi aveva dato cinquanta dollari in più.
Il resto – quanto meno tutto quello che non potevo caricare in macchina – era finito in un magazzino a pochi isolati di distanza. La mia vita intera in un box rettangolare, pieno di mobili dipinti e abiti invernali.
Qualcuno bussò alla porta e il rumore, echeggiando nella casa vuota, mi fece sobbalzare. Il nuovo inquilino non doveva arrivare prima di qualche ora. Ed era troppo presto per chiunque altro.
Attraversai la stanza e andai ad aprire.
«Sorpresa» disse Everett. «Speravo di beccarti prima che partissi.» Era pronto per andare al lavoro – lustro ed elegante – e si chinò per baciarmi tenendo un braccio nascosto dietro la schiena. Sapeva di dentifricio e caffè; amido e cuoio;
professionalità ed efficienza. Da dietro la schiena estrasse un bicchiere termico fumante. «Ti ho portato questo. Per il viaggio.»
Aspirai a fondo. «Sai come conquistarmi.» Appoggiata al bancone della cucina, ne bevvi una lunga sorsata.
Lui guardò l’ora e trasalì. «Non vorrei, ma devo scappare. Appuntamento mattutino dall’altra parte della città.»
Ci incontrammo a metà strada per un ultimo bacio. Gli strinsi un gomito mentre si allontanava. «Grazie» dissi.
Appoggiò la fronte contro la mia. «Finirà presto, vedrai.»
Lo guardai uscire – i passi decisi e misurati, i capelli scuri che gli sfioravano il colletto – e raggiungere l’ascensore in fondo al corridoio. Si voltò proprio mentre le porte si aprivano. Mi appoggiai allo stipite e lui sorrise.
«Guida piano, Nicolette.»
Lasciai che la porta si richiudesse, e la giornata mi piombò addosso, rendendomi braccia e gambe pesanti come macigni, facendomi formicolare le dita.
Sull’orologio del microonde i numeri rossi scorrevano e mi si strinse lo stomaco.
Sono nove ore d’auto da Philadelphia a Cooley Ridge, senza considerare il traffico, la sosta per il pranzo, le fermate per rifornimento e pipì. E dato che stavo partendo con venti minuti di ritardo rispetto al previsto, potevo già immaginare Daniel seduto in veranda a battere il piede in terra impaziente, mentre mi infilavo nel vialetto di terra battuta.
Gli mandai un sms tenendo la porta aperta con la valigia: Sono per strada, ma arrivo verso le tre e mezza.
Dovetti fare due viaggi per portare valigie e scatole fino all’auto, parcheggiata dietro l’angolo del palazzo. In lontananza sentivo il rumore del traffico dell’ora di punta, un rombo continuo sull’autostrada, qualche colpo di clacson. Un’armonia familiare.
Avviai il motore, aspettai che partisse l’aria condizionata. Okay, okay, pensai. Infilai il telefono nel portatazza da cruscotto e vidi la risposta di Daniel. Papà ti aspetta per cena. Non tardare.
Come se potessi arrivare addirittura con tre ore di ritardo. Quello era un vero colpo da maestro di Daniel: aveva perfezionato l’arte del messaggio passivo-aggressivo. Ci si allenava da anni.
Da piccola credevo di poter prevedere il futuro. Probabilmente era colpa di mio padre, che mi aveva riempito l’infanzia con frasi fatte che prendeva di peso dalle sue lezioni di filosofia, facendomi credere in cose che non potevano essere. Chiudevo gli occhi e le facevo apparire, fugaci e splendide visioni del futuro. Vedevo Daniel in toga e tocco. Mia madre che sorrideva accanto a lui attraverso l’obiettivo della macchina fotografica, mentre facevo loro segno di avvicinarsi. Mettile un braccio attorno alle spalle. Fate finta di volervi bene! Perfetto. Vedevo me e Tyler, anni dopo, che caricavamo i bagagli sul cassone del suo camioncino infangato, in partenza per il college. Per andarcene una volta per tutte.
Era impossibile per me immaginare a quel tempo che andarsene non sarebbe stata una semplice questione di salire su un camioncino e partire, ma un processo di escissione lungo una decina d’anni. Miglia e anni, ad aumentare lentamente la distanza. Senza considerare che Tyler non aveva mai lasciato Cooley Ridge. Daniel non si era mai laureato. E se anche lo avesse fatto nostra madre comunque non sarebbe sopravvissuta abbastanza da poterlo vedere.
Se immaginassi la mia vita come una scala, Cooley Ridge ne rappresenterebbe il fondo – una località senza pretese annidata al margine delle Smoky Mountains, la tipica ridente cittadina di provincia americana, ma priva di ogni fascino. Ogni altro posto, qualsiasi altro luogo, era uno scalino più in alto, da raggiungere con la costanza e il tempo. Il college duecento miglia più a est, l’università uno stato più a nord, il tirocinio in una città in cui avevo messo radici e che non avevo più voluto lasciare. Un appartamento tutto mio e il mio nome su una targhetta sulla scrivania, e Cooley Ridge continuava a essere il posto dal quale allontanarsi sempre di più.
Una cosa ho imparato sull’andarsene: non si può tornare indietro. Non so più che farmene di Cooley Ridge, e Cooley Ridge non sa che farsene di me. E la distanza non fa che crescere con gli anni.
Il più delle volte, se per qualche ragione cercavo di rimetterla a fuoco – Parlami di casa tua, parlami di dove sei cresciuta, parlami della tua famiglia, mi chiedeva Everett – quella che mi compariva in mente era una caricatura: una specie di presepe allestito sul tavolino d’ingresso per Natale, congelato nel tempo. E così fornivo risposte superficiali, piatte e prive di dettagli: Mia madre è morta che avevo sedici anni; è una cittadina ai margini del bosco; ho un fratello più grande.
Persino a me, persino mentre lo dicevo, sembrava un po’ poco. Una Polaroid che sbiadiva dai margini verso il centro, che perdeva i colori; la sagoma di una città fantasma piena di fantasmi.
Ma era bastata una telefonata di Daniel – «Bisogna vendere la casa» – per farmi mancare la terra sotto i piedi. «Torno a casa» avevo detto, e i margini si erano accartocciati: mia madre aveva premuto la guancia contro la mia fronte; Corinne aveva fatto dondolare avanti e indietro la nostra vettura al culmine della ruota panoramica; Tyler si manteneva in equilibrio sul tronco dell’albero caduto tra una riva e l’altra del fiume.
Quella ragazza, aveva scritto mio padre, e la sua risata mi fece battere forte il cuore.
Devo parlarti. Quella ragazza. Ho visto quella ragazza.
Un’ora dopo, o anche solo un momento dopo, probabilmente se n’era già scordato, aveva messo da parte la busta sigillata finché qualcuno l’aveva trovata abbandonata sul cassettone o sotto il cuscino e aveva poi recuperato il mio indirizzo dalla sua cartella. Ma qualcosa doveva aver agito da stimolo. Un ricordo. Un’idea sperduta fra le sinapsi del suo cervello; l’innesco di un pensiero che non aveva altro luogo dove andare.
La pagina strappata, la scrittura inclinata, il mio nome sulla busta…
E adesso qualcosa di tagliente e incontrollabile mi scorrazzava libero in testa. Il suo nome rimbalzava ovunque come un’eco.
Corinne Prescott.
In quelle ultime settimane la lettera di papà era rimasta ripiegata nella mia borsa, a galleggiare appena sotto la superficie della mia mente. Mi bastava infilare la mano alla ricerca del portafoglio o delle chiavi dell’auto e sfiorarne un bordo, tastarne un angolo, ed ecco che riappariva: lunghi capelli ramati che ricadevano sulle spalle, il profumo della gomma da masticare alla menta, il suo sussurro all’orecchio.
Quella ragazza. Per sempre quella ragazza. Quale altra ragazza poteva essere?
L’ultima volta che ero tornata a casa in auto era stato poco più di un anno prima, quando Daniel mi aveva telefonato per dirmi che dovevamo ricoverare papà in una residenza per anziani, e io non potevo permettermi di acquistare un biglietto aereo all’ultimo minuto. Era piovuto per quasi tutto il tragitto, sia all’andata che al ritorno.
Oggi, al contrario, era un giornata perfetta per guidare. Niente pioggia, nuvolosa ma non buia. Luminosa ma non accecante. Avevo attraversato tre stati senza fermarmi, città e uscite mi scorrevano accanto rapide e confuse; tutto ciò che mi piaceva del Nord sfrecciava al di là del mio finestrino. Mi piaceva quel ritmo, il fatto di riempire le giornate con liste di cose da fare, di avere il controllo delle ore e piegarle al mio volere. E l’insofferenza del commesso del negozio di alimentari vicino a casa mia, che non alzava mai lo sguardo dal suo cruciverba, non mi fissava mai negli occhi. Mi piaceva l’anonimato. Un marciapiede pieno di estranei e di infinite possibilità.
Guidare attraversando uno stato dopo l’altro mi faceva la stessa impressione. Ma all’inizio mi sembrava di procedere più veloce che verso la fine. Avanzando verso sud le uscite si facevano più rade, il panorama monotono, pieno di cose che mi sembrava di aver visto già mille volte.
Ero da qualche parte in Virginia quando il cellulare squillò nel portatazza. Cercai a tentoni nella borsa l’aggeggio per il bluetooth, continuando a tenere una mano ben salda sul volante, ma alla fine dovetti arrendermi e premere il vivavoce. «Pronto?»
«Ehi, mi senti?» la voce di Everett gracchiava, e non sapevo bene se fosse il vivavoce o una pessima ricezione.
«Sì, cosa c’è?»
Disse qualcosa di indecifrabile, le parole smozzicate andavano e venivano…
Megan Miranda ha studiato al MIT, e vive in North Carolina. Ogni ragazza perduta è il suo primo thriller, che è stato un importante bestseller internazionale. Ha scritto anche diversi romanzi per ragazzi.
meganmiranda.com