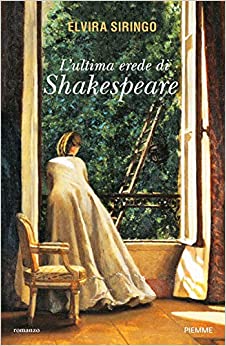
Trama
Messina, 1580. Michelagnolo Florio, figlio di Giovanni, un medico ebreo di grande fama, e di donna Memma, di nobili e cattoliche origini, un giovane dotato di gran cuore e intelletto, per questo i genitori, fuggiti da Palermo per poter vivere insieme, sognano per lui un destino sulle orme del padre. Ma la persecuzione contro gli ebrei e l’inclinazione del figlio a poetare e narrare, intrattenere gli animi piuttosto che a curare le ferite dei corpi, segneranno il suo destino per sempre. Un lungo peregrinare per l’Italia, prima a Milano e Verona, poi oltralpe, in Francia – sempre inseguito da vicende drammatiche, sempre assetato di conoscenza – lo porterà infine a raggiungere l’Inghilterra, dove il cugino più celebre, John Florio, lo presenterà alla corte della regina Elisabetta I. Messina, oggi. Elisabetta Villa ha smesso ormai da tempo di sognare. Rimasta sola al mondo, il grande palazzo di famiglia ereditato dal padre le sembra una prigione come tutti gli antichi scritti che contiene. Quando, però, il suo professore di un tempo le dice di avere una rivelazione importante sul passato della sua famiglia, il suo interesse si accende. Ma, dopo la conferma del loro appuntamento, del professore non risulta esserci traccia. Nel suo albergo è rimasta solo una cartelletta contenente strani e disordinati fogli di poesie in quello che sembra siciliano antico. Quei fogli e l’incontro apparentemente casuale con un vecchio Sir inglese saranno l’inizio di un’avventura mozzafiato sulle tracce di un passato che potrebbe cambiare la sua vita, e la storia della letteratura, per sempre.
Estratto
Questo romanzo è un’opera di fantasia. I fatti storici narrati sono liberamente interpretati dall’autrice.
A Roberto, fuoco d’inverno,
a Davide, vento di primavera,
a Carlo, acqua d’estate,
a Giuseppe, terra di partenza
e approdo, nell’autunno della mia vita.
If you can dream – and not make dreams your master,
If you can think – and not make thoughts your aim,
…
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
And – which is more – you’ll be a Man, my son!
RUDYARD KIPLING, Rewards and Fairies
PARTE PRIMA
Il mondo non deve sapere
LA FAMIGLIA CROLLALANCIA
Si displicuit sententia, fremitu aspernantur;
Sin placuit, frameas concutiunt.
“Se il parere non è piaciuto, lo respingono mormorando;
Se è piaciuto scrollano le lance.”
(TACITO, Germania, cap. 11)
Messina 1580
«Troppu traficu ppi nenti?» Filippo Spira ridacchia seduto dietro al bancone. «Tu l’hai letta?» chiede al fratello maggiore indaffarato a rassettare e ramazzare la bottega prima della chiusura.
«Ci ho dato uno sguardo e non ci ho capito una mi…» si contiene imbambolato fissando la ragazzina che entra in bottega «mizzica, niente.»
Ha le guance arrossate e le trecce sulle spalle, ansima ancora, ha fretta di ritirare le stampe commissionate dal padre per promuovere l’uso portentoso di certi unguenti. Girolamo non può staccare gli occhi dalla figura, quel petto pieno si solleva debordando ritmicamente dal pizzo della scollatura, funziona meglio di qualsiasi medicinale. La figlia dello speziale è ogni giorno più donna, però da quando il suo innamorato ha dovuto lasciare Messina s’è illanguidita, amplificando il fascino seduttivo. Quando va via, Girolamo chiude la bocca e si ricorda di respirare.
«Qua c’è scritto che è d’un certo messere Michele Agnolo Florio Crolla Lancia, lo conosci?»
«Io no» si spazientisce Girolamo, sospetta che il nome corrisponda al moccioso per il quale spasima la ragazzina. Getta in un angolo la scopa e assesta uno scappellotto al fratello. «Vuoi stare fermo?».
Filippo ha la risata facile e il vizio di dondolarsi troppo, in bilico sui piedi posteriori della seggiola.
«Va be’,» atterra e sembra serio «certo che ce l’ha bello lungo» sbuffa di nuovo a ridere «il nome. Però è meglio che stiamo attenti che, se parla di cose di religione, finiamo ai remi.»
«No, non mi è sembrato, anzi, è una storia buona per te, parla di corna.»
«E allora? Che mi vuoi significare?» Filippo scatta in piedi, sua moglie è bella e chiacchierata.
«E perché ti scaldasti? Fammi finire, volevo dire che è da ridere. Di corna, da ridere.»
«Io nelle cose di corna non ci trovo niente da ridere» borbotta tornando a sedersi «e poi vedi che prima o poi anche a te ti capita. E poi rido io, poi.»
«Comunque l’invalido spagnolo, quel Miguel de Cervantes, ha pagato bene» Girolamo Spira agita in aria un sacchetto tintinnante. «Qua ci sono monete d’oro per carta, inchiostro e offerte a Roma, caso mai a tua moglie ci vuoi far cancellare qualche peccato.» Si abbassa in tempo per scansare la matrice di piombo che l’altro gli lancia in direzione della fronte.
«Certo, dalla Spagna non vengono solo papisti.» Filippo si gratta la nuca. «Che dici, prima non è meglio che la facciamo leggere a fra’ Nicola?»
Sono ancora al via e un atto di censura sarebbe un disastro, li costringerebbe a chiudere, forse a scappare da Messina. Un peccato perché la bottega va bene, sono i più attrezzati della Sicilia e hanno investito i risparmi in torchi nuovi, matrici, inchiostri, quintali di carta e presse da stampa.
Fra’ Nicola riceve il manoscritto con un vassoio di paste, due giorni dopo accetta una botticella di passito e annuendo un benestare aggiunge che non gli sembra un’opera originale, poi gradisce due capponi e due ceste di olive sentenziando che la trama è scopiazzata. Infine, accetta la borsa di monete per il convento e decreta che non contiene eresia, precisando però che è solo una scimmiottatura d’infimo gusto del Romanzo di Calliroe, di Caritone d’Afrodisia.
Filippo Spira prende a leggersela nei ritagli di tempo, cercando di capirci qualcosa. Fra’ Nicola ha ragione, è una commedia volgaruccia e stravagante, innocua come il danaroso e bislacco soldato spagnolo ripartito per la sua patria. Una vicenda contorta, un singolare linguaggio che mischia inflessioni orientali, turche e castigliane, infarcito di doppi e tripli sensi siculi, con vocaboli latini, greci e pure arabi, tipica di chi ha la prerogativa di aggrovigliare ciò che è semplice. Proprio per questo la crema intellettuale siciliana, magari, l’apprezzerà. Segnerebbe la buona sorte anche per loro, diventerebbero stampatori di tendenza.
“Speriamo, il nostro lavoro di rischio è. Editori, siamo” conclude Filippo fra sé. “E se non dovesse avere successo, pazienza, lo spagnolo ci ha già pagato e noi non rischiamo di fare troppu traficu ppi nenti”. E a furia di ridere e dondolarsi, finalmente, cade giù dalla sedia.
La commedia va in stampa pochi mesi dopo, ma l’autore non può averne notizia. L’hanno avvisato all’ultimo istante, non ha avuto tempo di salutare l’amico invalido, gli ha scritto in fretta un biglietto d’addio unito a un plico con alcuni fogli dai margini bruciacchiati. Ha incaricato la Barbara di recapitarli al poeta spagnolo, al Grande Spedale. È partito piangendo, con l’unica magra consolazione che la consegna sia andata a buon fine, infatti un cavallo ha inseguito la loro carrozza fin quasi allo stretto e un giovane servo gli ha recapitato in contraccambio un rotolo di fogli scribacchiati in rima spagnola.
È accaduto tutto fin troppo in fretta, da quella sera così simile a tante altre, destinata invece a essere l’ultima.
Dalla finestra spalancata sulla pergola sale la dolcezza dello zibibbo, donna Memma Florio, nata Crollalancia, se ne inebria, il suo sguardo fugge fra agrumeti e vigneti delimitati da muriccioli a secco, armati di fichidindia, risale il litorale, segue il fremito di ulivi e carrubi percossi dallo scirocco lungo il perimetro orientale. I paesi sono piccoli presepi, riverberano miriadi di tremuli lumini a punteggiare la costa. Oltre lo stretto di Messina, l’ombrosa Calabria si impone sullo slargo di cobalto ricamato di lampare e inargentato di luna.
Memma increspa le labbra e strizza le ciglia negando loro l’autorizzazione a inumidirsi, percorre le linee di grigiore che sfumano dalle nubi al riflesso plumbeo sulla falce del porto. Il molo grande è gremito di navi.
«Giovanni e Michelagnolo rincaseranno, come ogni sera.» Continua a ripeterselo, quasi che il dire possa forgiare la realtà.
Scorgerà due puntini confusi fra la folla brulicante e poi sempre più nitidi, a sedare il sussulto d’ansia che le pesa sulla bocca dello stomaco. Alla composta dignità impartitale fin dalla nascita, mal s’accorda la trepidazione. Chi non fosse di rango la chiamerebbe paura, ma Memma sa mantenere una maschera adeguata a ogni circostanza, è cresciuta con la presunzione di dirigere il corso del destino. In tutta Messina e dintorni la sua forza è nota, la fa degna del suo uomo, l’illustre Giovanni Florio, medico riverito e rispettato dai potenti. Ma ora presagisce che il benessere stia per mutarsi in lontano ricordo, prova un’impotente fragilità. Un’ala fredda li sfiora, gli strali di santa romana chiesa colpiscono il guscio di onorabilità costruito con anni di fatica.
Un alito sale dal mare e le appiccica al volto un lembo del tendaggio, sfoga la stizza sulla seta. Si ricompone asettica, ostenta labbra strette all’ingiù e occhi socchiusi controluce, verso la superficie opaca fra le navi. L’acqua è immota, le banchine formicolano invece. Marinai, mercanti, ladruncoli e mendicanti, mischiati alla sozzura di schiavi incatenati a due e a tre, scivolano fra i malati viscidi intorno alle passerelle di sbarco.
Approdano navi commerciali e da corsa, si stipano, ammainano le vele, scaricano umanità, merci e da ultimi i corpi sanguinolenti, trascinati sui teloni, ammassati su carri in spola incessante dal molo al Grande Spedale. Cumuli di carne infedele, membra purulente e stremate che esalano una cupola di tanfo. Le sante vittorie contro il flagello turco hanno rimpolpato le file di rematori e più che mai il trionfo di Lepanto contro la Sublime Porta ha reso il Mediterraneo un mare colore del vino.
L’occidente guarda ora al suo interno e scopre gli orrori di una cristianità dilaniata da nuove minacce, cospirazioni, tradimenti. Si attrezza a rispondere con strumenti adeguati, sofisticate torture, affinché i nemici smembrati rendano piena confessione d’eresia, la più ingiuriosa è la richiesta della libertà di fede, è un’arroganza da estirpare senza pietà. Straripa da tempo per le vie di Messina che, coi suoi sessantamila abitanti è una delle più potenti città al mondo, è scalo di flotte, mercanti, feriti e prigionieri sulle rotte per la Terrasanta. Le nuove rotte oceaniche corrodono i commerci nel Mediterraneo ma non riescono a intaccare la fiorente perla del Sud che, pur non strappando a Palermo il titolo ufficiale di prima città della Sicilia, è diventata nei fatti l’indiscussa capitale del Rinascimento. È culla di menti eccelse, dal mirabile Antonello al genio d’erudizione Costantino Lascaris, da Moretti a Montorsoli, i gesuiti vi hanno fondato una gran scuola, il loro primo collegio, e valenti architetti e ingegneri l’hanno dotata di un moderno acquedotto, un piano regolatore e splendidi edifici di muratura ornati di fregi delle migliori scuole. Memma è proprio fiera d’averla scelta come città elettiva.
Dalla nuvola d’indistinto vociare si leva fino al suo balcone la cantilena dei mercanti: «Puru la sita ora si travagghja, la bedda sita, calzi pì donna e signurini, vesti e cammisi pì l’omu di vita».
I banniaturi espongono raffinati drappi di seta, diretti alla piazza franca della fiera agostana. Lungo la via grande sfilano altri carri carichi di vettovaglie. I buoi trascinano anche l’eco di lotte furibonde, i mercanti raccontano che a Trento si scrive un libro, un elenco di castighi esemplari per i trasgressori dell’ortodossia cattolica. Si dice pure che da Madrid giungeranno presto i relatores de causa a processare le streghe.
I primi a entrare in subbuglio erano stati i francescani, da giorni paventavano l’imminente arrivo del reverendissimo Françisco Peña, l’inflessibile inquisitore contro i frati viziosi colti a introdurre donnucole prope porta conventus, il più feroce propugnatore di scomuniche e condanne ai ferri sulle triremi. Perciò papa Gregorio aveva inviato al loro convento il vicario generale Antonio Fera, per veloce supervisione e preventiva pulizia. Così il frate guardiano aveva sbattuto con forza l’anello d’ottone contro il muso leonino del palazzo Florio e aveva restituito il ragazzo alla famiglia, con tante scuse e senza preavviso. Non potevano più rischiare di tenersi il piccolo Michelagnolo, di cuore e intelletto smisurati come la lingua, dotato pure di un ulteriore attributo non altrettanto evidente ma inequivocabile.
«Nell’eventualità di un’ispezione accurata, sarebbe imbarazzante spiegare a sua eccellenza il vicario la presenza di un piccolo sefardita fra le mura del nostro convento.» Con un’alzata di spalle il frate si era girato sui sandali ed era sparito.
Dopo otto lunghi anni donna Memma, arginato il velo di commozione, l’aveva riabbracciato. Sebbene il pupo dalle gote lanose la sopravanzasse d’una spanna, l’aveva lietamente stretto al seno sbaciucchiandolo, sopraffatta da un insolito impeto che aveva sorpreso tutti. Non le succedeva quasi mai di perdere il controllo, eccetto che per rari stravolgimenti, come quando molti anni prima aveva indotto al disonore la sua cattolicissima famiglia Crollalancia.
Era un ricordo sbiadito: Memma, detta allora Mina o Guglielmina, si era lasciata rapire. Un conturbante avventuriero l’aveva strappata da Palermo per trapiantarla a Messina. Lui era un Florio, un medico appartenente a una fiera famiglia ebrea fuggita dalla Spagna in seguito alle persecuzioni. In Italia il loro albero, traboccante di Giovanni e Michelangeli, si era scisso in due rami.
Avevano dei lontani cugini a Siena, sapevano di un certo fra’ Paolo Antonio che, gettato il saio alle ortiche, era tornato a essere Michele Angelo ed era migrato in Inghilterra, in cerca di libertà. Ma aveva incontrato il suo destino, più per necessità che per convinzione. Una pragmatica dama inglese l’aveva messo dinanzi al fatto compiuto concependo un piccolo Florio ed essendo amica del segretario di corte sir William Cecil, gli aveva procurato anche un bel lavoro di pastore protestante con uno stipendio di venti sterline l’anno.
Invece, dal ramo siciliano era fiorito il suo Giovanni. Nato e cresciuto a Palermo, non si era mai occupato di questioni religiose e dai suoi avi aveva preferito ereditare solo il patrimonio laico di scritti misterici, dottrine esoteriche, chimico-alchimistiche e mediche.
Quando la signora madre Crollalancia s’era ammalata, il vecchio medico di famiglia aveva sentenziato: «Male di femmina, femmina anziana. Ci vuole tempo e pazienza» e le aveva attaccato le sanguisughe. Era andata avanti per un mese senza miglioramenti. Anzi, un deperimento progressivo l’aveva divorata. Avevano indugiato troppo, prima di decidersi a chiamare il dottor Florio. Dal primo istante la giovanissima Mina, già promessa sposa al futuro governatore spagnolo Aragona-Tagliavia, ne era stata travolta. Giovanni però era arrivato tardi.
Il lutto aveva costretto Guglielmina a rimandare le nozze con il regale rampollo. Pur costernata, aveva esultato negli anfratti dell’animo, perché ogni incontro con il nobilissimo impomatato le produceva un sano e rivoltante disgusto. Tuttavia, sarebbe stato inconcepibile sollevare obiezioni all’unione, entrare a far parte di un così alto rango sarebbe stata una fortuna per tutta la famiglia. All’approssimarsi della nuova data di nozze, Mina si sentiva rimescolare, non digeriva, aveva la nausea, nel sonno smaniava e si svegliava sudata.
«Male di femmina,» dicevano tutti «di femmina giovane, però. Col matrimonio passerà.»
La Barbara, sua dama personale, l’accudiva come un’ombra e le somministrava cataplasmi e consigli di saggezza popolare. Così, in pochi giorni Memma era assai peggiorata, colta da una strana febbre, complice il trinciato di tabacco sfregato sotto le ascelle. Avevano dovuto posticipare ancora, contrariando il damerino indispettito.
Temendo allora che finisse come la signora madre, la famiglia aveva chiamato a curarla il giovane medico. Fin dalla prima visita Mina si era sentita meglio, e anche Giovanni. Mai visto uno sguardo così profondo e febbricitante insieme, una pelle così levigata, un ventre così morbido, quasi un burro al tatto, un seno così candido e opulento. La malattia si era protratta rendendo necessarie frequenti visite. Giovanni al principio la chiamava signorina Guglielmina, col passar del tempo erano entrati in confidenza.
«Memma, posso chiamarti Memma?» aveva mormorato all’orecchio una sera. «Così faccio più presto.»
«Certo, ma non c’è necessità che tu faccia tutto più presto» aveva sussurrato lei allargando le braccia e anche le gambe, per offrirsi docilmente a un secondo controllo più accurato, mentre la Barbara era distratta e affaccendata nella camera accanto…
L’ Autrice

Elvira Siringo è nata a Siracusa, dove vive, lavora e scrive. Insegna filosofia e storia presso il Liceo Quintiliano della sua città. È sposata e ha tre figli. Si dedica alla scrittura da sempre, da giovanissima ha collaborato al quotidiano Il Diario ed è stata fra i soci fondatori del settimanale cattolico Cammino.
In anni più recenti ha pubblicato alcuni contributi su riviste di storia locale, confluiti poi nel saggio storico Sogno di indipendenza. È inoltre autrice di racconti e di alcuni romanzi.
I suoi interessi attuali sono tutti rivolti all’età shakespeariana, ha condensato i frutti degli ultimi anni di studio in Il Codice Shakespeare (autopubblicato), in seguito al quale è stata ammessa a far parte della IASEMS (Italian Association of Shakespearean and Early Modern Studies).
Dal felice incontro fra le vicende storiche inglesi e quelle siciliane, è scaturito l’intreccio del suo ultimo romanzo, L’ultima erede di Shakespeare.






