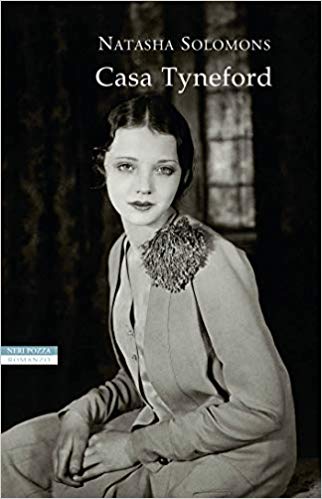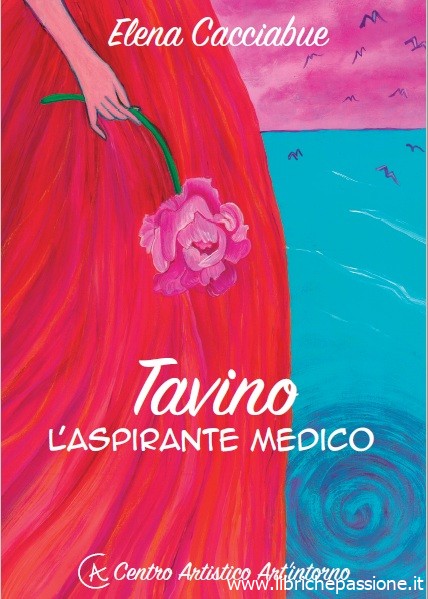Sinossi
Sicilia fine Ottocento. Costanza Safamita è l’unica figlia femmina di una ricca famiglia di proprietari terrieri, tanto amata e protetta dal padre, il barone Domenico, quanto rigettata dalla madre. Con la sua chioma di capelli rossi e il suo aspetto fisico quasi “di un’altra razza”, cresce fra le persone di servizio, fra l’orgoglio paterno del sangue e le prospettive alquanto ridotte della vita in provincia. Sarà lei, per volere del padre, a ereditare le sostanze e il prestigio della famiglia. Affronterà la mondanità palermitana e una vita coniugale in equilibrio tra l’amore per il marito e l’impossibilità di abbandonarglisi, saprà affrontare i capimafia e contenere lo sfascio della famiglia, in un mondo arcaico e barbarico, fotografato nel momento della fine.
Estratto
Agli hornbini, nati e nascituri, e alla loro bisnonna.
Non aspettarti nulla che non venga da te.
LUIGI PIRANDELLO (dal libro degli ospiti della baronessa Maria Giudice).
Parte prima
1
“A vecchi e picciriddi Dio l’aiuta.”
Dicembre 1898. Alla Montagnazza Amalia Cuffaro,
balia di Costanza Safamita,
conversa con la nipote Pinuzza Belice mentre le fa la treccia
Amalia Cuffaro aveva finito di imboccare Pinuzza con la poltiglia di pane duro e latte di capra. Le sollevò un lembo del tovagliolo allacciato al collo e le strofinò bocca e mento, poi lo scotolò energicamente a terra – Pinuzza sbavava e spesso sputava il cibo, anche quello di cui era golosa – e infine, con l’indice, fece cadere a terra il pane che Pinuzza si era sputacchiata sulla spalla. Le formiche erano in agguato: la colonia più folta si era insediata dentro la pietra concava dove era riposta la quartara dell’acqua; da lì uscivano in formazione compatta verso quel ben di Dio che ogni mattina cadeva dall’alto. Amalia meditava scoraggiata: se ne buttava assai di pane e latte, in quella casa dove abbondava soltanto la fame; male formiche erano, di razza guerriera, con il corpo grosso e la testa rossastra, di quelle che pizzicano, sfacciate al punto da arrampicarsi sulla seggiola su cui Pinuzza era legata. Le scorrazzavano addosso, lasciandole la pelle piena di puntini rossi.
Le aveva trovate persino dentro la bocca di quella poveretta che non poteva difendersi e aveva dovuto cacciarle le dita fra i denti per toglierle, quelle ardite bestiacce.
Ancora agile nonostante l’età, Amalia si rizzò nel mezzo della grotta, a gambe larghe, pronta a riprendere la incessante e tenace lotta contro le formiche; si piegò in avanti e si passò il braccio in mezzo alle gambe per afferrare l’orlo della sottana; rialzandosi, lo tirò sul davanti e se lo infilò nella cintura, trasformando la veste in un paio di ampi pantaloni orientaleggianti. Poi prese le corte foglie di giummara che fungevano da scopa e si accovacciò, facendo attenzione che la gonna restasse sollevata da terra e neppure una di quelle formicacce potesse salirle addosso. Spazzava con cura, scompigliando le file di formiche che da tutti gli angoli della grotta convergevano verso la seggiola di Pinuzza.
Spinse il mucchietto di immondizia brulicante di formiche impazzite sul minuscolo spiazzo davanti all’ingresso e finalmente, con un ultimo colpo di scopa, lo fece cadere nel precipizio: polvere, molliche e formiche.
Dopo la prematura morte della padrona, Amalia aveva rifiutato di raggiungere il figlio Giovannino in America ed era ritornata in famiglia. Il fratello minore, Carmine Belice, se l’era accollata per dovere, di malavoglia, perché dopo la morte dei suoceri e la partenza di Giovannino Amalia aveva sperperato lo stipendio e anche la roba regalatale dai Safamita ed era tornata a casa Belice nuda e cruda come l’aveva lasciata quarant’anni prima per sposare Diego Cuffaro. Posto per Amalia non ce n’era a casa Belice – due catoi in cui dormivano e vivevano ammassati in otto, più galline, capra e asino – e il fratello l’aveva sistemata in quella grotta con Pinuzza, alla Montagnazza, dove non c’era padrone a cui pagare affitto; inoltre, come diceva ai curiosi e alle malelingue, un dottore aveva suggerito che l’aria fresca e il sole avrebbero giovato alla salute della figlia.
Su quel litorale della Sicilia si snodava un candido costone di marna alto circa duecento metri e lungo una decina di chilometri, le cui falde erano ricche di fessure e grotte naturali. A volte si insinuava nel mare penetrandovi a mo’ di promontorio, altre volte si curvava ritraendosi nell’entroterra, creando spiaggette e piccole insenature. In una di queste si trovava Riporto, il villaggio di pescatori più vicino a Sarentini, in cui vivevano Carmine Belice e la sua famiglia. Da tempo immemorabile le popolazioni indigene si rifugiavano nelle caverne naturali della Montagnazza – come la gente del luogo chiamava il costone –, ampliandole e scavandone di nuove per sfuggire alle razzie dei pirati barbareschi e dei corsari turchi. L’accesso era impossibile a chi non ne fosse a conoscenza: infatti soltanto i rinnegati riuscivano a raggiungerle e a strappare dalle caverne i cristiani destinati alla schiavitù dei turchi. Poi gli attacchi nemici si erano diradati e dalla metà del Settecento di incursioni barbaresche non ce n’erano più state.
Con la crescente miseria del popolo, le grotte si erano ripopolate ed erano abitate da latitanti, fuggitivi e giovani renitenti alla odiata leva imposta dal governo unitario; ai cosiddetti piani bassi, più accessibili, si era insediata una piccola colonia di poveracci, infermi, emarginati e gente di passaggio. Avevano scavato scalinate ripidissime e insidiose, che la pioggia smussava o addirittura distruggeva con implacabile regolarità trasformandole in pericolosi scivoli. In alcune zone le bocche delle grotte erano state ampliate in apparente simmetria e ci si arrivava per strettissimi corridoi d’accesso a picco sul precipizio. Dal mare, questa parte della Montagnazza appariva di giorno ai naviganti come la candida facciata ondulata di un palazzo lunghissimo; di sera, dopo il tramonto, quando bruciavano le lampade a olio, come un grasso verme fosforescente. Il resto del costone piegava a sud e penetrava a picco sul mare. Indomito, si concedeva come rifugio agli uccelli marini e, in primavera e in autunno, a quelli migratori, come posto di sosta. Battuto dal vento e dalle piogge in inverno, abbagliante e quasi incandescente sotto il sole in estate, era sempre bellissimo. Ad Amalia ricordava una immensa, lucida quagghiata di latte di pecora tremolante e liscia, appena sformata dal pastore.
Zia e nipote vivevano in una di queste grotte, l’unica della terza fila, quella immediatamente sotto il pianoro. La monotonia delle loro giornate era interrotta dalla visita settimanale di Carmine Belice o dei fratelli di Pinuzza, che portavano cibo e legna. Era un’esistenza dura, ma Amalia era grata di essere sfuggita al tugurio del fratello, dove non riusciva più ad adattarsi dopo aver vissuto per tanti anni nei palazzi dei nobili. Amalia amava la solitudine e la natura e sulla Montagnazza ne aveva in abbondanza; inoltre Pinuzza era una compagnia costante e anche gradevole. Era riuscita perfino a guadagnare qualcosa rammendando le robe delle fimmine di sotto, che venivano passate su e giù con un paniere attaccato a una corda, e poteva concedersi il suo unico lusso: la Revalenza Arabica, una polvere ricostituente a cui attribuiva tutte le proprietà immaginabili.
In quanto a Pinuzza, a paragone di Riporto la Montagnazza rappresentava un miglioramento. Era stata calata nella grotta dal padre e dai tre fratelli, avvolta in una coperta ripiegata a mo’ di culla e legata come un bozzolo all’estremità di una grossa fune che due fratelli si erano attorcigliati attorno al corpo e che allungavano a poco a poco mentre il terzo scendeva assieme a lei lungo le pareti della Montagnazza, aggrappandosi ai chiodi infissi qua e là nella marna per guidare il suo involucro ed evitare che gli spuntoni aguzzi facessero male alla sorella. Così Pinuzza era passata dalla prigionia del catoio, umido e quasi privo di luce, a quella della grotta. Lì le cure della zia, l’aria salubre e il calore del sole l’avevano rinvigorita.
Pinuzza era in attesa del rito giornaliero della pettinata. Aveva quattordici anni; nonostante l’infermità nutriva speranze e desideri come qualsiasi altra giovanetta e anticipava il piacere di sentirsi in ordine. Amalia le pulì ancora una volta la bocca sbavazzata con uno straccio umido, poi sollevò la seggiola e la posò con cautela davanti all’ingresso della grotta.
Pinuzza aveva dinanzi a sé mare e cielo, null’altro. Il sole invernale era piacevolmente caldo. “Oggi ti spidocchio e ti rifaccio la treccia,” disse la zia, e la nipote sorrise. Amalia prese un grosso pettine d’osso dall’impugnatura intarsiata con una decorazione in madreperla e cominciò a spidocchiarla usando la parte a denti fitti. Quel corpicino sofferente e contorto aveva una sola bellezza: la chioma nera, lucida e folta. Amalia allargava i capelli della nipote con dita agili, leggere e sicure, come se le ciocche della grossa treccia fossero fuselli e lei stesse ricamando un merletto al tombolo. Era un momento di particolare intimità per entrambe: Amalia tornava ai suoi ricordi più belli e le si scioglieva la parlantina; Pinuzza l’ascoltava incantata.
“Quando la marchesa era carusa non si voleva pettinare. Ci volevano ore per persuaderla. Non aveva torto, perché i suoi capelli erano ingarbugliati assai, non come i tuoi, che sono docili e lisci. Soltanto quando la mettevo a sedere alla finestra e ci aveva davanti, lontano, il mare, solo allora potevo pettinarla com’è di giusto.”
“Perché?” domandò Pinuzza.
“Capelli speciali aveva, quella. Non erano buoni di qualità, con tutto che sangue di baroni ci aveva nelle vene: erano duri come crine e arricciati come lana scucita, più li allisciavo più si increspavano, non si potevano tenere rassettati e le scappavano anche dalle trecce. Ma il colore… che meraviglia! Aveva i capelli rossi come l’oro da piccola, un sole di mezzogiorno erano; come lei cresceva cambiavano di colore, sempre più scuri, come lo zolfo raggrumato nelle pietre; e quando diventò fimmina passarono al rosso cupo del tramonto, con riflessi di rame. Quando il sole le batteva sulla testa, dalle trecce si sprigionavano bagliori come quelli delle braci dei ferri da stiro.”
“Belli dovevano essere, e di innamorati ne doveva avere tanti,” sospirava Pinuzza.
“Invece no, alla gente non piaceva, era differente assai. Si fermavano per strada a guardarla, quando passava in carrozza, e incrociavano le dita per scaramanzia: chi è diverso non piace, io il perché non lo capisco, ma così è.” Amalia si interruppe, le ciocche lucide tese sulle dita, lo sguardo perso sull’orizzonte.
“Ma a lei piacevano i suoi capelli, o no?”
Amalia riprese a intrecciare, lentamente. “Sai che ti dico?, non lo so. L’amai come se fosse mia figlia e l’ho servita fino all’ultimo, ma tante cose di lei non le conosco: il fatto è che era diversa da tutti, dai Safamita, dagli altri nobili, dalla gente come noi…” Amalia si rendeva conto di divagare, era un discorso che faceva con se stessa.
“Ma a lei piaceva essere diversa dagli altri?” incalzava Pinuzza.
“I nobili sono diversi dagli altri in ogni caso e questo soltanto piacere può dare a loro. Prima di tutto non conoscono la miseria e la fame e fanno quello che vogliono, e poi…
Se questa storia vi incuriosisce e volete acquistare questo romanzo a un’offerta speciale di 7,00 euro invece di 9,50 euro cliccate sul link in basso
Il mercatino dei libri usati. Tantissimi libri super scontati