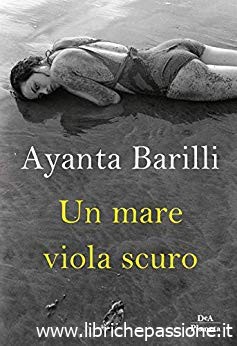
Un bisnonno, Belzebù, dal nome improbabile e inquietante. E un luogo, Colorno, così carico di segreti e di orrore da non potersi evocare. Parte da qui, dagli ostinati silenzi e dalle invenzioni di una famiglia di saltimbanchi, bugiardi, scrittori, amazzoni e diavoli, il viaggio di Ayanta alla scoperta della sua verità. Tre donne: Elvira, Angela, Caterina. Un secolo di Storia: la nostra. E poi Padova, Parma, Roma, Tellaro, Madrid. Per riannodare il filo contorto e spezzato della memoria, Ayanta si addentra nel labirinto ora spaventoso, ora traboccante di luce delle proprie radici, fruga nei vecchi cassetti, separa le favole dalla realtà, le leggende dalle bugie. Sveglia fantasmi a lungo sopiti, forza le stanze chiuse dei ricordi, traccia i frastagliati contorni di un dramma famigliare ma non domestico – anzi, universale – lungo tre generazioni. Perché sono le donne a custodire la memoria, lacune e omissioni comprese, delle generazioni passate e presenti. E sono sempre loro, le donne, a mettere le mani in quei cassetti, a trasformare i detriti in storie che pretendono di essere ascoltate. Storie così vive da riguardarci tutti.

A Sandra e a Leone, indimenticabili compagni del Teatro Stella.
A Carlotta, testimone dei giorni perduti e ritrovati.
A Francis, alfabeto di tutte le mie lettere. Principio e fine.
Prologo
La notte in cui morì mia nonna, dormivo nel suo letto. Alle tre del mattino nella casa di famiglia di Roma squillò il telefono. Un’infermiera mi comunicò la notizia. Quando raggiunsi la stanza d’ospedale che condivideva con quattro o cinque anziane, lei non c’era già più. L’avevano spostata nello sgabuzzino dove tenevano i prodotti per le pulizie. Mi dissero che era per non impressionare le altre pazienti. Entrai e chiusi la porta. Dal soffitto pendeva una lampadina. Lo spazio era angusto. Scaffali con bottiglie di varechina, guanti e altri detergenti, uno spazzolone dentro il secchio, una scopa con la paletta e, sulla scalcinata parete in fondo, una scritta: Viva la Roma, abbasso la Lazio! Posai la guancia sul suo cuore. Le baciai il viso, le palpebre, il collo. Scottava ancora di una febbre ormai inutile. Sollevai la camicia da notte celeste e osservai il suo corpo nudo. Le toccai il ventre, la pelle bianca e liscia. Coprii con una mano il seno che le mancava, percorsi le cicatrici e piansi per l’ultima volta nel suo grembo.
Dopo qualche tempo comparve il medico incaricato di constatare la morte di Angela. La infilarono in una cassa metallica e, prima ancora di rendermene conto, mi ritrovai a correre dietro quel feretro improvvisato, assicurato alla barella da cinghie di cuoio e spinto da un inserviente che andava di fretta.
Percorremmo corridoi, rampe e ascensori che conducevano ai piani interrati dell’edificio, dove la cassa fu sistemata in una cella frigorifera. Qualcuno mi accompagnò nel piccolo ufficio delle pompe funebri dell’ospedale. Le pareti erano rivestite di legno laccato, lo stesso delle bare vendute a prezzi impietosi. Seduto a una scrivania anch’essa laccata mi attendeva un professionista del lutto.
«Buongiorno, le mie più sentite condoglianze. Per prima cosa dobbiamo riempire il modulo con i dati della defunta. Nome?»
«Angela Spagnoli.»
«Nata a…?»
«Parma, il 28 settembre del 1911.»
«Figlia di…?»
«Elvira e Belzebù» risposi convinta.
Lo sconosciuto delle pompe funebri mi fissò perplesso.
«Belzebù?» farfugliò. Erano le sei del mattino e l’uniforme lo avvolgeva come un sudario.
Non sapevo come si chiamasse veramente il mio bisnonno. Non si trattava di un vuoto di memoria causato dalla confusione del momento. Era molto peggio: ignoravo il vero nome del padre di mia nonna perché lei lo aveva sempre e solo chiamato a quel modo, Belzebù.
Restai muta davanti alla scrivania, in attesa di una reazione dell’uomo in nero. Senza scomporsi lui segnò con una crocetta il punto in cui dovevo firmare il certificato di morte, datato 5 febbraio 2001. Quindi si alzò e mi strinse la mano in silenzio, rivolgendomi un tirato sorriso di circostanza, come se avesse di fronte una squilibrata. Non posso dargli torto.
Tornai a casa dopo aver promesso di fargli avere i dati mancanti. Ma quando interrogai la zia Carlotta, nemmeno lei fu in grado di darmi una risposta diversa.
«Mia nonna, la tua bisnonna, si chiamava Elvira.»
«Zia, questo lo abbiamo sempre saputo.»
«E lui… Belzebù» affermò dopo un istante di esitazione.
«Anche tu con questa storia? È impossibile, non poteva chiamarsi così! Ci serve il suo vero nome per le pompe funebri. Bisogna trovarlo, ci sarà pure in qualche documento.»
Iniziammo a rovistare tra le vecchie carte nel cassetto del comodino della nonna. Sotto una cartellina spuntò la foto molto antica di un neonato, nell’angolo il timbro di uno studio fotografico di Padova. Il piccolo era adagiato su un grande cuscino, avvolto in uno scialle di pizzo, con cuffia e scarpine. Tutto era bianco, tranne le labbra che sembravano tinte di scuro. Aveva la bocca un pochino aperta e gli occhi socchiusi.
«Chi è questo bambino, Carlotta?»
«Non ne ho idea» rispose quasi senza guardarlo.
«Sì, ma è morto, te ne sei resa conto?»
«Come può essere morto? E se anche fosse… io che ne so! A quei tempi ne morivano tanti e, per non dimenticarli, gli facevano una foto. Non la voglio neanche vedere. Queste cose mi fanno spavento.»
«E perché la nonna Angela teneva nel cassetto la fotografia di un neonato morto? Che orrore! E chi sarà? Qualcuno della famiglia?»
«E tu perché vuoi sempre sapere tutto? Rimetti quella foto dove stava, avanti…»
«Dovrei rimetterla nel cassetto come se nulla fosse? Non capisco che gusto ci provi a nascondermi le cose. Non capisco perché amiate tanto i segreti, tu, la nonna e tutti gli altri. E
se davvero non hai idea di chi sia questa creatura, come puoi non provare la minima curiosità di scoprirlo? È inconcepibile! Be’, posso tenerla?»
«Che cosa?»
«La foto del bambino cadavere» risposi per stuzzicarla.
«Certo che quando vuoi sai essere proprio sgradevole, Ayanta! Tienila, se ti fa piacere. E quando scoprirai chi era quel poveretto, fammi il favore di non raccontarmelo. Sono troppo vecchia per certe cose. Guarda invece cos’ho trovato io!» annunciò la zia, sventolando il certificato di nascita della nonna. «Poi non venirmi a dire che tengo tutto per me e che non ti aiuto… Evaristo, si chiamava Evaristo! Meno male, iniziavo a preoccuparmi. Chissà come ho fatto a dimenticarlo. La mia memoria peggiora di giorno in giorno.»
Evaristo. Mentre sentivo pronunciare il suo nome per la prima volta, mi resi conto che non sapevo niente di lui, salvo un paio di aneddoti poco credibili riferiti da Angela. E se non ne sapevo niente, era appunto perché nessuno aveva voluto raccontarmi dei miei bisnonni. E se io stessa mi ero accontentata di mezze risposte evasive, era perché avevo inconsciamente assimilato il modo di essere così tipico della mia famiglia.
Di colpo, con quel certificato di nascita gualcito in mano, compresi che la mia eredità principale era un albero genealogico senza rami, senza nomi e senza date, che Angela aveva portato con sé nella tomba. Mi tornarono alla mente le tante occasioni in cui le mie domande erano cadute nel sacco senza fondo dei silenzi e delle leggende domestiche. Perché chiamavano il bisnonno Belzebù? E perché Carlotta, in risposta alle mie insistenti curiosità infantili, una volta si era lasciata sfuggire che la bisnonna era una puttana? Evaristo ed Elvira: un diavolo e una puttana.
Da bambina non conoscevo divertimento più grande che stare con la nonna. Per me era meglio di qualsiasi altro programma. E per lei doveva essere lo stesso. Non appena mi vedeva comparire, Angela abbandonava le sue frenetiche attività per concentrarsi sulla nipote. Prendeva decine di libri dagli scaffali, me li leggeva e poi insieme ripassavamo le illustrazioni soffermandoci su ogni minimo particolare, mentre preparava qualche merenda dolce e consolatrice. Si divertiva a costruire pupazzetti con i resti del pranzo sparpagliati sulla tavola. Bucce di mandarino, gusci di noce, tovaglioli di carta, stuzzicadenti su piedi di mollica, ossicini e turaccioli con occhi di semi. Sistemava i pupazzi sul marmo della cucina e con loro allestiva le opere di Shakespeare in esclusiva per me. Ma quello che in assoluto le piaceva di più era raccontarmi i grandi balletti classici, nel cui secondo atto faceva sempre il suo ingresso trionfale il demonio: Il lago dei cigni, Giselle, Lo schiaccianoci. Agitava le braccia da una parte all’altra, come se fosse al contempo direttore d’orchestra e prima ballerina. Seduta sulle sue ginocchia, la guardavo rapita fino a cadere preda della sua stessa estasi.
La sera in cui mi portò per la prima volta al Teatro dell’Opera di Roma per vedere Le silfidi, lo spettacolo mi impressionò al punto che credetti di morire insieme a tutte quelle vergini. Quando apparve in scena il diavolo, gridai e gridai nella speranza di riuscire ad avvertirle del pericolo e a mettermi in salvo con loro. Avevo cinque anni.
Angela mi aprì le porte di un mondo strampalato che raccontava con occhi antichi. Vivere con lei era delizioso. Però poteva diventare esasperante. Il suo amore smisurato per il racconto la spingeva a manipolare la realtà per trasformarla in un soggetto attraente, degno di essere raccontato. La verità le interessava poco, perciò la reinventava o la travisava fino a renderla un’esperienza unica, personale e irriconoscibile. Noi non potevamo far altro che accettare quel tratto del suo carattere, e ormai nessuno si prendeva la briga di provare a scoprire se ciò che affermava con tanta certezza fosse o meno un’invenzione. L’unica cosa che le importava era lasciarci a bocca aperta, e assicurarsi che le sue fantasie si insinuassero nel patrimonio delle leggende di famiglia. Fu in quel modo che ricostruì il proprio passato, e già che c’era anche il nostro presente: secondo i capricci della sua immaginazione.
Ma le reinvenzioni della nonna non si limitavano alle questioni importanti o episodi cruciali della cronaca familiare, riguardavano anche le minuzie della quotidianità. Negava il vero e dichiarava il falso in modo sistematico, come una bugiarda compulsiva. Ad esempio, le chiedevo se aveva comprato le mele.
«Ma certo, proprio stamattina, al mercato» assicurava distogliendo lo sguardo e aggiungendo dettagli di tutti i tipi.
Sì, era andata alla bancarella della “signora grassa”, ma purtroppo non aveva le renette, poi guarda caso aveva incontrato Berta, la sua migliore amica d’infanzia… Io già sapevo che non era vero. Non avevo neanche bisogno di andare in cucina per scoprire che le mele non c’erano e confermare così i miei sospetti. Né sarebbe servito a qualcosa accusarla o cercare di capire il motivo di quelle assurde frottole. Se ci provavo, Angela girava sui tacchi e, livida d’indignazione, mi piantava in asso borbottando qualcosa che aveva il solo scopo di provocarmi.
«Be’, se non ci sono più mele, sarà perché te le sei mangiate tutte!»
Era dunque naturale che in casa mia fosse difficile, per non dire impossibile, distinguere i fatti concreti dalle fantasie. C’erano domande destinate a restare senza risposta, salti temporali ed eventi inspiegabili cui a malapena si accennava, persi com’erano nei labirinti contraddittori dei ricordi. Né mancavano i segreti custoditi a doppia mandata. Tutto il resto, ciò che era risaputo, si trasformava all’istante in materia letteraria, soggetta a qualsiasi tipo di rielaborazione. Ma non sempre era così. A volte – raramente – qualcuno si lasciava scappare una verità che per la forza dell’abitudine veniva interpretata come una bugia, aggiungendo ancor più confusione al caos.
Nei giorni successivi alla morte di Angela mi dedicai a setacciare la sua casa da cima a fondo, sempre con l’aiuto della zia Carlotta. Scoperto il nome di Evaristo, ora dovevo solo ricordare il luogo in cui la nonna conservava il testamento, benché prima di morire me lo avesse ripetuto mille volte. Rammentavo fin nei minimi dettagli le occasioni in cui la sua mano, ruvida e deformata dall’artrosi, si era stretta attorno alla mia. Rivivevo la sensazione del contatto con la sua pelle, il modo in cui si rivolgeva a me. Ma non mi riusciva di riscattare dall’oblio neppure una delle sue parole. La desolazione mi aveva impedito di ascoltarla, rendendomi sorda alle raccomandazioni dell’addio.
Mentre cercava invano le ultime volontà della madre, Carlotta s’imbatté in diversi scatoloni zeppi di carte nascosti sul ripiano più alto di un armadio. C’erano un romanzo breve che la nonna aveva autopubblicato, decine di pagine sciolte con gli incipit di altrettante storie poliziesche, un’altra delle sue grandi passioni. Ma anche i diari di mia madre, dall’adolescenza fino a tre o quattro anni prima che morisse, e le sue poesie, canzoni, commedie teatrali incompiute, saggi universitari, discorsi politici, foto, passaporti, cartoline, fatture, appunti, certificati di nascita e di morte, e centinaia di lettere ingiallite indirizzate a parenti, amici e a mio padre lungo il periplo della loro storia d’amore tra l’Asia e l’Europa.
Mia zia Carlotta non voleva saperne del passato. Si liberò immediatamente degli scatoloni e dei segreti che forse nascondevano.
«Tieni, sono tuoi» disse, abbandonandoli ai miei piedi.
E siccome erano miei, li caricai in macchina e li portai con me da Roma a Madrid, dove vivevo, dove vivo tuttora. E siccome era tutta roba mia, per dieci anni non mi azzardai a guardarci dentro. Il bottino di famiglia restò qualche settimana in salotto e un po’ di giorni in camera da letto, finché decisi di tornare a nasconderlo sul ripiano più alto di un armadio, il mio. E lì restò. Anche se non andò esattamente così. Qualcosa estrassi da quegli scatoloni: il romanzo di Angela. Lo lasciai sul comodino senza aprirlo, perché mi facesse compagnia nelle mie notti insonni. S’intitolava Sequenze familiari.
La ragione per cui seppellii quel materiale insieme ai giochi abbandonati dei miei figli, ai costumi di carnevale bucherellati dalle tarme, alla macchina per cucire e alla collezione di fossili è evidente. Tutto il mondo di Angela si era trasformato per me in qualcosa di oscuro, ambiguo, sinistro. La curiosità che aveva ispirato le mie investigazioni infantili e poi giovanili era svanita di colpo per lasciare il posto alla paura. Paura di sapere. Forse la stessa di cui soffriva Carlotta. Perché questo mi avevano insegnato fin da piccola: a inventare una realtà parallela affinché la vita risultasse meno amara. Ma gli anni in cui mi credevo l’eroina immortale dei racconti della nonna erano ormai tramontati; l’età adulta si imponeva in tutta la sua complessità, e aprire la porta ai fantasmi non è mai facile. Così gli scatoloni continuarono a dormire il sonno a volte un po’ inquieto dei giusti.
Ancora una volta mi tappavo gli occhi, le orecchie, la bocca, e senza saperlo mi trovavo a ricalcare le orme delle donne che mi avevano preceduto. Non sapevo come liberarmi di un passato che non osavo affrontare. E quanto alla parte che conoscevo, meglio tacerla. Anch’io avevo vissuto con un Belzebù, che non aveva il volto di Evaristo, ma quello del compagno di mia madre. Però questo non lo posso ancora raccontare. Non adesso.
La morte di Angela segnò un momento di regressione nella mia vita. Tornai a provare la stessa solitudine che mi aveva travolto da bambina quando era morta mia madre. Proprio come allora iniziai a percepire i suoni distorti e le voci filtrate, come se vivessi su un palcoscenico dove i passi echeggiano, le porte rimbombano tra le quinte e qualcuno ti parla, ma senza rivolgersi davvero a te. Non riuscivo a lavorare. Occuparmi dei miei due figli mi costava fatica. A stento mi costringevo a uscire di casa. Dissero che soffrivo di stress postraumatico. Mi diedero delle pastiglie. Le mie notti trascorrevano in grovigli onirici da cui riemergevo senza fiato. Le mie giornate si trasformarono nel triste compendio di tutto ciò che avevo perduto. Trascorsi dei mesi sdraiata sul divano a guardare la televisione, cosa per me inaudita. Non avevo nemmeno la forza di cambiare canale in cerca di qualcosa che mi interessasse, lasciavo che le immagini mi scorressero davanti. Niente di più.
Cominciò il corteo degli amici preoccupati per il mio stato d’animo, pronti a suggerire mille alternative ai pomeriggi trascorsi a fissare uno schermo. Va tutto bene, dicevano. La morte di una nonna è una cosa naturale che dobbiamo accettare. All’epoca avevo trentadue anni e convivevo ancora con il padre dei miei figli, avevo una bella casa e un lavoro che mi piaceva. Nessuna preoccupazione. Eppure sentivo sulle spalle un peso difficile da portare, un’angoscia che mi impediva di andare avanti.
Quando il dolore del lutto si fece meno affilato e lasciò spazio alla sensazione che nulla ha davvero importanza, una sera afferrai il libretto di Angela, che continuava ad aspettarmi accanto al letto, e iniziai a leggerlo. Sequenze familiari era un racconto con toni da feuilleton, ambientato nelle due città del Nord Italia che l’avevano vista crescere: Parma, dove era nata, e Padova, dove aveva trascorso la prima infanzia. Benché riconoscessi come sua la prima persona del libro, la vicenda era così drammatica che lì per lì non la presi per autobiografica. Figlia e nipote di scrittori, ero abituata all’idea che il materiale privato venisse sfruttato per gettare le fondamenta di una storia inventata, di fatto priva di attendibilità. Pensai che la nonna avesse preso spunto da alcune circostanze personali per tessere un’altra delle sue fantasie, stavolta per iscritto. Comunque fosse, quelle pagine risvegliarono in me il desiderio impellente di conoscere i paesaggi descritti, di seguire i passi di Angela e vedere ciò che lei aveva visto. Decisi quindi di volare da Madrid a Roma, per poi intraprendere un solitario viaggio in treno fino a Parma, dove ancora vivevano alcuni parenti che conoscevo appena. Per prima cosa volevo visitare il cimitero in cui era sepolta mia madre e poi mettermi sulle tracce della bisnonna Elvira, la puttana, la moglie di Belzebù, ovvero d’Evaristo. Niente di più.
Perché Elvira? Per puro istinto: la sua era una figura misteriosa e onnipresente, capace di suscitare i silenzi e gli sguardi degli adulti, dalla quale avevano sempre cercato di tenermi alla larga. Per opportunismo: iniziavo ad accarezzare l’idea di scrivere un libro sulle donne di famiglia, perché in fin dei conti erano state loro a reggere le fila della nostra storia. E per amore, verso me stessa e verso gli altri: se volevo liberarmi dalla tristezza, dovevo imparare a conoscermi meglio. Tornare indietro per ripercorrere la strada dal principio. E forse il principio era proprio Elvira.
Per una di quelle strane sincronie della vita, mentre il treno si avvicinava a Parma costeggiando la statale, dal finestrino colsi una scritta a lettere bianche su fondo blu, un cartello a forma di freccia che balenò nella notte come un fotogramma. Così veloce che, un attimo dopo, già dubitavo di averlo visto davvero. Era un nome di città: Colorno. Visitavo quei luoghi per la prima volta e non riuscivo a spiegarmi perché il nome Colorno mi risultasse così familiare. Mi stavo ancora sforzando di ricordare, quando arrivai a destinazione.
Alla stazione mi aspettava uno zio di secondo grado, nipote di Elvira, stimato pittore e collezionista di giocattoli d’epoca. Di lui conservavo un vago ricordo infantile e alcuni aneddoti del dopopranzo, ad esempio il fatto che, timido e pudico com’era, usava fare la doccia in mutande. O almeno così sosteneva la nonna.
Lo riconobbi non appena scesi dal treno per via di un’inequivocabile aria di famiglia. Lo zio Stefano era un uomo corpulento di mezza età, e mi attendeva sotto la pensilina avvolto in un grande paltò, con tanto di sciarpa, guanti e cappello, la tenuta minima per tenere a bada le ansie da ipocondriaco che lo tormentavano. Per prima cosa mi portò a casa sua, dove mi avrebbe ospitata per qualche giorno. Dopodiché andammo al ristorante, accompagnati da sua moglie. Durante la cena parlammo di Angela e con cautela lo interrogai su quel passato che conosceva assai meglio di me. Ma commisi un errore da principiante, gli confessai la vaga intenzione di scrivere un libro sulla famiglia. Senza considerare la personalità riservata dello zio, né la sua genetica predisposizione a schivare qualsiasi conflitto e a negare l’inevitabilità del dolore in quanto parte del tutto, gli chiesi di Elvira. Per tutta risposta mi consigliò un delizioso dessert che era la specialità della casa. Allora la moglie, che sembrava non interessarsi a nulla, intervenne in mio aiuto.
«Perché non le mostri il ritratto di Elvira dipinto da tuo padre?» domandò con apparente innocenza, in realtà ben consapevole di tradire così le paure più radicate del marito. «È l’unica immagine che rimane ad Ayanta della sua bisnonna, è giusto che la veda.»
Lui, contrariato, rispose in modo evasivo e addusse il pretesto di non sapere dove si trovasse il quadro. Chiese il conto, pagò e, mentre si alzava da tavola, mi rivolse un sorriso franco. E un monito: «Lascia perdere».
Era un’uscita alla don Corleone, che in bocca a lui risultò ancora più assurda, o più minacciosa. In ogni caso, confermava la difficoltà dei miei parenti a fare i conti con il passato. Ci augurammo la buona notte in salotto e lo osservai avviarsi in camera da letto con la gatta tra le braccia e la moglie subito dietro.
Mi lasciai cadere su una vecchia poltrona e soltanto allora mi accorsi dello spettacolo – non saprei come altro definirlo – che si dispiegava davanti ai miei occhi. Sembrava lo scenario impossibile di un sogno. O uno di quei libri per ragazzi che si aprono a ventaglio per svelare castelli così favolosi da strapparti un applauso. Il paese dei balocchi e dell’arte. E della letteratura. La ricostruzione di un universo che pur appartenendo a un passato prossimo sembrava già lontanissimo. Le pareti erano ricoperte di quadri e, attorno al caminetto, una grande libreria a pannelli mobili ospitava centinaia, forse migliaia di libri d’arte, saggi e prime edizioni dei grandi poeti del Novecento italiano. Ma il particolare più incredibile era il trenino elettrico che senza sosta percorreva l’intera stanza su binari che sembravano veri. S’inerpicava sugli scaffali della libreria come se fossero valichi alpini, riscendeva a valle, spariva dietro un divano, rispuntava in curva per schivare la base di un tavolino ai margini del tappeto, affrontava un’altra faticosa salita lungo pareti di mogano e infine irrompeva sulla tavola da pranzo, evidentemente mai utilizzata per scopi che non fossero ferroviari. Sui vagoni viaggiava una compagnia circense: foche con palle in equilibrio sul naso, cavallini con le loro graziose amazzoni, ballerine che giravano e giravano su un’unica gamba di latta, un elefante con le ruote al posto dei piedi, diversi pagliacci a cavallo di monocicli e un domatore con frusta e leone.
E a osservare quell’intrico di gallerie, semafori, ponti e passaggi a livello, un pubblico dei più assortiti: mamma anatra con i suoi anatroccoli tutti in fila attaccati a una cordicella, una ruota panoramica d’ottone con i seggiolini volanti protetti da un ombrello per riparare le coppie innamorate dal sole o dalla pioggia, un ginnasta che volteggiava sulle parallele, svariati supereroi un po’ anacronistici e una miriade di animali della giungla e della savana in attesa del passaggio del treno.
Rimasi a lungo seduta lì, in contemplazione. La locomotiva avanzava a velocità costante, tirandosi dietro le carrozze lungo quell’itinerario circolare mille volte ripetuto. La osservavo con ammirazione infantile finché, di colpo, immersa nel suo sferragliare, mi ricordai perché conoscevo il nome che mi era apparso davanti come un lampo durante il viaggio in treno: Colorno. Lo incastrai nel puzzle della memoria. E ne provai sollievo.
A casa mia, per riferirsi a qualcuno che per un motivo o per l’altro aveva perso la testa, dicevano sempre: «Bisognerà portarlo a Colorno». A furia di ripeterla, quell’espressione si era tramutata in una frase fatta. Non mi era mai passato per la mente di interrogarmi, tanto meno di chiedere notizie ad altri, sulla sua origine. Nemmeno in quel momento seppi riconoscerne l’importanza. Era la chiave dello scrigno, ma io non lo capii. Ciò che invece compresi nel salotto dello zio quella notte è che una delle chiavi della coscienza, quella che apre la porta alla comprensione di noi stessi e all’attenta percezione del prossimo, risiede nelle parole. Il linguaggio usato tra due innamorati, tra un padre e un figlio, in famiglia, nasconde così tanti segreti della nostra intimità condivisa da risultare incomprensibile ai non iniziati. Questo lessico privato, questo codice segreto, custodisce la verità. A volte, persino travestita da menzogna.
Parola su parola, la nonna aveva tessuto le nostre storie. Sarebbe bastato, dunque, tirare un filo per vedere disfarsi a uno a uno i punti, le lettere del mio alfabeto, l’intima e veritiera lingua madre che accompagna le mie tribolazioni. Il trenino girava ancora instancabile nella stanza quando, circondata da fantasmi, seppi che dovevo visitare Colorno. Aspettai che spuntasse il sole. In tutti i sensi.
All’alba, presi il primo pullman e in mezz’ora arrivai a Colorno. Era un paese come tanti: una piazza, un paio di caffè, un ristorante, una libreria, casette basse ben tenute e sullo sfondo montagne innevate a incorniciare quella cartolina. Lo attraversai da cima a fondo senza che altri particolari colpissero la mia attenzione. Mi fermai davanti alle immagini di due giovani sposi nella vetrina di un fotografo, comprai il giornale e decisi di considerare conclusa la mia gita.
In attesa dell’autobus, entrai in un caffè per ripararmi dal freddo. Mentre bevevo un tè al banco, vidi un uomo passare per strada. Era un tipo bizzarro. Girava senza cappotto, con una camicia blu sbottonata che gli lasciava scoperte le spalle. Pantaloni cascanti, patta aperta e pantofole di stoffa. Dalle labbra carnose pendeva un filo di bava.
“Un matto” mi dissi.
Non gli diedi grande importanza.
Chiamai il cameriere, presi il portafogli e feci per pagare il conto. In quel preciso istante vidi passare un altro uomo combinato più o meno come il precedente.
“Bisognerà portarlo a Colorno” pensai in modo automatico. E d’un tratto ricordai che nel romanzo di Angela la madre della protagonista finiva rinchiusa in una clinica per malati di mente chiamata C. C puntato? C come l’iniziale del paese in cui mi trovavo? C come Colorno?
Fu una rivelazione. Un lampo. Mi mancò la terra sotto i piedi. Sentii una vertigine, una vampata, un frullare d’ali nel petto. Uscii dal bar. Un caldo tremendo in mezzo alla neve. Il vapore del respiro che mi annebbiava la vista. Da sempre, dalla prima parola lasciata a metà fino all’ultima occhiata sfuggente, Angela aveva detto tutto senza dire niente. Mi aveva raccontato ogni cosa con le sue mille e una storia trasformate in letteratura.
Dunque era possibile che la bisnonna Elvira fosse stata in manicomio. Quella parte del romanzo forse era vera. E se lo era, il manicomio doveva trovarsi proprio lì, nella C. del libro, nella Colorno del ritornello familiare.
Decisi di seguire uno di quegli uomini sgangherati. “Pensa, Ayanta, pensa” mi dicevo, mentre accompagnavo il matto nella sua passeggiata. “Ma pensa bene, usa il cuore e non la testa, perché è lì che sono nascosti i ricordi che hai dimenticato.” E proprio dal cuore affiorò un altro ricordo perduto. Alla morte di mia madre, Angela mi aveva raccontato di essere rimasta anche lei orfana da bambina. La bisnonna era mancata all’improvviso quando Angelina aveva solo sei anni. Eppure il romanzo riportava una versione completamente diversa. Stando a ciò che vi era scritto, Elvira non era morta durante l’infanzia di Angela, come lei stessa mi aveva assicurato piangendo lacrime di coccodrillo. No, nel 1917, sei anni dopo la nascita della figlia, Elvira era finita in manicomio. Ma potevo fidarmi del libro? Dove stava la verità, in quello che Angela raccontava o in quello che aveva scritto? O in una diabolica combinazione dei due?
Pedinando con discrezione il matto lungo le vie del paese, giunsi davanti a una costruzione che per struttura e giardini ricordava una piccola Versailles. Era il Palazzo ducale, regalo di Napoleone alla moglie Maria Luisa d’Austria e destinato a diventare una delle sue residenze preferite. L’edificio era stato ristrutturato da poco e in quei giorni ospitava una mostra d’arte moderna: fu lì che il matto si intrufolò. E quando me ne resi conto era già scomparso.
Schivai le opere di un artista locale palesemente indegno delle fastose sale che si succedevano una dopo l’altra, saltai il percorso raccomandato e senza volere mi ritrovai in un salone vuoto, immenso, vibrante dell’eco di epoche antiche e del volteggiare incessante di coppie in abiti sfarzosi. Al riparo da sguardi indiscreti accennai qualche passo di danza verso una piccola finestra coperta da tendine bianche. Le scostai quanto bastava per vedere che dava su un cortile abbandonato. L’edera abbarbicata sulle pareti ne dissimulava il degrado, infilandosi nelle crepe dei muri per rispuntare poco più in là e attorcigliarsi alle spesse sbarre conficcate nelle finestrelle che costellavano le tre facciate. Era una pianta così vitale e frondosa che alcuni dei suoi rami non crescevano più verso l’alto, ma cercavano spazio verso il basso, strisciando sul pavimento fino a ricoprirlo in buona parte e ad avvolgere il tronco di quattro o cinque alberi che chissà come resistevano a quello stretto abbraccio.
A un tratto fui richiamata da un custode perché stavo curiosando dove non avrei dovuto. Abbandonai la sala un po’ a disagio e mi ritrovai davanti una vetrata che dava su un giardino maestoso. Una simmetria di siepi fiancheggiava il vialetto principale che sbucava nei pressi di una fontana circondata dai cipressi. Attraversai il parco costeggiando il palazzo, ma una recinzione di filo spinato impediva l’accesso all’ala posteriore dell’edificio. Non mi diedi per vinta finché non trovai un varco. Una casetta di recente costruzione sorgeva separata dal resto della struttura. Mi avvicinai per leggere il cartello appeso alla sua facciata: CENTRO MISERICORDIA PER MALATI MENTALI. E fu allora, a pochi passi dalla casa, che sentii qualcuno intonare O sole mio. A squarciagola. Con passione e amore. Con una certa lascivia.
L’effetto era paradossale in quel giorno pallido, di nubi basse e gravide di neve. Affacciato a un balcone, un altro matto cantava con le braccia aperte tese al cielo, sempre la stessa strofa. Sembrava la preghiera a una divinità pagana, di quelle che s’intendono solo di fulmini e tuoni. O il lamento di un innamorato, che invoca il suo amore senza mai ottenere risposta. O ancora il grido di un guerriero giunto all’ultimo assalto, un attimo prima di perdere la battaglia.
«Chiudi il becco, Pavarotti!» gli gridò una donna obesa dal giardino.
E Pavarotti chiuse il becco. Ma solo per prendere fiato e riattaccare con rinnovato ardore.
Entrai e mi sedetti nella modesta sala d’aspetto dell’ambulatorio psichiatrico, con la fila di panche di legno plastificato color verde acqua a ricordarmi i banchi e le sedie della mia prima scuola. In un angolo, una vergine in gesso scrostato stringeva tra le mani giunte un rosario di plastica fosforescente. Se me lo avessero chiesto, non avrei saputo dire che cosa facessi lì, persa come una sonnambula nel mezzo di una caccia al tesoro, gioco che per di più detestavo da sempre. E intanto i postumi della notte in bianco cominciavano a farsi sentire.






