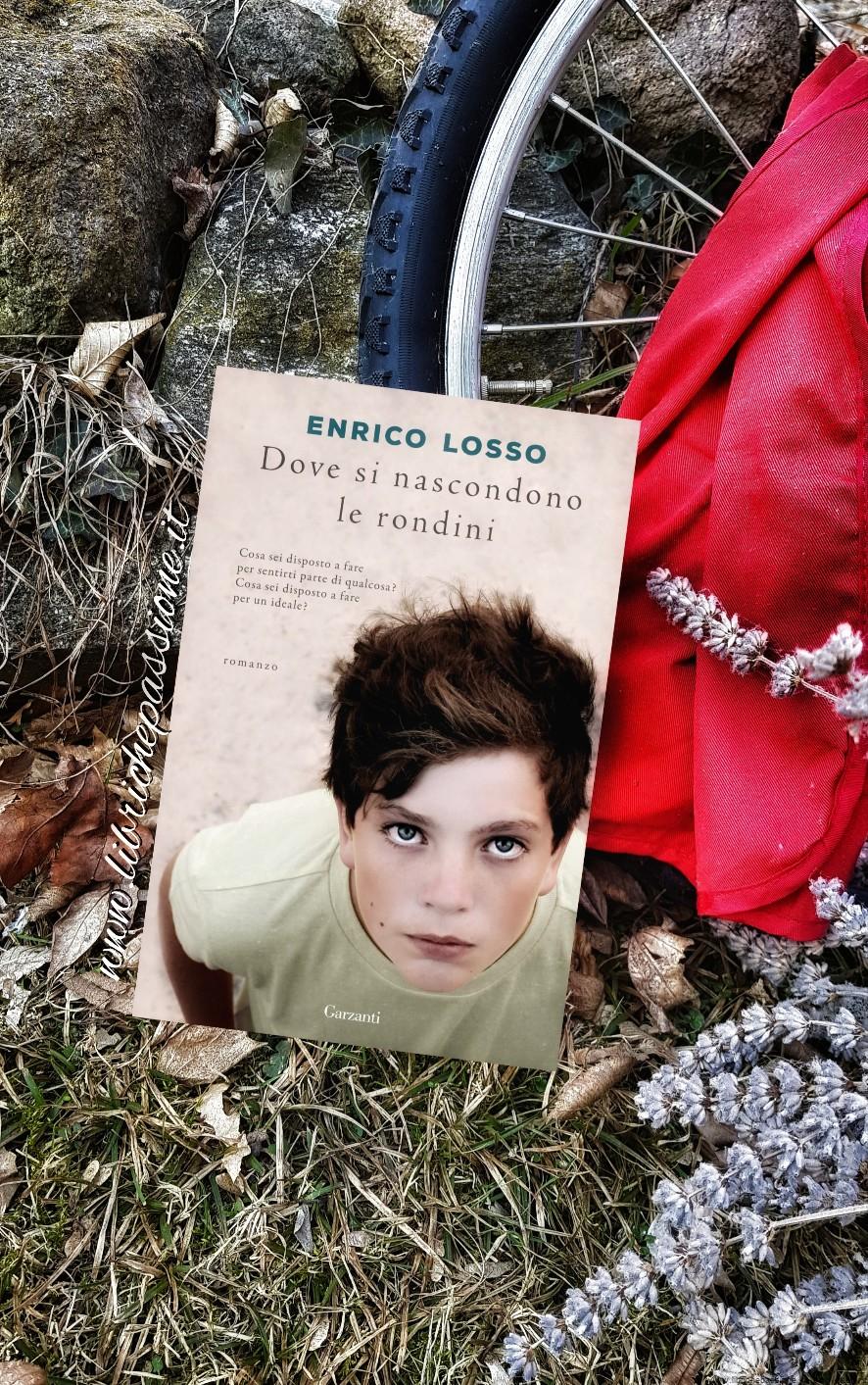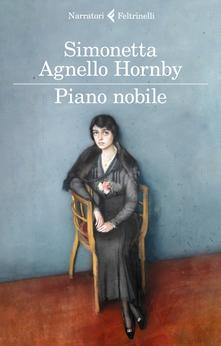Trama
Tre storie diverse, la stessa città – Roma, all’inizio degli anni Ottanta – e lo stesso destino: smettere di essere soltanto figli, diventare genitori. Eppure Luciana, Valentina, Cecilia non sono certe di volerlo, si sentono fragili, insofferenti. Così come sono confusi, distanti, presi dai loro sogni i padri. Si può tornare indietro, fare finta di niente, rinunciare a un evento che si impone con prepotenza assoluta? Luciana lavora in un giornale che sta per chiudere. Corre, è sempre in ritardo, l’uomo che ama è lontano, lei lo chiama l’Irlandese per via dei capelli rossi. Valentina ha diciassette anni, va alle superiori ed è convinta che da grande farà la psicologa. Appena si è accorta di essere incinta, ha smesso di parlare con Ermes, il ragazzo con cui è stata per qualche mese e che adesso fa l’indifferente, ma forse è solo una maschera. Cecilia vive fra una casa occupata e la strada, porta un caschetto rosa e tiene al guinzaglio un cane. Una sera torna da Gaetano, alla tavola calda in cui lavora: non vuole nulla da lui, se non un ultimo favore. A osservarli c’è lo sguardo partecipe di un io che li segue nel tempo cruciale della trasformazione. Un giro di pochi mesi, una primavera che diventa estate. Tra bandiere che sventolano festose, manifesti elettorali che sbiadiscono al sole e volantini che parlano di una ragazza scomparsa, le speranze italiane somigliano a inganni. Poi ecco che una nuova vita arriva e qualcosa si svela. “Lontano dagli occhi” è una dichiarazione d’amore al potere della letteratura, alla sua capacità di avvicinare verità altrimenti inaccessibili. Ricostruendo con la forza immaginifica della narrazione l’incognita di una nascita, le ragioni di una lontananza, Paolo Di Paolo arriva a rovesciare la distanza dal cuore suggerita dal titolo. Una storia sul peso delle radici, su come diventiamo noi stessi.
Estratto
Ma è tutto visto dal di fuori, le due entità che
potrebbero illuminarci, neonato e cadavere,
non possono farlo, poiché l’apparato atto a
comunicarci le loro esperienze non è in
sintonia con il nostro ricevitore.
E.M. FORSTER, Aspetti del romanzo
VICINO
Un uomo che sta per diventare padre non lo riconosci da niente. Nessuno gli cede il posto, nessuno gli fa largo, nessuno suppone di doverlo proteggere, o compatire. Può uscire con una ragazza, bere con lei, fare il brillante: nulla, della sua attesa, sarà svelato. Può lui stesso, per qualche ora, dimenticare, e non sarà certo il corpo a ricordarglielo. Affamato, eccitato, stanco, però come sempre.
Se infine non si troverà lì – nei pochi lunghissimi istanti in cui, dal corpo della madre, verrà alla luce il figlio – niente potrà avvertirlo: non un presagio, un campanello, un dolore, un acquazzone, niente. Non resteranno segni addosso. Dovrà, per qualche via, essere raggiunto dalla notizia: svegliandosi nell’albergo lontano in cui è fuggito; o sentendo di perdere un battito, prigioniero di un mezzo di trasporto ormai in ritardo.
E comunque, è nato, è nata, non sarà come dire sei padre. C’è una strada, un ponte da percorrere, corto qualche mese o magari mezzo secolo.
Così, in questa storia, non mi basta sapere l’emozione confusa – e in ogni caso canonica, fra incredulità e sconcerto – di quando all’Irlandese, a Ermes, a Gaetano, la rispettiva ragazza ha comunicato di essere incinta. Vorrei sapere se, quando e come ciascuno di loro ha maturato coscienza della trasformazione. C’è stato forse un contatto, un’ansia diversa, qualcosa come un clic, una notte insonne?
Hanno fatto l’amore già parecchie volte (Ermes un po’ meno), e non ne hanno tenuto il conto; nessuno lo fa. Memorabili? Qualcuna sì, certo, anche se poi alla lunga tutto si impasta un po’ – la nube dello stesso desiderio: le birre, la macchina, oppure su in casa, di notte, la domenica pomeriggio, le lenzuola umide, il cesso di un locale.
Non saprebbero dire, se interrogati, quando sia accaduto. Forse l’Irlandese sì, per via del panico che l’ha preso, scoprendo di avere perso il preservativo. E comunque, non è stata quella volta. Gli altri due diciamo pure che non ci hanno fatto caso, voltandosi subito su un fianco, o aspettando giusto il tempo necessario per farlo di nuovo, più forte, a occhi chiusi.
Poi se ne sono tornati nel mondo, nell’estate che stava per finire, ignari per settimane.
L’Irlandese, con le sue unghie sempre un po’ nere e i suoi taccuini, i cartoni di vino da senzatetto, le poesie lasciate a metà.
Ermes, la fine della scuola, la certezza che fuori di lì andrà meglio, e anche se c’è la leva di mezzo, non importa. Ha la fissa di trovare lavoro al microfono di una radio. Ama la Roma, ama la musica. E ormai, a forza di sentirselo dire, si è convinto di avercela davvero, una bella voce.
Gaetano per ora, inchiodato al bancone di una tavola calda su via Taranto, non sa nemmeno bene cosa volere. Senza la sterminata collezione di fumetti di cui prendersi cura come di un gatto, boh, forse certe sere, quando stacca, si stenderebbe sulle rotaie del tram.
Se ti sollevi da terra, se cerchi di stare dietro alle loro traiettorie osservandoli dall’alto, come da un terrazzo che domina un quartiere, da un elicottero, a un certo punto, comunque, li perdi.
Basta che svoltino a un angolo, o che diano più gas al motorino, che entrino in un supermercato, prima o poi la città li inghiotte e li rende invisibili. C’è, per ogni giornata, una porzione ampia di minuti preclusa a chiunque e nota solo a noi, spesso del tutto irrilevante, in ogni caso segreta.
L’Irlandese in una vasca da bagno, a casa del tizio che lo ospita – le pareti scrostate e giallastre, la casa di uno che, come lui, non bada troppo all’igiene, e ha vent’anni di più, un certo Morelli, o Monelli, che ha una casa editrice; gli lascia il divano da amico, così dice, ma forse è per interesse, cioè per desiderio. L’Irlandese l’ha capito e il pensiero gli dà la nausea, allora apre tutt’e due i rubinetti, più che può, e si sciacqua con foga, sfrega forte la barba, si prende quasi a schiaffi. Apre gli occhi, ha mezzo allagato il pavimento.
Ermes che si chiude, dopo cena, in camera sua – scuro di rabbia, senza un vero motivo. Risale nel rutto il sapore di cipolla dell’insalata, che ha masticato come si mastica il ghiaccio.
Gaetano che impreca fra i denti, uscendo dal tabaccaio dove non ha comprato le sigarette. Credeva, rovistandosi in tasca, di cavarne una banconota da cinquemila lire, sicuro ci fosse, accartocciata, invece niente.
Qualcosa, in tutto questo, mi riguarda.
Il secolo sta consumando il suo ultimo quarto. Resta misterioso essere vivi proprio adesso, caduti nel tempo in modo da trovarsi ad avere chi ventinove, chi diciotto, chi ventisei anni nell’anno 1983, e non è chiaro, è impossibile decidere quale età anagrafica convenga, rispetto a una certa epoca di questo pianeta. Sempre che abbia senso la domanda. Sempre che abbia senso la propria storia fatta con i se.
Di indubitabile c’è che, a questo punto, l’Irlandese, Ermes e Gaetano, dispersi nella folla, potrebbero sottrarsi alla parte che a loro spetta nella venuta al mondo di un altro essere umano. Ciò che l’ha determinata è un evento già superato, in una sequenza di eventi che d’ora in avanti li esclude.
Perché poi, da qualche parte – visibili, stupefatte, e sole, in quella devastante metamorfosi – ci sono le madri.
Aprile
È l’ultima volta che mette piede in redazione, ma non lo sa. Il brusio lo riconosce da lontano. I telefoni che non la piantano di squillare. La nuvola di fumo. Sono tutti lì che resistono, ringhiano, sbuffano, come su una parete di roccia – e questo è davvero uno spettacolo. La proprietà ha deciso per la chiusura, ma i poligrafici si sono impuntati per fare uscire ancora il giornale. Vuole sentirsi utile nell’impresa, e sentire che l’impresa è utile a lei. Un giornale della sera è un oggetto fuori tempo? Non importa. E non importa che nessuno le dica grazie, no, per carità: le basta lo sguardo di un collega stupito nel vederla entrare.
“Luciana,” le dice, “che ci fai qui?”
“Facciamo lo stesso mestiere, no?” risponde lei, e raggiunge la scrivania. La redazione è ai minimi termini. A ognuno tocca fare il doppio, scrivere quattro articoli e firmarne due, ma la fatica non pesa. C’è una foga insolita, una corrente che riaccende gli occhi dei più vecchi, che hanno perso la conta dei caffè e delle sigarette. È tutto ciò che sognava da ragazzina.
Un’anziana cronista, passando accanto a Luciana, le chiede scusa. “La spengo subito.”
“Non preoccuparti.” Luciana le sorride.
“Sei sicura che ti faccia bene stare qua, in questo delirio, in quest’aria tossica? Forse dovresti rimanere a casa.”
Comincia come un’amica, come una sorella maggiore, poi prende il tono di rimprovero di una madre. “Non vorrai mica diventare tu una notizia in cronaca.”
Va bene, pensa Luciana, va bene, avete ragione voi.
Doveva cambiare già da tempo, invece ha aspettato. Doveva cambiare dopo tre mesi o quattro, quando il corpo dava segnali e lei li ignorava. Doveva mettersi – così si dice, così le dicevano – l’anima in pace, e invece si è comportata come se niente fosse. Come se le gengiviti e il reflusso fossero sintomi di niente.
Doveva cambiare dieta, come il ginecologo le aveva detto, prendere qualcosa contro i crampi di notte, invece di sopportarli come un’idiota mordendo la federa del cuscino. Non ignorare il batticuore, non ignorare questa specie di esplosione di tutto – la massa di capelli e i chili in più. Le voglie, anche, e non quelle più strane, quelle semplici. Ha provato a distrarsi. Ora si sveglia e si sente in trappola, rallentata. Stanca, gonfia.
Le frasi in testa cominciano tutte con non: non sei, dice a sé stessa, la ragazzetta che fuma beata stringendo gli occhi, in piedi davanti all’ingresso del parrucchiere. Non sei la turista che cammina stupita. Non sei quella di prima.
Se passa, di sera, per piazza Trilussa e incrocia la solita folla di adolescenti, di ventenni, seduti sui gradini a bere birra, Luciana ha la sensazione di essere stata espulsa, che le sia stato imposto un veto, un esilio. Un certo modo di stare al mondo, di sentire la primavera che arriva, di avere la testa vuota, non può permetterselo più.
Le verrebbe, per questo, da urlare – come faceva a quindici anni per contestare sua madre, per dimostrarle che non la temeva, che non aveva paura di lei e di niente. E che non si faceva incantare dal suo passato trasgressivo.
“La vita è miaaaaaaaa,” gridava, facendo sbattere tutte le porte che poteva, anche più volte la stessa. “La vita è miaaaaaaaa,” ripeteva con una rabbia che le pareva diventasse odio minuto dopo minuto, la misura di una cattiveria che non credeva di avere dentro. Si calmava dopo avere pianto per mezz’ora, quasi senza respiro.
Quella frase, che allora era stupida, adesso è solo falsa. È solo il contrario della realtà. Il buon senso a cui avrebbe dovuto affidarsi, secondo i consigli non richiesti, non è certo utile a stare meglio. Né le viene facile parlare con l’inquilino della sua pancia, che ormai nuota a orecchie e occhi aperti in settecento millilitri di liquido amniotico. Non sa bene cosa dirgli.
Le fa schifo starsene chiusa in casa per forza. Le fa schifo contare l’ennesima smagliatura sui fianchi, screpolature fosforescenti che quasi lampeggiano nella penombra in cui si spoglia.
Un rubinetto che perde le pare un’insolenza. Per un istante le passa dentro la scarica d’energia sufficiente a cavare, dalla scatola sotto al lavandino, le pinze per stringere, le guarnizioni nuove, ma non dura. Diventa subito insofferente, si scoraggia, si getta sul divano sconfortata. La casa le parla con astio. Lo sporco la provoca. Si è opposta all’idea di sua madre di farsi aiutare, di far venire qualcuno. “Almeno un paio d’ore a settimana.” “No. Faccio da me.”
Ma poi quando un’amica è in arrivo per un tè, per fare due chiacchiere, cade nel terrore, e un po’ anche nella vergogna, e aspetta il suono del citofono come la campanella al termine di un compito in classe.
Si agita, con un piede accompagna una matassa di lanetta a nascondersi – la polvere sotto il tappeto, Luciana! Poi, in cucina, affolla tazze e piatti nel lavello, li fa annegare nell’acqua saponata, che in un attimo si intorbida.
Sul letto, nella metà che resta vuota, c’è un cumulo di abiti smessi, la sua Venere degli stracci: così la chiama, senza riderne, non è un’opera d’arte. L’eroico caos di quando usciva di casa il sabato pomeriggio. E non è sabato pomeriggio, e lei non è la ragazza che piombava nel panico davanti allo specchio. O invece sì: con quindici anni di più, e l’insicurezza di sempre.
È così assurdo che senta le voci? La giacca a fiori con le spalline dice alla felpa vinaccia di starsene zitta, il giubbino di pelle se l’è presa con un paio di pantaloni estivi, che è troppo presto per indossare. Comunque, a vestirsi ci mette sempre più tempo, questo è un fatto. Infilarsi un paio di calze è come ficcare le gambe in una materia collosa.
Pescata la cosa più larga a disposizione, una specie di tunica chiara, chiude la porta della camera da letto con la sensazione che il chiacchiericcio fra quei pezzi di stoffa non sia finito. Loro sanno di lei ciò che lei ha dimenticato, o fatto l’impossibile per dimenticare. La maglia di lana lasciata all’Irlandese, mettiamo, con tutto quello che è successo – be’, le pare che ci sia un suo segreto in giro, e soprattutto che sia indifeso.
Ancora sull’ingresso, Giovanna la abbraccia. Non dice niente, nemmeno ciao. La stringe. Luciana, che gli abbracci non li ama, a questo non si sottrae. Resta lì a lungo, con il mento sulla spalla di Giovanna, con il naso nel profumo forte. Resta fino quasi a sentire un po’ di nausea, e a sentire che le viene da piangere. Allora, per smorzare la commozione, dice all’amica una frase che non è da lei: “Non badare al disordine”.
Giovanna si mette a ridere, una risata eccessiva.
“Mi stai prendendo in giro?”
“No, non ti sto prendendo in giro. La casa fa schifo.”
“E noi ci siamo mai preoccupate che la casa faccia schifo?”
Luciana si sdraia sul divano, si scusa un po’ anche di questo: “Non so più come mettermi”.
“Non ti lamentare troppo,” le dice Giovanna, ridendo ancora con gli occhi dietro alle lenti. “Ti ricordavo più divertente.”
Cominciano a parlare di lavoro. Giovanna prova a discutere di tutto fuorché della pancia di Luciana. Racconta com’è diventato difficile sopportare il tizio che le sta addosso lì al ministero: la cosa che più le dà fastidio è il suo alito, e un dettaglio che trova penoso e allo stesso tempo buffo, i peli della barba più lunghi sotto il mento.
“È il primo segno di un uomo quando invecchia. La barba fatta male. I peli che sbucano dalle narici.”
“Quando spuntano dalle orecchie è anche peggio,” aggiunge Luciana. Si rimette seduta, stringe le mani attorno alla tazza da tè un po’ sbreccata. Fa parte di un servizio che le aveva regalato suo padre per festeggiare la casetta che si era presa in affitto. L’unico che avesse capito il suo desiderio. Sua madre lo trovava assurdo. Lei si era giustificata spiegandole che era una situazione provvisoria. Ma in effetti era ancora là. Le succedeva spesso, le sembrava di essersi solo distratta un po’ – un paio di giorni, due anni – e si era ridestata in una situazione che, nelle premesse, doveva durare pochissimo, niente.
Giovanna continua a parlare dei suoi guai in ufficio, di un telefax che sta imparando a usare.
Toccherebbe a Luciana dire qualcosa. Invece si alza, apre la finestra. “C’è odore di chiuso,” dice, ma lo sente solo lei.
Di Giovanna le è sempre piaciuta la scioltezza, la chiamerebbe così; e le ha sempre invidiato l’impressione che dà, di non tenere troppo in conto i propri difetti. Per dire, anche dei fianchi, che già a vent’anni aveva piuttosto larghi, se ne frega. Sembra che le cose la tocchino solo un po’: non troppo, non al punto di permettere che le facciano male.
Muove le mani velocissima, aggiusta di continuo gli occhiali sul naso, non sta ferma, e forse il trucco è questo, non stare fermi. Stare fermi, stare chiusi, stare in gabbia è il contrario di vivere.
“Dopo facciamo una passeggiata?”
Se ne esce così e Giovanna è un po’ spiazzata.
“E dove andiamo?”
“Anche solo al bar e ritorno.”
“Abbiamo appena preso un tè.”
“Che ti importa.”
Una volta che Giovanna le ha proposto di andare a comprare insieme due o tre vestitini per lui, Luciana si è innervosita. Perciò, l’amica non torna sull’argomento. E questo sì che è un paradosso, un inghippo che infatti finisce per bloccare la conversazione, per renderla innaturale.
Giovanna fissa qualcosa sulla parete. Luciana alza gli occhi. Due o tre minuti sembrano lunghissimi. Si sente nettamente il gorgoglio di uno stomaco. Visto che è il suo, Luciana ha il pretesto per cambiare discorso, lamentandosi del bruciore che non le dà tregua.
“Magari è anche l’ansia per la situazione al giornale.”
“L’ansia è un po’ per tutto. C’è solo quella.”
Giovanna allunga un braccio verso il tavolino basso per recuperare una copia del giornale. Se lo rigira fra le mani come un enorme origami.
“Si vede che non li leggi mai,” scherza Luciana. La aiuta, e le indica l’ultimo articolo.
“Hai mai pensato di buttarti sulla letteratura? Sarebbe più comodo.”
Luciana scuote la testa. Giovanna non aspetta la risposta e aggiunge: “Io sì”.
Si è iscritta a un corso di scrittura, in una libreria dietro piazza Mazzini, è un buco ma è carina, due ore ogni giovedì. Anticipa l’obiezione e se lo dice da sola che ormai non c’è un corso che non abbia fatto – cucina, cucito, meditazione. Che altro? “Ah sì, ti ricordi quando ho fatto quello di judo?, mi dicevate che ero pazza.”
Però queste lezioni sono meglio, sono una sorpresa tutte le volte. La tipa, la scrittrice, dà un’indicazione e lascia mezz’ora di tempo, non di più. L’ultimo giovedì ha chiesto di trascrivere un sogno. O meglio, di farne un racconto.
“E che sogno hai raccontato?” domanda Luciana.
“Me lo sono inventato. Io i sogni non me li ricordo mai. È una cosa che mi fa rabbia, quando ci penso. E così ho descritto un sogno erotico, che poi è un sogno che faccio da sveglia.”
“Non voglio saperlo.”
“Peggio per te. E tu, che sogno avresti scritto?”
Luciana è indecisa se raccontarlo. È un sogno vero, il suo, e l’ha atterrita.
C’era lei con le gambe aperte, urlava. Qualcuno, finalmente, estraeva il bambino. Lei si tirava su appena con la schiena, per vedere – e c’era questo neonato insanguinato che cominciava a correre, scappava, e più scappava più cresceva, diventava un bambino grande. Lei lo inseguiva, lui non si voltava, le dava le spalle. Quando finalmente lo raggiungeva, lui si girava di scatto, aveva una faccia come sfocata, impossibile da descrivere. E continuava nella sua corsa.
No, non glielo racconta, non vuole raccontarlo. Liquida l’argomento con un’alzata di spalle. Aggiunge: “Faccio solo sogni di merda”.
Cala nel salotto una specie di polvere triste, come se si fosse aperta di colpo una crepa nel soffitto. Un cielo grigiastro si agita fuori. Tutto è più difficile di come per qualche ora è sembrato.
Luciana tende l’orecchio quando sente il ronzio della motoretta del postino. “Sarà un libro,” dice. “È bastato scrivere un paio di recensioni e hanno cominciato a mandarmeli in omaggio. Non è male.”
Invece, spera che sia una lettera dell’Irlandese.
Non riesce a non pensare a lui, non riesce a nascondere la foga con cui separa le buste, le scorre in fretta, le lancia sul divano. Forse dovevo chiedergli di vivere insieme. Forse dovevo fargli capire meglio le cose, pensa adesso. Se lui torna, ce la farò. Qualche volta si chiede se non sia soltanto una stupida ossessione. Che ti prende?, si domanda, come lo dicesse a un’altra. Che cosa vuoi di preciso? Lui? Una famiglia con lui? Il desiderio che continua a provare – una sete – la fa sentire incompleta. Qualche volta tenta di sfogarlo, ma insieme al piacere arriva una specie di contrazione nella pancia, che la lascia più sola e colpevole.
Manda giù la saliva, si sfrega il collo chinando la testa, e per fortuna un dettaglio delle scarpe di Giovanna, un fiocco, le dà lo spunto per riemergere, con una battuta, dallo sconforto.
Fuori, camminano una accanto all’altra con lentezza eccessiva, come in punta di piedi, senza una direzione. Si fermano a guardare le vetrine, quasi una per una, fanno il gioco di puntare gli abiti impossibili, quelli che non possono permettersi: il prezzo, i colori. La taglia!
Contemplano divertite la concentrazione totale, estatica, di una signora che, alla fermata dell’autobus, lecca un cono gelato, benché oggi il tempo inviti più a qualcosa di tiepido. Socchiude gli occhi, è tutta in quel gesto.
Nel frattempo, ha cominciato a piovere. Niente di che, però non hanno preso l’ombrello.
Una goccia scivola precisa, tra stoffa e pelle, sul collo di Luciana: una sensazione di gelo che pare arrivare da lontano, da un’altra epoca, una stilla di era glaciale.
Si infilano nel primo bar, come previsto, tanto più che Luciana, alle solite, deve fare pipì. “Sto morendo,” dice.
Senza nemmeno chiedere un caffè, fa un gesto chiaro col dito, a cui subito risponde quello del cameriere. Occupato. Alla buon’ora sbuca, finalmente, una ragazza: giovanissima, chiara di capelli, molto truccata. Anche Luciana, adolescente, faceva così: andava a truccarsi nei bagni dei bar. Usciva di casa dopo le quattro del pomeriggio, dicendo di avere finito i compiti, ficcava in una borsa la trousse, e spesso pure un cambio. Giovanna le teneva la porta, e lei sbucava come da un camerino, ed era un’altra. Più adulta, vagamente più – sicura no, ma protetta, in maschera.
Ha invidiato la ragazza bionda. Entrando, si è sentita avvolta da una vampa calda – profumo e sangue mestruale – che, prima di nausearla, l’ha irritata come un’ingiustizia.
Giovanna vorrebbe accompagnare Luciana dal ginecologo, e prova a chiederglielo.
“La prossima volta.”
“Dici sempre così.”
“Te lo prometto.”
“Non mi fido.”
“Giovanna.”
“Sì.”
“Non sto bene.”
Lo dice – tetra, spaventata – cercando gli occhi dell’amica. Giovanna vorrebbe risponderle lo so, lo capisco, lo vedo. Invece le dice: “Non manca molto, devi avere pazienza”.
“Non è questo.”
“E cos’è allora?”
“Ho paura di impazzire.”
L’amica tace. Stringe le labbra, si passa le dita sugli occhi, dietro le lenti.
“Sento di non farcela,” dice Luciana.
“Penso che sia normale.”
“Normale è una parola che con la mia vita non funziona più. Voglio dire, io mi sforzo…”
“Lo so.”
“Mi sforzo di prendere le distanze da quello che mi sta capitando, ma…”
“Non puoi prendere le distanze da quello che ti sta capitando.”
“Ecco. Forse è questo il problema, non posso. Però ci provo, credimi. E sai cosa? L’idea che lui possa lasciarmi mi preoccupa più di tutto il resto.”
“Senti, Luciana. Tutto il resto. Che cazzo di espressione è tutto il resto?”
Giovanna ha alzato il tono di voce, è più acuto. “Non riesci a vedere nient’altro. Come se da lui dipendesse la tua vita.”
“Lo so che da fuori…”
“Da fuori niente, Luciana. Da fuori, da dentro.”
“Forse non capisci.”
“Capisco, te lo assicuro. Capisco che non sei lucida. Non sembri più tu, Luciana. Non puoi dipendere da lui. Non sai nemmeno dov’è. Non sai in quale buco di culo di mondo sia.”
“È a Dublino.”
“Sta bene là. Perché non torna?”
“Non lo so. Ma tornerà in tempo, me l’ha promesso.”
“È scappato quando gli hai detto di essere rimasta incinta.”
“Non è scappato. Lui fa così. Va, torna.”
“Uno spirito libero!” ride ironica Giovanna, e agita le braccia. “Uno spirito libero! Posso farti una domanda?”
“Fammela.”
“Pensi davvero che lui si senta legato a te? Vi conoscete da quanto? Sei mesi?”
“Dieci. E ti assicuro che sono stati così… così incredibili da sembrare molti di più.”
“Non sai nemmeno se il padre è lui.”
“Non sai nemmeno se il padre è lui.”
“Lo è.”
“Non puoi esserne sicura. E c’è quel povero cristo di Ettore che ti sta dietro, ti aiuta, si fa in quattro e tu…”
Si interrompe, si trattiene. Non vuole farle la predica. Non le piace la parte dell’amica razionale, pedante. Quella che mette i guantini e non si sporca con le cose, la professoressa di disegno tecnico. Ha ascoltato troppe volte la versione di Luciana su questo Irlandese – la storia del poeta che l’ha fatta sentire più viva.
La storia di quello che ti cambia la vita, che cambia anche te, quello di cui non potrai mai liberarti. Basta. Lui non c’entra niente con te, non può, non vuole darti niente, non lo vedi? Dovrebbe dirle questo, di nuovo. Le dice: “Io lo so cosa provi, lo so. Però aspetti un bambino, e invece di pensare a te stessa, almeno a te stessa, l’unica cosa a cui pensi è un tizio che non ha nessuna intenzione di fargli da padre”.
“Questo non puoi dirlo.”
“Questo non vuoi sentirtelo dire.”
Il bambino la saluta avvolto nella nebbia. Non è un sogno. Il monitor rimanda una sagoma chiara su fondo di pece. L’immagine è irreale, balla, si muove a scatti. Lei gli occhi li distoglie dopo poco, non vuole tenerli fissi lì.
Ho due cuori dentro, pensa, il mio e il, pensa, il mio e il suo. Il pensiero lo formula così. E non è una scoperta. Non è niente, sei tu.
Prima, nella sala d’attesa, ha guardato le altre. Non riusciva a concentrarsi sul romanzo che si è portata – un consiglio dell’Irlandese, Pao Pao. Sempre sulla stessa riga, come su un geroglifico. Andava avanti con sforzo, tornava indietro.
Allora ha alzato lo sguardo sulle altre: tutte così – l’aggettivo non lo trova. Diverse, e non fra loro, ma da lei. Serene? Difficile dirlo. E non vuol dire nemmeno rassegnate, ma di sicuro non in lotta.
Se fosse capace di attaccare discorso con una di loro – quella che sta una sedia oltre la sua e sfoglia una rivista, fermandosi su ogni pagina non più di due secondi, o quella bellissima, il viso lentigginoso, che si accarezza la pancia di continuo. Se fosse capace, chiederebbe solo questo: ma voi come vi sentite? Però sinceramente, seriamente. Non avete mai l’impressione che sia tutto finito? Che ogni cosa sia scritta, irreversibile, senza alternative?
Non si accorge che una ragazza senza pancia la guarda con invidia.
Nuda sul lettino, sente il medico che traffica fra le sue gambe divaricate, cerca di distrarsi girando il viso verso la finestra. Le tende impediscono di vedere fuori, ma sul davanzale incrocia il volto di una madonnina di gesso e non riesce a decifrarlo…