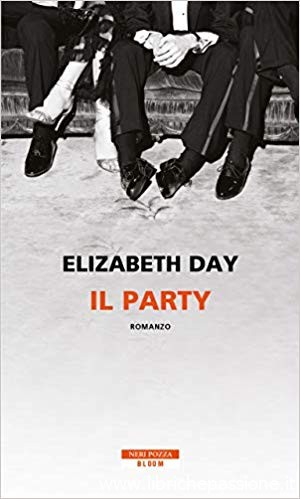L’ombra di Caterina
Autrice: Marina Marazza
Casa editrice:Solferino
Genere: Romanzo storico
data di pubblicazione: 2 Maggio 2019
Trama
«Oggi è festa. Nella chiesetta del borgo battezzano il mio bambino. Io non ci potrò essere, ufficialmente: devo stare nascosta.» Comincia così il racconto di una donna che la Storia ha a lungo dimenticato: Caterina, la madre di Leonardo da Vinci.
Giovane popolana, sedotta dal notaio ser Pietro da Vinci, Caterina rimane incinta di un figlio che non potrà allevare: lo allatta, ma le viene tolto dalle braccia per essere cresciuto nella casa paterna. Il suo bellissimo bambino potrà godere di molti più agi, certo, ma rimarrà sempre un bastardo: non erediterà né titoli né proprietà e dovrà vivere solo del suo ingegno.
Anche la vita di Caterina non sarà facile: l’accusa di stregoneria, il matrimonio con un ex soldato di ventura, cinque figli da crescere, e sempre il rimpianto per quel primogenito perduto che può vedere solo da lontano.
Leonardo si trasferisce a Firenze, entra nella bottega del Verrocchio, manifesta ingegno e talento al di là di ogni previsione, ma si trova macchiato da un’accusa di sodomia. Meglio partire per una città più grande, più libera, piena di opportunità, la Milano degli Sforza. Madre e figlio sono destinati a non rivedersi mai più? O Caterina potrà riunirsi a Leonardo, coronando il sogno di stargli vicino, che ha dato luce e senso alla sua intera vita?
Marina Marazza intreccia un’accurata ricostruzione d’epoca a una trama narrativa ricca di svolte inattese, popolata di personaggi e splendente di dettagli. E riporta in vita le vivide figure di un genio del Rinascimento e di una donna indomita e libera, intessendole in una storia appassionante d’amore, rinuncia e perdono.
Estratto
A tutte le madri i cui figli voleranno lontano.
Anche alla mia.
Benché le pernici rubino l’ova l’una all’altra,
non di meno i figlioli, nati d’esse ova,
sempre ritornano alla lor vera madre.
Leonardo da Vinci
Prologo
L’acqua che tocchi de’ fiumi è l’ultima di quella che andò
e la prima di quella che viene. Così il tempo presente.
Leonardo da Vinci
Milano, 1494.
Uscendo da Santa Maria delle Grazie mi sembrò che il gradino del montatoio della carretta fosse diventato alto il doppio di quando ne ero discesa poco prima. Invece il veicolo era sempre quello con cui eravamo arrivati lì e anche il conducente che ci aveva aspettato fuori della chiesa era lo stesso.
«Ti sei stancata troppo, Caterina?» chiese subito Leonardo, aiutandomi a prender posto.
«Oh, no» lo rassicurai. «Sono contenta di essere venuta.»
Mi afflosciai sui cuscini, perché avevo la sensazione che il mio corpo non m’obbedisse più: mi aveva presa una grande stanchezza, ma la mente era molto lucida.
Leonardo non si avvide del mio malessere, perso dietro le idee che gli si stavano affollando nella mente per dipingere l’Ultima cena sulla grande parete bianca del refettorio dei frati.
«Non sarà un affresco. Non è una tecnica che mi appartiene, quella. Voglio poterci pensare e ripensare. Voglio poter modificare, aggiungere, rifare.»
Lo ascoltavo sorridendo. Ormai il bambino che avevo messo al mondo e nutrito col mio latte era un uomo fatto, l’ingegnere di corte degli Sforza che progettava le città e imbrigliava le acque, il pittore che aveva dipinto ritratti lodati perfino dai poeti. Il mio Leonardo.
Procedendo verso la sua bottega ci pareva che il fermento per le strade di Milano già sempre trafficate aumentasse. Il Boltraffio, Zoroastro da Peretola e Marco d’Oggiono erano in strada, fuori della Corte Vecchia, e i lavori del gran cantiere del duomo parevano interrotti: le impalcature erano deserte e, invece di andare avanti a posare i blocchi di marmo rosato e le vetrate colorate, gli operai si erano riuniti in capannelli per parlare, commentare, consultarsi con una certa frenesia con i passanti altrettanto animati.
«Si dev’essere già diffusa la notizia della morte di Galeazzo Maria Sforza» esclamò il Salaino, seduto vicino a me.
Fuori della bottega il Boltraffio per primo vide avvicinarsi la nostra carretta e ci venne incontro. «Maestro! Pare che Ludovico il Moro sia uscito dal castello tutto vestito d’oro, con in pugno la spada, a farsi proclamare duca di Milano a furor di popolo, ora che suo nipote non c’è più.»
«Lo dicevano gli astri» aggiunse Zoroastro.
Da Porta Giovia proveniva un rumore sordo, come il coro di una folla inneggiante. Le parole diventavano più intelligibili man mano che il corteo si approssimava alla piazza.
«Lunga vita al duca!»
«Moro! Moro!»
«Entriamo in casa» disse Leonardo al conducente. «Presto.»
Ai piedi dell’enorme cavallo di creta che probabilmente non sarebbe mai diventato un cavallo di bronzo raccolsi le forze per scendere dalla carretta, ma le gambe mi si piegavano sotto.
Mi posarono sul letto con il mio bell’abito nuovo azzurro e pensai che sarei stata contenta di morire con quello addosso perché era stato Leonardo a donarmelo.
Mi ci erano voluti più di quarant’anni per arrivare a stargli accanto. Una vita intera prima di sentire la sua bella voce calda chiamarmi «madre».
Ma ne era valsa la pena e avrei rifatto tutto quanto.
Dall’inizio.
Parte prima
L’ostrica, quando la luna è piena, s’apre tutta,
e quando il granchio la vede, dentro le getta qualche
sasso o festuca: e questa non si può risserrare,
ond’è cibo d’esso granchio.
Leonardo da Vinci
1
Proposta di matrimonio
Mia sorella Lisa aveva vent’anni e già cominciavano a chiamarla zitella. Non che fosse brutta. Aveva preso i capelli scuri e lisci del babbo e forse anche la sua corporatura un poco tozza, ma tutto sommato era di aspetto gradevole. L’incarnato era ambrato ma senza macchie, gli occhi grandi e intelligenti. Era la più brava e la più veloce a strappare le erbacce nella vigna e vederla raccogliere le olive con le sue mani forti e delicate al tempo stesso era uno spettacolo, arrampicata su per la scala di legno con la cesta legata alla vita. «Bisogna stare attenti, l’albero si può ammalare, se lo maltratti» mi diceva. «E questo vale anche per noi umani.» Lisa era saggia e sapeva sempre come fare: mi insegnava tante cose, in casa e nei campi. Ero con lei la prima volta che a undici anni avevo visto il sangue del mio mese e le era toccato di spiegarmi che cosa mi stava succedendo. «Ora sei in età da marito, attenta a quel che fai» mi aveva raccomandato, orgogliosa che la sua sorellina fosse diventata una donna.
«Mi vuole Duccio del frantoio» mi disse sottovoce una sera di marzo mentre rigovernavamo dopo mangiato, quando i fratelli esausti per il lavoro nei campi erano già andati a dormire. Era l’epoca della zappatura, la terra andava rivoltata zolla per zolla, ti spaccavi la schiena e anche le braccia. «L’ho incontrato fuori della chiesa e m’ha detto che parlerà con Cambio.» Cambio era il nostro fratello maggiore, che dopo la morte del babbo era diventato il capofamiglia. Ora stava russando a bocca aperta, appoggiato all’indietro sul muro, seduto sulla panca dove aveva appena finito di divorare la zuppa, fulminato dalla stanchezza. Mentre raccontava, Lisa strofinava energica la ciotola che teneva in mano per pulirla e rimetterla sopra la madia, senza perdere tempo.
Io invece mi ero immobilizzata con lo straccio zuppo sospeso in aria come il fazzoletto di una dama che saluta il suo campione al torneo. «Duccio è vedovo, ha quarant’anni suonati e due figlie quasi della nostra età» le risposi, stupita.
Lei si tirò indietro una ciocca che le ricadeva sulla fronte usando l’avambraccio nudo, perché si era rivoltata le maniche fin sopra il gomito per non bagnarle. «Ha anche un frantoio» ribatté secca. «Chi vuoi che mi prenda in moglie, con due polli macilenti per dote? Non sono bionda e fresca come te. Siamo anche in gran debito con ser Piero da Vinci per l’affitto. Lo scorso anno le olive son state stente. Duccio è un’ottima soluzione. Un brav’uomo, generoso. Sarò una bocca di meno da sfamare a questa tavola e andrà meglio per tutti.»
Mi era preso il panico. Non avevo mai pensato seriamente che Lisa se ne potesse andare, anche se era nell’ordine delle cose, lei era la maggiore e anzi, di solito ci si sposava più per tempo, solo che la morte del babbo e le nostre condizioni economiche non avevano attirato molti pretendenti.
Avevo bene in mente Duccio di Bosco Zampi. Possedeva un frantoio dove qualche volta avevamo portato le nostre olive e in questo modo lui ci aveva conosciute fin da bambine, me e Lisa, anche se erano sempre i nostri fratelli Cambio e Pantaleo a trattare con lui. Di solito si prendeva una quota del raccolto in cambio della spremitura. Al locatore di casa e campo spettava addirittura la metà, e a noi restava sempre ben poco. Me lo ricordavo bene, Duccio, aggirarsi intorno alla macina trainata da un mulo bendato e incitarlo col bastone e con la sua voce rauca: «Via, via, Bigio!». Da piccola mi faceva paura. Lo chiamavano «frantoio a sangue», quello azionato da un animale, perché era mosso dallo sforzo immane della sventurata bestia, venuta al mondo per girare in tondo in una fatica senza fine. C’era qualcosa di disumano in un simile sfruttamento.
«È quello che ha ammazzato il mulo» dissi in un soffio. Era bello, tutto grigio, col muso intelligente. Lo accarezzavo sempre quando portavamo le olive o andavamo a ritirare gli orci d’olio. E poi un giorno Bigio non c’era stato più e al suo posto era legato un altro mulo nero tutto ossa.
Mi ricordavo di quel che avevano detto in paese, che Duccio per avidità durante l’ultimo raccolto aveva sfiancato la bestia fino a farla morire.
Lisa alzò le spalle. «Sciocchezze. Il mulo s’è ammalato, può capitare. Lui non avrebbe avuto interesse a maltrattarlo, ragiona, con quel che costa comperarne uno nuovo.»
Lasciai cadere la ciotola che stavo lavando dentro il mastello di acqua calda saponata e già unta. «E sua moglie? Non gli avevano detto che undici gravidanze erano troppe per una col suo fisico delicato? Insisteva, continuava a metterla incinta, ma i bambini morivano appena nati. Te la ricordi, debole come un uccellino, alla messa di Natale? Dopo, è durata sì e no una settimana.»
«Che cosa avrebbe dovuto fare lui? È un buon cristiano, un marito fedele, la sua sposa doveva pure soddisfare i suoi bisogni. Anche don Masetto ha detto che è stata la volontà di Dio. E comunque due figlie sono ancora al mondo.»
«Come fa Dio a volere cose tanto brutte?» risposi. Mi si riempirono gli occhi di lacrime. «Che un bambino nasca e muoia senza aver assaggiato la vita? E nostra madre? Aveva trentacinque anni quando se n’è andata sputando sangue, ed è stata la volontà di Dio?»
Lei mi tirò uno schiaffo secco sulla nuca con la mano bagnata. «Come parli? Vuoi che ti sciacqui la bocca nell’acqua delle ciotole?» Ma vide che stavo piangendo e si rabbonì subito. «Non devi reagire in questo modo.»
«Ho paura per te» risposi spassionatamente.
«Non devi. Starò bene. Lui ha bisogno di una donna in casa, una delle sue figlie sta per maritarsi e l’altra sarà monaca. Vuole un erede maschio e se glielo darò sarà generoso. Ne verrà del bene anche per tutti voi.»
«E se non glielo darai? E non rispondermi che sarà la volontà di Dio.»
Lisa aggrottò le sopracciglia. «Invece di parlare a vanvera, bisognerà che cominci a pensare anche tu a sistemarti. Il Buti ha occhi solo per te, chiunque se ne accorgerebbe. E mi pare che le sue intenzioni siano serie, solo che tu gli sfuggi come una lucertola e lui è troppo orgoglioso per esporsi a un rifiuto.»
Avevo sedici anni e credevo ancora di tenere il mondo tra le mani. Guardai Lisa come se fosse pazza. «Tonio Buti del Vacca?»
«Proprio. Quello che faceva il soldato. L’Accattabriga, insomma.»
Come suo fratello Andrea che ancora era in milizia, Tonio aveva fatto il mercenario al soldo del capitano Samperoli. Durante le guerre di Lombardia, aveva combattuto con i veneziani contro i milanesi, ma poi il quadro delle alleanze si era ribaltato. Tonio nel frattempo era rimasto ferito ed era tornato al paese con qualche moneta come congedo, uno sfregio rossastro che gli tagliava la faccia dalla fronte al mento socchiudendogli l’occhio destro e una gamba rigida. Era stato un bel giovanotto, come tutti quelli della sua famiglia, alto e robusto. Adesso aveva la faccia aperta a metà e il bastone che usava per sostenere meglio la gamba offesa diventava un’arma nelle risse. La guerra lo aveva trasformato a neanche trent’anni in un reduce violento e mezzo invalido.
«Credevo che mi volessi bene, sorella» risposi, sempre più confusa. Davvero pensava che non potessi aspirare a niente di meglio? «È zoppo e sfregiato e se lo chiamano l’Accattabriga un motivo ci sarà.»
«Quello è il soprannome da soldato perché il suo comandante si chiamava così. Ha solo bisogno della donna giusta» tagliò corto lei. «La bellezza se ne va con la gioventù, comunque. E ricordati che con i soldi del congedo lui ha affittato la fornace del convento delle suore.»
«Peccato che passi più tempo in giro e in osteria che a impastare argilla» risposi petulante. «Doveva consegnarci tre anfore due mesi fa e non sono ancora pronte.»
«Perché non fai un salto a chiedergli a che punto è? Te l’ho detto, gli manca una moglie. Quando ti guarda gli si addolciscono gli occhi.»
«Peggio per lui!»
Dovevo aver parlato troppo forte perché Cambio si svegliò di soprassalto e imprecò. «Ma cos’è tutto questo starnazzare, donne? Non si può nemmeno chiudere gli occhi a casa propria dopo essersi spezzati la schiena tutto il santo giorno, Dio buono?»
Lisa gli andò vicino. «Mettiti a letto, non puoi dormire così sulla panca.»
Per tutta risposta, lui allungò il braccio e le mise la mano aperta sul fondoschiena, palpando tra le pieghe della gonna. Lei si sottrasse svelta al contatto, senza dir nulla. Non era la prima volta che Cambio allungava le mani, quand’era stanco e aveva bevuto, con lei e più raramente anche con me. Biondo, grande e grosso, il maggiore dei miei fratelli era quello che mi somigliava di più, anche lui aveva preso i colori della mamma e la vita nei campi lo aveva irrobustito. Alla fine si alzò brontolando, strascicando i piedi nudi negli zoccoli in direzione del suo pagliericcio. «Di che stavate discutendo, galline?»
«Duccio del frantoio ti chiederà di prendermi in moglie» riassunse Lisa.
«Buon per te» farfugliò Cambio, lasciandosi cadere sul suo giaciglio, girandosi verso il muro e rimettendosi subito a russare.
Lo prendemmo come un sì. Quando si è poveri non si può andar molto per il sottile.
«Duccio non è l’unico ad aver bisogno di ammogliarsi» osservai sottovoce, lanciando un’occhiata in tralice a nostro fratello addormentato. Sapevamo entrambe che a Cambio piaceva Berta, la figlia di Peppo il somaio, ma suo padre faceva resistenza: sperava in un partito migliore per la sua figliola. Cambio era bello, forte, lavoratore, ma senza un soldo e con troppi fratelli e sorelle. Andandosene da casa Lisa facilitava la vita a tutti, liberava un posto per la sua futura moglie.
Lei mi guardò seria. «L’Accattabriga aspetta solo un tuo cenno, credi a me. Vattene anche tu da qui prima che puoi, quando l’uva è matura a non coglierla marcisce.»
Forse avrei dovuto davvero seguire il suo esempio.
2
Viva gli sposi
Quell’agosto le nozze di Lisa con Duccio sembrarono un rito pagano dell’estate. Il corteo nuziale era composto di giovani dei dintorni che cantavano e danzavano come a calendimaggio, rossi in viso e ridenti, coronati di fiori. Qualche fanciulla era fin troppo discinta, con le braccia nude e le spalle e i seni quasi scoperti.
Gridavano motti sconci, si facevano beffe degli sposi, ripetevano i ritmi antichi dei cori di sempre, come il Contrasto di santa Caterina, contesa tra angeli e diavoli. Cantavano con le loro voci forti e sgraziate, superandosi negli acuti, e i giovani uomini guardavano dalla mia parte ammiccando perché anch’io mi chiamo Caterina.«E tu, Cate, sei santa o sei diavola?» ripetevano, allegri.
Molti di loro li conoscevo, erano nostri vicini. Zita degli Ulivi Bassi, che si era cresimata con me, mi si avvicinò ridendo e camminammo vicine per un tratto. «Ho sentito che ser Piero da Vinci è tornato al paese ieri» mi disse, tornando seria.
Sapevamo bene tutte e due che cosa significava: anche la sua famiglia era a pigione come noi e quando il padrone ti viene a trovare non lo fa per cortesia, ma per chiedere il dovuto.
«Lo dirò ai miei fratelli» risposi, mentre i cantori intonavano la storia del cavaliere che mette in guardia la pastorella incauta dal lupo che si mangia la pecora. La pastora piange, il cavaliere apre la pancia del lupo con la spada e fa saltar fuori la pecorella, chiedendo un bacio per ricompensa, ma lei glielo nega perché è fanciulla onorata e se glielo concedesse correrebbe il rischio di rimanere zitella. E qui il corteo si scatenò di nuovo in altri lazzi e scherzi di pessimo gusto, mimando la ritrosia della fanciulla.
L’Accattabriga, che non si era fatto tutto il tragitto a piedi con gli altri, preferendo aspettare vicino alla chiesa di San Pantaleone, meta del festoso corteo con in testa Lisa e Duccio, mi si affiancò.
«E tu gliel’avresti dato il bacio al cavaliere, se fossi stata al posto della pastora?» mi chiese, scherzoso. Masticava un lungo filo d’erba per darsi un contegno e camminava abbastanza spedito, appoggiandosi sì e no al suo bastone ricavato da un ramo di nocciolo. Era più alto di me di una spanna buona, si era vestito meglio del solito ed emanava un odore come di argilla calda, non sgradevole. Le unghie delle sue mani forti e callose erano pulite, non come quelle dei miei fratelli, sempre orlate dello sporco del lavoro contadino.
Scossi la testa. Dalla mia parte vedevo solo il lato buono della sua faccia, quello che era rimasto illeso dal colpo di spada, e così di profilo era un bell’uomo.
«Stai bene con i capelli sciolti e la corona di fiori» mi disse, sforzandosi di continuare la conversazione. Non era abituato a fare troppi complimenti e io di certo non lo incoraggiavo.
Intanto eravamo arrivati sul sagrato della chiesa dove Lisa e Duccio levarono alte le mani legate strette dai nastri rossi, come tradizione vuole, per mostrare a tutti la loro unione e il loro impegno reciproco, e il vecchio celebrante li proclamò marito e moglie.
Lisa era bella con in testa il velo che era stato della mamma, il suo vestito migliore di un azzurro pallido stretto in vita da una cinturina di pelle chiara ricamata che le aveva regalato il suo promesso. Duccio le aveva anche donato un anellino d’argento che era stato della sua prima sposa e le aveva tolto quand’era morta, prima di chiuderla nella bara. Personalmente lo avevo trovato macabro, ma Lisa se l’era infilato senza paura, ritenendolo un bel gesto. L’avevo pettinata io, una gran treccia scura che le scendeva sulle spalle, e avevo aggiunto qualche fiore di campo.
Mi ero messa una gonna marrone che era stata anche quella della mamma e a me andava un poco corta, mostrava le caviglie. Le avevo belle, snelle, da puledra, e non mi dispiaceva che si vedessero. Sopra avevo la camicia bianca della domenica e un corsetto scuro.
«Adesso che la tua sorella maggiore è andata sposa, toccherebbe a te» commentò l’Accattabriga, mentre ci dirigevamo verso il frantoio di Duccio. Fuori dall’edificio di pietra avevano messo dei tavoli di legno per il banchetto nuziale, offerto dallo sposo. Un porcellino stava arrostendo sullo spiedo da ore e l’odore della carne e degli aromi si spandeva intorno, invitante e nauseabondo al tempo stesso, quando il grasso colava sulla fiamma.
Sapevo dove voleva andare a parare. «Sono poi venuti pronti i tre orci che i miei fratelli ti avevano commissionato?» risposi, cambiando volutamente argomento e sperando di metterlo in difficoltà. Un poco il suo interesse mi lusingava, ma di notte sognavo un uomo giovane e sano dentro il mio letto, e lui di sicuro non rientrava più nella categoria.
Assentì. «Da un pezzo. Ma nessuno è più venuto a richiedermeli. Potrei portarveli magari domani al vespro, così farei due parole col tuo maggiore.» Mi scrutava e aspettava una risposta. Era chiaro quel che mi stava dicendo: se vengo a chiederti in moglie a Cambio, tu non ti opporrai? Era un modo di procedere normale, ma di solito i due promessi sposi si mettevano d’accordo prima della richiesta formale al capofamiglia, in modo da non far figuracce e non perdere tempo. Poi gli uomini sistemavano i dettagli. Tonio non era certo ricco, ma la fornace in affitto era sempre meglio delle nostre poche staia di campo. Tra i due quella più affamata ero io. Però potevo mettere sul piatto della bilancia la mia gioventù, la mia bellezza e il fatto che nostra madre era stata feconda, cosa della quale aveva tenuto conto anche Duccio quando aveva scelto mia sorella Lisa.
A proposito di Duccio, ora che si era ammogliato pareva contento e sorrideva più del suo solito, stando allo scherzo con gli uomini intorno che gli lanciavano delle battute sulla
prossima notte di nozze.
«Siedi e mangia, che stasera devi essere in forze!» celiava Peppo il somaio che non voleva dare la sua primogenita Berta a mio fratello. Costruiva bei basti di legno per gli animali da soma, era amico di Duccio e non aveva portato sua figlia al matrimonio, probabilmente per evitare che s’incontrasse con Cambio.
Per l’occasione Duccio si era messo in ghingheri, con le brache marroni, una camicia giallastra e un farsetto ricamato. Non sembrava affatto elegante, però, anzi, quegli indumenti attillati accentuavano le sue gambe storte, le sue spalle curve, la sua pancia molle.
«Guarda che lei è carne fresca, mostrati all’altezza!» gridò qualcuno.
Altroché: Lisa poteva essere sua figlia e vederla seduta vicino a lui che le appoggiava il braccio sulle spalle nude pesandole addosso con aria di possesso mi faceva salire dentro una specie di disgusto. In campagna, sappiamo molto bene che cosa succede tra un uomo e una donna. Vediamo fin da piccoli gli animali che si accoppiano e dentro le nostre case non ci sono dieci stanze con le porte chiuse: ci si ammucchia come si può e si sa bene quando madre e padre fanno sesso. Me li immaginavo, lui nudo, ansante e peloso sopra la mia Lisa, e mi veniva la nausea.
Seduti davanti a Duccio, i miei fratelli avevano già cominciato a bere vino dalle brocche, ancora prima che mettessero in tavola le assi di legno con sopra le cibarie. In particolare Cambio, deluso dall’assenza di Berta, ci dava dentro con tanta foga che il liquido rosso dal boccale gli scorreva sul mento.
«Viva gli sposi!» gridò, fingendo allegria.
Per quanto riguardava le figlie di Duccio, una si era sposata a maggio, era andata a stare nel paese del marito, giù verso Siena, e non era tornata per il matrimonio del padre. L’altra, quella che sarebbe andata al convento delle Clarisse, era lì presente. Me la ritrovai vicina, pallida e vestita di scuro, con una cuffia bianca che le copriva i capelli. Era suppergiù della mia età, con la faccia di suo padre, la stessa espressione corrucciata che lui mostrava tutti i santi giorni, e aveva accanto come accompagnatrice una zia molto anziana che sorrideva vacua.
Un poco per evitare di rispondere a Tonio l’Accattabriga ancora in attesa di un mio cenno di conferma per venire a parlare con Cambio, un poco per curiosità, decisi di rivolgerle la parola. Non ci conoscevamo perché lei non era vissuta al borgo, ma in un altro abitato verso Firenze, da quella zia anziana che adesso le stava vicina. Però in qualche modo eravamo diventate parte della stessa famiglia.
«Sono Caterina» le dissi, cercando di intercettare il suo sguardo sfuggente.
«Sei la sorella della sposa?» mi chiese. Aveva gli occhi orlati di rosso e si mordeva le labbra.
«Sì, e tu devi essere Lauretta.»
Stavano arrivando salsicce, cacio, focacce, verdure, frittate, pesce minuto, fegatelli di pollo, un gran ben di Dio per una tavola di gente semplice. Duccio aveva fatto le cose senza risparmio.
Ogni volta che portavano un nuovo tagliere si levavano esclamazioni approvanti e subito i commensali allungavano le mani e si servivano, chi usando un pezzo di pane come vassoio, chi prendendo un piatto di legno. Non c’era tovaglia sulle lunghe assi montate sui cavalletti che fungevano da desco nuziale e nemmeno posate, ciascuno si arrangiava con buona volontà. Gli uomini avevano tirato fuori di tasca i coltelli e così fece anche Tonio, seduto vicino a me. Sapevo già che mi avrebbe tagliato il cacio, il pane e la salsiccia e non ne ero felice: c’era una certa confidenza, in quel gesto, come fa un uomo con la sua donna. Ma non potevo rifiutare la cortesia.
Senza parlare, lui versò dalla brocca a me e a Lauretta con un certo garbo. Lei lo ringraziò chinando il capo.
«Siete promessi?» mi chiese.
«No, no» mi affrettai a rispondere. Lo sapevo che quella vicinanza poteva generare malintesi. Lei mi guardò storta per la mia reazione troppo vivace.
«Non ancora» buttò là Tonio, con un sorriso teso.
«Non ci sarebbe niente di male, saresti fortunata, non come me, che finirò a fare la serva dentro un convento di clausura. Vorrei esserci io al posto tuo» mi rimbeccò Lauretta.
Lanciai un’occhiata preoccupata alla zia seduta alla sua destra, ma la vecchia sembrava troppo presa a ingurgitare purea di fave, una delle poche cose che le sue gengive sdentate le permettevano di mangiare.
«È sorda» mi rassicurò Lauretta. «Non sente.»
«Dicono che fare la monaca non è così male, non devi per forza appartenere a un uomo che magari non ti garba, non devi far figli uno dietro l’altro…» Avrei voluto aggiungere: come tua madre, ma mi trattenni.
Lei scosse la testa. «Sai come chiamano le Clarisse di Santa Margherita? Le insaccate. Perché ti mettono una tonaca grezza, ti rapano a zero, chiudono il portone e buttano la chiave. Mio padre non ha una gran dote da dare al convento e se mi prendono è per farmi lavorare come il mulo che lui tiene alla macina, né più né meno.»
L’immagine del mulo mi colpì di nuovo come un pugno in faccia. Mi tornò in mente il Bigio e dovetti inghiottire un paio di volte per respingere il nodo in gola. Lauretta aveva occhi grandi con le palpebre pesanti, una faccia irregolare e della peluria scura sopra il labbro distorto in una smorfia di sofferenza mentre mi raccontava a bassa voce quel che l’aspettava. Somigliava un poco al Bigio, a dirla tutta. Le misi una mano sul braccio e strinsi, cercando di darle coraggio. Lei prese un pezzo di pane scuro dalla tavola e lo ruppe tra le dita.
«Non riesco a perdonarlo, ma forse non può fare altro. Lo vedi, non sono bella e quel poco che lui aveva l’ha impiegato per maritare la mia sorella maggiore e per trovarsi una moglie per lui. Non vuole morire senza eredi maschi. Per me non restano neanche le briciole.»
«Magari non andrà così male. Ti farai delle amiche, imparerai cose nuove. Ho sentito che molte monache sanno leggere e scrivere, perfino» le dissi, un poco in affanno.
Lei prese il boccale del vino e bevve un sorso, soprappensiero. «Ci sono già stata per un anno, al convento. Mi hanno fatta uscire per il matrimonio di mio padre, poi tornerò dentro e il legato delle monache mi domanderà se è mia volontà prendere il velo. Non mi sono fatta delle amiche. Un’altra novizia aveva rubato un fazzoletto dalla lavanderia e ha accusato me. La superiora non mi ha creduta perché l’altra era la figlia di un benefattore del convento e mi ha fatto stare in ginocchio sui ciottoli per una notte intera. Le piaghe non sono ancora cicatrizzate, te le mostro?»
«Allora devi rispondere di no al legato.»
Lauretta mi guardò sopra l’orlo del boccale. «Mio padre ha detto che se lo faccio mi ammazza. Mi ha mostrato anche la roncola che tiene attaccata al muro nel frantoio con gli altri attrezzi. Mi vuole sgozzare con quella.»
Guardai Lisa seduta dall’altra parte del tavolo, che faceva del suo meglio per sembrare contenta e si lasciava strapazzare affettuosamente dal suo novello sposo che, sempre più pieno di vino, le batteva sulla schiena, le toccava i capelli, le sussurrava all’orecchio qualcosa con aria lasciva e poi sghignazzava forte. L’avevo sempre saputo che Duccio era una bestia. E lo sapeva anche lei.
Intanto Tonio aveva attaccato discorso col suo vicino e la zia di Lauretta si era appisolata chinando il mento sul petto come fanno i vecchi. Nessuno aveva seguito la nostra conversazione.
«Mi dispiace tanto» balbettai. Non potevo far finta che andasse tutto bene. Non potevo liquidarla con una frase rassicurante. «Non so cosa fare.»
Lei mi rivolse qualcosa di simile a un sorriso. «Nessuno mi può aiutare, lo so.»
Capita tante volte nella vita di venir sfiorati dalla disperazione degli altri ed è raro che ce la prendiamo veramente a cuore: ci sembra sempre che i nostri guai siano peggiori dei loro.
L’odore del porcello arrosto servito bollente si diffondeva per tutta la tavolata mentre lei mi sussurrava: «Ti auguro di maritarti e di vivere». Non aggiunse: «felice», disse solo: «di vivere». Come se fosse già qualcosa. Si alzò e si allontanò verso l’interno del frantoio.
Finito di divorare l’arrosto, la gente cominciò ad alzarsi dal tavolo per ballare.
Pensai di unirmi alle danze, certa che Tonio non avrebbe potuto seguirmi; dubitavo che avesse voglia di farsi schernire per la gamba rigida, ma fui punita per i miei cattivi pensieri. Furono i miei fratelli e non Tonio a dare un brutto spettacolo, infatti. Ci fu un gran trambusto quando Cambio si avventò all’improvviso su Pantaleo e tutti e due finirono a rotolarsi nell’erba, avvinghiati. Tonio si mosse per primo, nonostante il bastone, e non ci mise molto a separarli, mentre io guardavo spaventata.
«Ma che fate?»
L’Accattabriga scosse la testa, risistemandosi il giubbetto che si era aperto nella foga del corpo a corpo. «Hanno bevuto troppo. È meglio che andiate a casa, tanto la festa sta finendo.»
Pantaleo ci guardava in cagnesco, ancora ansimante. «Vuoi comandarmi a bacchetta, zoppo?»
Trattenni il fiato.
La contesa stava attirando l’attenzione di qualche altro invitato. Per fortuna gli sposi stavano danzando un poco più in là un trescone scatenato con un cerchio di gente intorno che cantava a squarciagola e batteva le mani, e Duccio si esibiva saltando come un invasato per dimostrare di essere ancora un uomo nel pieno delle sue forze, in grado di tener testa a una
moglie giovane. Era rosso e sudato e pensai che magari gli sarebbe preso un colpo. Non che glielo augurassi. Però confesso che mi venne in mente.
Tonio non perse la calma. «Tu e Cambio dovete smaltire la sbornia senza far danni al matrimonio di vostra sorella. Non sfidarmi, lo sai che anche con la mia gamba rigida ti farei mangiare la polvere. Vuoi provare?»
Per essere un Accattabriga, aveva reagito abbastanza blandamente alla provocazione.
Pantaleo, che conosceva la sua fama, non ritenne prudente insistere e si allontanò imprecando con l’andatura ondeggiante degli ubriachi. Cambio era come svenuto e Tonio lo caricò senza tanti complimenti su un carretto a stanghe. Lui da una parte e io dall’altra, ci avviammo verso casa, senza parlare. Faceva un gran caldo e le ruote sobbalzavano sui ciottoli. Mosche verdi scintillanti ci ronzavano intorno, attirate dal nostro sudore. Tenevo gli occhi bassi sulla strada, vergognandomi per il comportamento dei miei fratelli. Tonio non approfittò della situazione per insistere nelle sue profferte e lo apprezzai per questo.
«Grazie» gli dissi di tutto cuore, quando fummo in vista della nostra casupola. Cambio era pesante e da sola non ce l’avrei fatta. La fatica era stata tanta. «Ora me la cavo.» Mi sentivo in colpa nei suoi confronti, in fondo lui si era comportato bene con me.
Tonio alzò le spalle, come a dire: niente, figurati. «Ricordati di rendere il carretto a tuo cognato, è uno di quelli del frantoio.»
Mio cognato, giusto, avevo anche un cognato, adesso. Tonio si allontanò col suo passo disuguale, mentre io tiravo in piedi Cambio che si stava riprendendo e, sorreggendolo di peso, lo conducevo verso la porta. Si fermò a vomitare un paio di volte, schizzandomi gli zoccoli, poi si pulì la bocca con la mano, cercando di mettermi a fuoco.
«CateCateCate» cantilenò, alitandomi addosso fiato acido.
«Vieni a sdraiarti, non stai bene.»
«Quel vino era cattivo» farfugliò.
Meno male, se no chissà quanto ne avrebbe bevuto. «Ora ti passa, ti prendo dell’acqua così ti sciacqui la bocca.»
Eravamo già dentro e lui si appoggiava alle mie spalle. Allungai la mano verso la brocca, poi sentii una specie di grugnito, lo vidi raddrizzarsi, come se di colpo avesse ripreso vigore e mi ritrovai sbattuta sul ripiano del tavolo con la gonna sollevata. Mi stava dietro con le brache aperte e cercava di penetrarmi con il suo membro duro, spingendomi contro il ripiano ruvido, tenendomi giù la testa con la mano destra, stritolando la mia coroncina di fiori e schiacciandomi la faccia sul legno intanto che con l’altra mano mi frugava tra le gambe.
Gridai forte. «Cambio, per l’amor di Dio! Sono tua sorella, che stai facendo?»
Non mi ascoltava. Come una specie di grosso coniglio infoiato, ansimava contro le mie reni. Forse nel suo delirio ero la figlia del bastaio. Sentii la rabbia che mi saliva dentro.
«Mi sciupi la gonna della mamma» protestai, assurdamente, a denti stretti.
Ero praticamente sdraiata sul tavolo, il seno premuto contro il ripiano, le braccia aperte, e mi ritrovai il grosso tegame col manico di ferro sotto la mano destra. Lo afferrai e colpii all’indietro, alla cieca. Sentii un rumore secco quando la padella raggiunse Cambio sulla fronte e la presa si allentò. Mi girai di scatto, sempre brandendo la mia arma improvvisata, pronta a colpire ancora. Lui stava scivolando per terra, stordito, un filo di sangue che gli colava fin sul naso, gli occhi stupiti.
Non pensai nemmeno per un istante di soccorrerlo. In due passi ero fuori e andai quasi a sbattere contro Pantaleo che proprio allora stava rientrando. Ci guardammo in faccia, tutti e due stravolti, lui per il vino e la rissa, io per il tentativo di stupro. Pantaleo vide Cambio sdraiato per terra, privo di sensi, la patta aperta, spalancò gli occhi e non accennò a fermarmi. Penso che anche nella confusione della sbronza avesse capito. Io corsi via, giù verso il ruscello, accecata dalle lacrime.
«Mi sciupi la gonna della mamma» ripetevo, inciampando sui ciottoli. Caddi, mi rialzai, arrivai all’acqua e quasi mi strappai i vestiti di dosso. Dovevo lavarmi, dovevo togliermi l’odore di mio fratello. Nuda, entrai nell’acqua nel punto più riparato del rivo, aggrappandomi ai rami flessibili del salice rosso, immergendomi fra le rocce scintillanti al sole.
L’acqua era fredda, correva veloce, una benedizione. Singhiozzavo forte, ma il rumore del torrente era più forte ancora e nessuno avrebbe potuto sentire la mia disperazione.
Tra i massi c’era un punto che conoscevo bene, dove una roccia liscia formava una specie di bacile concavo e rosato. Mi ci infilai, rabbrividendo di piacere, immergendo anche i capelli, giocando sott’acqua.
Poi alzai la testa e vidi l’uomo a cavallo che stava fermo sulla sponda opposta e guardava dalla mia parte, levando la mano destra a farsi schermo contro il sole, incredulo dello spettacolo insolito che gli stavo offrendo mio malgrado. Lo riconobbi subito e mi rannicchiai su me stessa come un porcellino di sant’Antonio, quel verme corazzato che se lo sfiori diventa una pallina e si confonde con la terra: il cavaliere era ser Piero da Vinci, il nostro padrone di casa che era venuto a riscuotere la pigione arretrata e che mi stava ammirando in controluce, nuda come mia madre mi aveva fatta, dentro le scintillanti acque del Bonchio.
3
Ser Piero di verde vestito
Ser Piero era sceso di sella e, conducendo il cavallo per le briglie, percorreva la ripida discesa, costeggiando il torrente.
Non appena i salici fecero cortina tra me e lui, balzai dall’acqua arrancando sui ciottoli e mi rimisi frenetica la gonna e la camicetta. Mi stavo strizzando i capelli fradici quando lo vidi spuntare dietro le rocce, vestito di verde e aureolato di sole.
Aveva legato il suo cavallo, un leardo grigio chiaro che mi parve bellissimo, a qualche distanza, per poter proseguire in mezzo alle rocce e arrivare fino all’acqua.
Restammo a guardarci per qualche interminabile secondo, incantati, poi lui batté le palpebre e parlò. «Non immaginavo che il rio Bonchio fosse abitato dalle ninfe» disse, sorridendo e facendo un passo avanti.
Io ne feci uno indietro. Non sapevo esattamente cosa fossero le ninfe, ma non suonava offensivo. Non mi sentivo minacciata, ma preferivo mantenere una distanza di sicurezza, senza contare che ero ancora fradicia, mi ero dovuta rivestire in fretta e furia.
Lui scosse la testa, tendendomi la mano. «Non fuggite, ve ne prego. Sono…»
MARINA MIGLIAVACCA MARAZZA ex manager editoriale, scrittrice, giornalista, è specializzata in tematiche di storia, di società e di costume. Collabora con diverse riviste tra cui «Io Donna». È autrice di romanzi, saggi e narrative non fiction, tra cui i recenti Il segreto della Monaca di Monza (Fabbri 2014) e Leonardo, il genio che inventò Milano (Garzanti 2015).