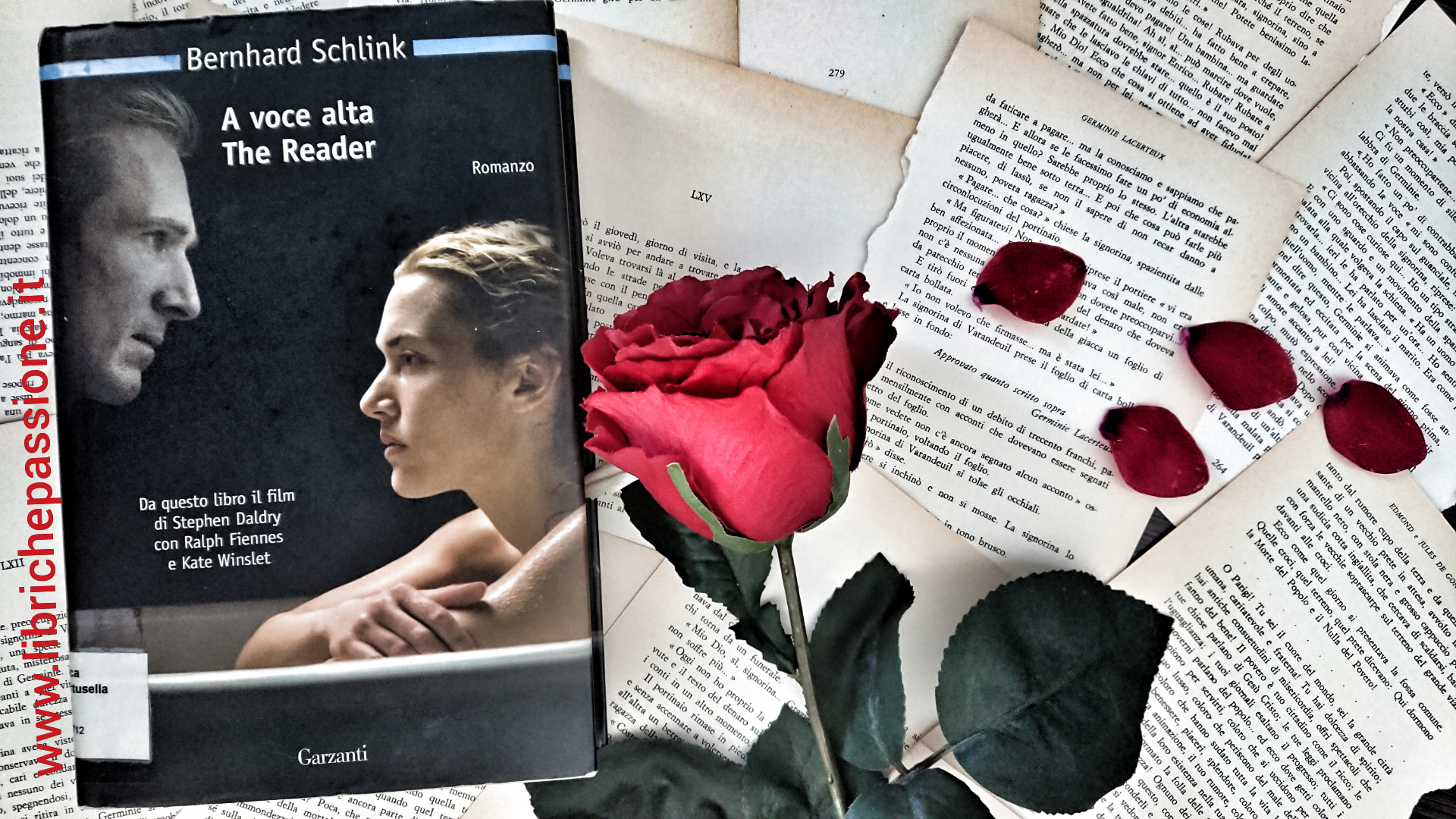Trama
“Tuvia era mio nonno. Vera è mia nonna. Rafael, Rafi, mio padre, e Nina… Nina non c’è. Nina non è qui. È sempre stato questo il suo contributo particolare alla famiglia”, annota Ghili nel suo quaderno.
Ma per la festa dei novant’anni di Vera, Nina è tornata; ha preso tre aerei che dall’Artico l’hanno portata al kibbutz, tra l’euforia di sua madre, la rabbia di sua figlia Ghili, e la venerazione immutata di Rafi, l’uomo che ancora, nonostante tutto, quando la vede perde ogni difesa. E questa volta sembra che Nina non abbia intenzione di fuggire via; ha una cosa urgente da comunicare. E una da sapere. Vuole che sua madre le racconti finalmente cosa è successo in Iugoslavia, nella “prima parte” della sua vita, quando, giovane ebrea croata, si è caparbiamente innamorata di MiloŠ, figlio di contadini serbi senza terra. E di quando MiloŠ è stato sbattuto in prigione con l’accusa di essere una spia stalinista. Vuole sapere perché Vera è stata deportata nel campo di rieducazione sull’isola di Goli Otok, abbandonandola all’età di sei anni e mezzo.
Di più, Nina suggerisce di partire alla volta del luogo dell’orrore che ha risucchiato Vera per tre anni e che ha segnato il suo destino e poi quello della giovane Ghili.
Il viaggio di Vera, Nina, Ghili e Rafi a Goli Otok finisce per trasformarsi in una drammatica resa dei conti e rompe il silenzio, risvegliando sentimenti ed emozioni con la violenza della tempesta che si abbatte sulle scogliere dell’isola. Un viaggio catartico affidato alle riprese di una videocamera, dove memoria e oblio si confondono in un’unica testimonianza imperfetta.
Con La vita gioca con me David Grossman ci ricorda che scegliere significa escludere e vivere è un continuo, maldestro tentativo di ricomporre.
Un romanzo di intensità straordinaria, dove ogni pagina è grande letteratura.
Estratto
Rafael aveva quindici anni quando sua madre morì e lo liberò dalle sue sofferenze. La pioggia cadeva sui membri del kibbutz accalcati sotto gli ombrelli nel piccolo camposanto. Tuvia, il padre di Rafael, singhiozzava. Per anni si era preso cura della moglie, e sembrava un orfanello sperduto. Rafael, in pantaloncini corti, se ne stava in disparte con un cappuccio calato sugli occhi perché nessuno vedesse che non piangeva. Rifletteva: “Adesso che la mamma è morta, scoprirà tutto quello che pensavo di lei”.
Era l’inverno del 1962. Un anno dopo suo padre incontrò Vera Novak, arrivata in Israele dalla Iugoslavia con l’unica figlia, Nina, una ragazza di diciassette anni, alta, con i capelli chiari e il viso oblungo, pallido e bellissimo, quasi completamente privo di espressione, e i due cominciarono a convivere.
I compagni di classe di Rafael chiamavano Nina “la Sfinge”, la seguivano di nascosto, ne imitavano l’andatura con le braccia strette intorno al corpo e lo sguardo perso nel vuoto. Una volta lei agguantò due di quei ragazzi e gli spaccò la faccia. Mai nel kibbutz si erano viste botte del genere. Era incredibile quanta forza e ferocia ci fossero in quelle braccia e in quelle gambe esili. Cominciarono a circolare voci su di lei. Dicevano che quando sua madre era stata prigioniera politica in un gulag, Nina – che allora era una bambina – fosse finita in mezzo a una strada. E accompagnavano le parole con sguardi carichi di significato. Dicevano che a Belgrado si fosse unita a una banda di teppisti che rapivano bambini per ottenere un riscatto. Dicevano. La gente parla.
La storia delle botte, altri episodi e le dicerie non squarciarono la nebbia nella quale Rafael viveva immerso dalla morte della madre. Per mesi rimase in uno stato di narcolessia auto-indotta. Due volte al giorno, mattina e sera, ingoiava un sonnifero che prendeva dall’armadietto dei medicinali della defunta. Di tanto in tanto si imbatteva in Nina, ma non la notava nemmeno.
Una sera, circa sei mesi dopo la morte della madre,mentre attraversava la piantagione di avocado diretto in palestra, vide Nina che veniva verso di lui. Camminava a testa bassa, con le braccia strette intorno al corpo, come se avesse freddo. Rafael si fermò, incomprensibilmente nervoso. Lei, chiusa in se stessa, non lo vide. Lui notò la sua andatura. Fu quella la prima cosa che lo colpì. Un incedere pacato, misurato. La fronte alta, bianca, un abito blu, semplice e leggero, che le sventolava intorno ai polpacci.
L’espressione del viso di Rafael mentre raccontava…
Quando Nina gli fu vicino, lui si rese conto che piangeva. Un pianto soffocato. E a quel punto anche lei notò Rafael. Si fermò, si ingobbì. I loro sguardi si aggrovigliarono per qualche istante e – lo dico con rammarico – in maniera indistricabile. «Il cielo, la terra, gli alberi» mi disse Rafael, «non so… Mi sentivo come se la natura fosse svenuta.»
Nina si riprese per prima. Sbuffò, irritata, e si allontanò in fretta. Lui ebbe ancora il tempo di lanciarle un’occhiata, vide che il suo viso era tornato inespressivo e sentì qualcosa gonfiarglisi dentro. Allungò la mano verso di lei. Riesco proprio a vederlo lì, in piedi, con la mano tesa.
E così è rimasto, con quella mano a mezz’aria, per quarantacinque anni.
Ma quel giorno, nella piantagione, senza riflettere e prima di avere ripensamenti, Rafael rincorse Nina con uno scatto per dirle ciò che aveva capito nel momento in cui l’aveva vista. Tutto in lui si era risvegliato alla vita, mi raccontò. Gli chiesi di spiegarsi. Lui si confuse. Mormorò qualcosa a proposito di quello che si era assopito in lui negli anni della malattia della madre, e ancor più dopo la sua morte. E improvvisamente tutto si era fatto impellente, fatidico, e lui non aveva alcun dubbio che Nina si sarebbe mostrata disponibile nei suoi confronti.
Lei sentì i passi di Rafael che la seguivano, si fermò, si voltò e lo squadrò lentamente. «Che c’è?» gli ringhiò in faccia. Lui arretrò, rabbrividì per quanto era bella, e forse anche per quanto era aggressiva. Ma soprattutto, temo, per quella combinazione di bellezza e di aggressività. Ancora oggi Rafael ha un debole per le donne che mostrano un po’ – anche solo un pizzico – di prepotenza maschile, e persino di maleducazione. Una spezia di questo tipo. Rafael, Rafi…
Nina si mise le mani sui fianchi e in lei si affacciò la ragazza tosta di strada, un animale selvatico. Allargò le narici, annusò Rafael. Lui notò una delicata vena bluastra che le pulsava sul collo e d’un tratto le labbra gli fecero male. Mi disse proprio così, le labbra gli bruciavano per la sete.
“Va bene, abbiamo capito” pensai. “Non devi addentrarti in dettagli.”
Sulle guance di Nina ancora brillavano le lacrime ma i suoi occhi erano freddi, quasi da rettile.
«Tornatene a casa, ragazzino» disse. Lui scosse la testa. No, no. Lei gli si avvicinò lentamente con la fronte, poi l’allontanò, come se cercasse il punto esatto. Rafael chiuse gli occhi e Nina gli sferrò una testata che lo mandò a gambe all’aria ai piedi di un albero di avocado.
«Varietà Ettinger» è solito puntualizzare Rafael quando racconta quell’episodio, perché io non mi scordi che ogni dettaglio è importante. È così che si costruisce un mito.
Rimase disteso, stordito. Si tastò il bernoccolo che aveva cominciato a spuntargli in fronte e si rialzò frastornato. Da quando sua madre era morta non aveva più toccato nessuno, e nessuno aveva toccato lui, a eccezione di alcuni ragazzi con cui aveva fatto a botte. Ma in quel caso era diverso, così gli sembrava. Nina era finalmente arrivata ad aprirgli la testa, a salvarlo dai suoi tormenti. In preda a un dolore cieco le gridò ciò che aveva scoperto nel momento in cui l’aveva vista. Mi confidò che si stupì delle parole che gli uscirono di bocca: banali, volgari. «Da ragazzaccio» disse, «tipo “voglio scoparti” o roba del genere.» Così diverse dai pensieri puri e precisi che aveva su di lei. «Ma per un secondo e mezzo le ho letto in faccia che, nonostante quelle oscenità, lei mi capiva.»
E forse era davvero così. Che ne so io. Perché non dare fiducia a Nina? Perché non credere che una ragazza nata in Iugoslavia, che per alcuni anni era stata davvero abbandonata ed era rimasta senza padre né madre (come in seguito si scoprì), a dispetto di quei presupposti – o magari proprio in virtù di essi – in un istante di grazia avesse sbirciato dentro un ragazzino di un kibbutz israeliano? Un ragazzino introverso (così mi immagino Rafael all’età di sedici anni), solitario, pieno di calcoli segreti e complicati e capace di grandi gesti dei quali nessuno al mondo sapeva niente. Un ragazzo triste, ombroso, ma talmente bello da farti venire le lacrime agli occhi.
Rafael, mio padre. C’è un film famoso di cui ora non ricordo il titolo (e non sprecherò nemmeno un istante a cercarlo su Google), nel quale il protagonista ritorna al passato per rimediare a qualcosa, o per evitare una qualche guerra
mondiale, o roba del genere. Cosa non darei per poter tornare al passato e fare in modo che quei due non si incontrassero.
Nei giorni seguenti, ma soprattutto nelle notti, Rafael si tormentò per aver buttato al vento quel momento meraviglioso. E per vivere l’amore a mente lucida smise di prendere i sonniferi di sua madre. Cercò Nina in tutto il kibbutz, ma non la trovò. Poiché a quel tempo non parlava quasi con nessuno, non sapeva che lei aveva lasciato gli alloggi degli scapoli e delle nubili – dove viveva con la madre – e aveva preso possesso di una stanzetta in una vecchia e cadente baracca dei tempi dei padri fondatori del kibbutz. Un alloggio minuscolo, di fianco ad altri simili, dietro le piantagioni, in una zona denominata, con il caratteristico tatto del kibbutz, “il lebbrosario”. Una piccola comunità di uomini e donne volontari, provenienti dall’estero, rimasti bloccati nel kibbutz, e che, avendo problemi di inserimento, non erano utili in alcun modo. E il kibbutz non sapeva che farsene di loro.
Il sentimento nato in Rafael quando aveva visto Nina nella piantagione non aveva però perso slancio e, giorno dopo giorno, non gli dava pace: “Se Nina
accettasse di venire a letto con me almeno una volta” pensava Rafael, serissimo, “il suo viso riacquisterebbe espressività”.Mi raccontò di questa sua convinzione durante una conversazione che io filmai con la cinepresa un’eternità fa, quando lui aveva trentasette anni. Era il mio primo documentario e questa mattina, ventiquattro anni dopo, Rafael e io, colti da un repentino attacco di nostalgia, abbiamo deciso di riguardarlo. Lo si vede tossire, soffocare quasi, stropicciarsi la barba incolta, sganciare e riagganciare il cinturino di pelle dell’orologio, ma soprattutto non alzare lo sguardo sulla giovane intervistatrice, ovvero su di me.
«Eri molto sicuro di te a sedici anni» mi sento dire nel film con un cinguettio adulatore. «Io?» esclama Rafael stupito. «Sicuro di me? Ero una foglia in balia del vento.» «A me invece sembra che la tua idea di come fare perché il viso di Nina riacquistasse espressività sia la formula di corteggiamento più originale che abbia mai sentito» dice l’intervistatrice in tono terribilmente falso.
Avevo quindici anni e, francamente, fino a quel momento non mi ero mai imbattuta in formule di corteggiamento, né originali né scontate, da nessun altro chenon fosse me stessa davanti a uno specchio, con in testa un berretto nero e una sciarpa a coprirmi metà del viso, per darmi un’aria misteriosa.
Una videocassetta, un piccolo treppiede, un microfono rivestito di spugna grigia spelacchiata. Li ha ritrovati questa mattina d’ottobre del 2008 mia nonna Vera in una scatola di cartone in soffitta, insieme alla vecchia Sony, dietro il cui obiettivo osservavo il mondo in quegli anni.
Be’, la definizione “documentario” è un po’ esagerata per questa roba. Si tratta di spezzoni di pellicola, ricordi di gioventù di mio padre, sconnessi e privi di montaggio. Il sonoro è terribile, le immagini sbiadite e sgranate, però si riesce a capire che cosa succede. Sullo scatolone Vera aveva scritto con un pennarello nero: “Ghili. Varie”. Non ho parole per descrivere ciò che suscita in me questo filmato, la compassione che provo per la ragazza che ero e che, non esagero, sembrava la versione umana di un Dodo, una creatura che, com’è noto, si è salvata da una morte per vergogna solo perché si è estinta prima. In altre parole, un essere che, fondamentalmente, non sapeva che cosa fosse né dove stesse andando. Tutte le strade gli erano aperte…
David Grossman (Gerusalemme, 1954), noto per il suo impegno in favore di una soluzione pacifica della questione palestinese, è uno dei più grandi narratori contemporanei. È diventato un caso letterario nel 1988 con Vedi alla voce: amore, seguito da Il libro della grammatica interiore, Ci sono bambini a zigzag, Che tu sia per me il coltello, Qualcuno con cui correre, Col corpo capisco, A un cerbiatto somiglia il mio amore, Caduto fuori dal tempo e Applausi a scena vuota, vincitore del prestigioso Man Booker International Prize nel 2017. Suoi sono anche alcuni celebri libri inchiesta dedicati alla questione palestinese: Il vento giallo, Un popolo invisibile, Con gli occhi del nemico, La guerra che non si può vincere.