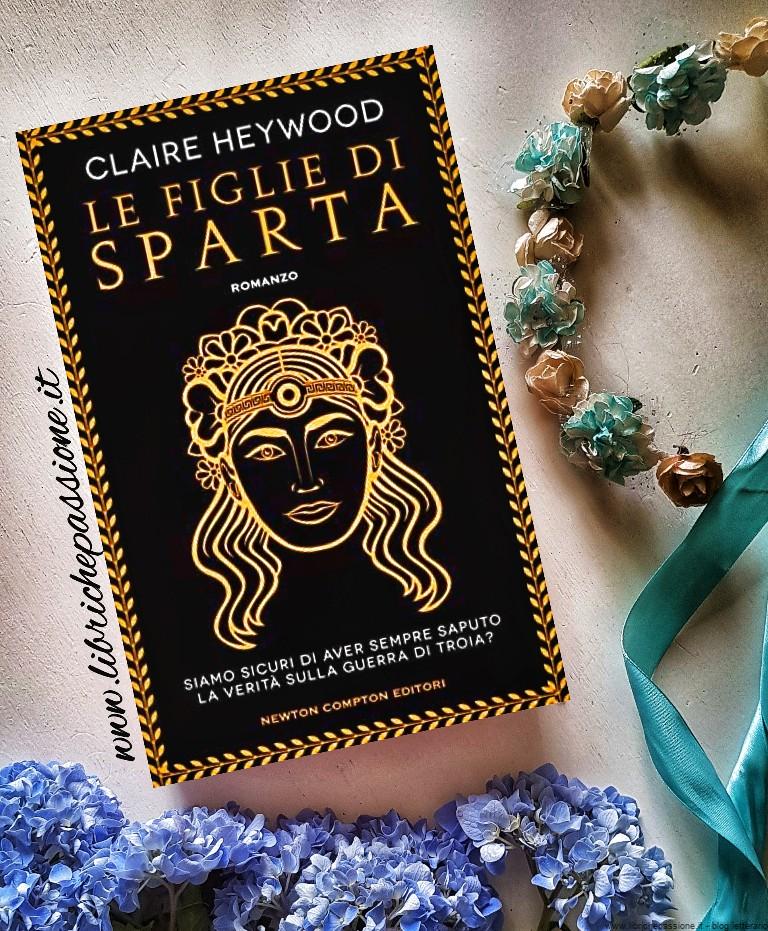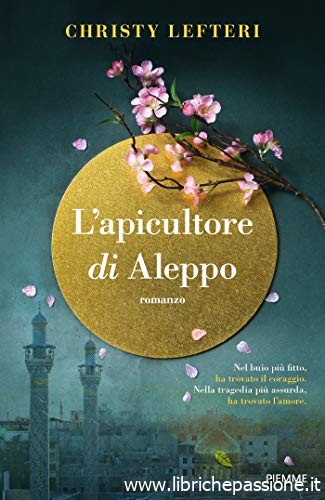Sinossi
Cosa ricordano le dita? Se la memoria scompare, possono gli oggetti aiutare a ritrovare i ricordi?
Sin da ragazza, Dalia ha lavorato come dattilografa, attraversando il ventesimo secolo sempre accompagnata dalla sua macchina da scrivere portatile, una Olivetti MP1 rossa.
Negli anni Novanta, ormai anziana, la donna viene colpita da un ictus che, pur non rivelandosi letale, offusca parte della sua memoria. I ricordi di Dalia tuttavia non si sono dissolti, essi sopravvivono nella memoria tattile dei suoi polpastrelli, dai quali possono essere liberati solamente nel contatto con i tasti della Olivetti rossa. Attraverso la macchina da scrivere, Dalia ripercorre così la propria esistenza: gli amori, i dispiaceri e i mille espedienti attuati per sopravvivere, soprattutto durante gli anni della guerra, riemergono dal passato restituendole un’immagine di sé viva e sorprendente, la storia di una donna capace di superare decenni difficili procedendo sempre a testa alta con dignità e buonumore. Un unico, importante ricordo, però, le sfugge, ma Dalia è decisa a ritrovarlo seguendo gli indizi che il caso, o forse il destino, ha disseminato lungo il suo percorso.
La narrazione alla ricerca del ricordo perduto si arricchisce pagina dopo pagina di sensazioni e immagini legate a curiosi oggetti vintage: la protagonista del libro ritroverà la memoria anche grazie a questo tipo di indizi, che appaiono ogni volta in luoghi inaspettati, in una specie di caccia al tesoro immaginaria, tra realtà e fantasia.
Dopo L’annusatrice di libri, sul senso dell’olfatto e la lettura, un romanzo appassionante sul tatto e la scrittura, un viaggio a ritroso nella vita di una donna sulle tracce dell’unico ricordo che valeva la pena di essere conservato.
Estratto
Capitolo 1
È una verità universalmente riconosciuta che una donna in possesso di una lunga storia abbia bisogno di una memoria adeguata.
Senza memoria, ogni cosa perde di valore e di utilità, come ad esempio l’oggettino insignificante che stringi tra le dita: freddo al tatto, liscio, di forma circolare e senza alcun valore.
L’hai ritrovato nella tasca del soprabito, avvolto in un fazzoletto che riporta le tue iniziali da signorina coronate da una ghirlanda di fiorellini a punto croce: D.B., Dalia Buonaventura.
Ti domandi perplessa perché hai conservato con tanta attenzione quello che ha tutta l’aria di essere un vecchio anello per le tende; ci ragioni su per qualche istante, poi decidi di mettere l’anellino nella tasca della vestaglia e di riporre il fazzoletto diligentemente ripiegato nel cassetto che la tua donna di servizio ha adibito a tale scopo. Germana è una santa donna, ma ha il brutto vizio di mettersi a borbottare ogniqualvolta ti dimentichi di chiudere l’anta di un armadio, o lo stipetto dei medicinali. Negli ultimi trent’anni hai compiuto indicibili sforzi per contrastare la tua indole caotica e rispettare l’ossessione per l’ordine della tua donna di servizio, ma ora, dopo il tuo piccolo incidente, sono troppe le cose che dimentichi, e lo scordare un cassetto aperto non sarebbe certo la più grave.
Due mesi: questo è il tempo che il tuo piccolo incidente ha spazzato via dalla tua memoria, due mesi dei quali non hai alcun ricordo.
Decidi di smetterla di tormentarti con i cattivi pensieri, in fondo sei stata dimessa dall’ospedale poco più di una settimana fa, e sì, hai qualche vuoto di memoria, lo ammetti, ma sei convinta che ti basterà tornare alla vita di tutti i giorni per colmare ogni lacuna. Ti risolvi a recarti nel tuo studio, e nel lasciare la camera da letto intravedi la tua immagine riflessa sulla superficie risplendente di Vetril dello specchio sul comò: hai settant’anni, quasi settantuno, e non hai ancora l’aspetto di una vecchina che perde i colpi. Nonostante il parere dei medici, sai di avere ancora una gran bella testa, a cominciare dall’acconciatura, la stessa che porti da più di cinquant’anni, per la precisione dal 1936, quando ti sei tagliata le trecce e hai incominciato a lavorare. All’epoca avevi tredici anni e un attestato di dattilografia; non potevi certo presentarti ai tuoi futuri datori di lavoro con l’aspetto di una scolaretta che ha marinato le lezioni, così la tua amica Ester ti aveva tagliato i lunghi capelli castano chiaro all’altezza delle spalle e te li aveva ondulati con i becchi d’oca.
Ora sorridi, il termine “becco d’oca” ti ha sempre divertito e lo specchio ti restituisce l’immagine di una fila di denti perfetti – ancora tutti tuoi, e chi afferma il contrario mente! –, incorniciati da uno sfolgorante rossetto magenta. Anche il tuo maquillage è lo stesso di tanti anni fa: matita nera attorno agli occhi, cipria bianco perla e labbra rosse come ciliegie, talvolta come amarene poiché sul rossetto ti concedi qualche variazione sul tema, ma senza esagerare perché quando una cosa è perfetta – e il tuo trucco lo è, indubbiamente – tentare di migliorarlo è una perdita di tempo.
Non sei mai stata una donna di grande bellezza, cosa della quale ti sei spesso rammaricata, ma hai saputo trarre il meglio dai tuoi lineamenti ordinari e dal corpicino di scricciolo: i capelli, che ricadono con una morbida onda quasi a coprire l’occhio destro, conferiscono al tuo viso un che di lievemente malizioso, sei intrigante ancora adesso che le tue onde perfette si sono fatte bianche come nuvole e gli occhi sono segnati, oltre che dalla matita nera, da profonde rughe. E piaci ancora agli uomini, persino a quelli più giovani di te! Circa sei mesi prima del tuo piccoloincidente, il proprietario della profumeria che frequentavi da tempo ti aveva invitato a cena e tu, colta da un raro lampo di follia, avevi accettato nonostante si trattasse di un bamboccio di neppure sessant’anni. Era stata una serata orribile! I gamberetti erano stati serviti ricoperti da una melmosa salsa color rosa spento e contornati da un’aiuola di rucola amarognola. Una volta ti piaceva molto la rucola, per te aveva il sapore della primavera che si trasforma in estate, poi però una decina di anni fa, sarà stata più o meno la metà degli anni Ottanta, tutti i cuochi italiani sembravano aver unanimemente deciso di inserirla in qualunque ricetta: rucola negli antipasti, nei primi piatti, per contorno ai secondi.
Come se la rucola non fosse bastata a rendere amaro ogni boccone di quel ridicolo appuntamento galante, il tuo cavaliere non aveva fatto altro che parlare della moglie buonanima; un de profundis al gusto di rucola. La conseguenza più seccante di quella cena era stata tuttavia il doverti trovare un altro profumiere presso il quale fare acquisti: non avresti più potuto guardare quell’uomo in faccia senza scoppiare a ridere e la cosmesi, per te, è sempre stata una faccenda della massima serietà.
Lasci la camera da letto, lo specchio fa ancora in tempo a registrare un sorrisetto di disappunto: ricordi la tua iniziazione ai becchi d’oca, e persino l’esecrabile monomania per la rucola che dagli anni Ottanta imperversa nella cucina italiana, eppure non hai idea di dove stessi andando il giorno del tuo piccolo incidente.
Dovevi avere un impegno importante, di questo sei certa, altrimenti non avresti indossato il tuo abito di satin blu, né tantomeno il collier col pendente di zaffiri. Chissà se avevi applicato il rossetto borgogna o il magenta. Quello sarebbe stato un dettaglio interessante per venire a capo del mistero, ma in ospedale, quando ti sei risvegliata, nessuno aveva saputo dirtelo, quasi ti trovassi ricoverata in un reparto di daltonici.
Ora infili la mano nella tasca della vestaglia e i tuoi polpastrelli incontrano il metallo freddo dell’anellino per le tende. Quello è un altro bel mistero: perché hai conservato quel cerchietto di ferro annerito dentro a un fazzoletto ricamato? E soprattutto: perché lo portavi con te, nella tasca? Forse il giorno del tuo piccolo incidente stavi andando in merceria a far rifornimento di anelli per le tende? Scuoti il capo perplessa, non sei mai stata portata per le faccende domestiche; in realtà quand’eri giovane non ti sarebbe dispiaciuto impratichirti in quel campo ma ti è sempre mancato il tempo, ecco perché, appena hai avuto i mezzi necessari, hai assunto una donna di servizio che si occupasse delle pulizie, del cibo e, all’occorrenza, degli anelli per le tende.
Percorri il corridoio a passo ancora un po’ incerto, imbocchi la porta del tuo studiolo e ti siedi allo scrittoio sul quale è poggiata la tua vecchia Olivetti MP1: quella signorina è poco più giovane di te, eppure la sua laccatura rossa è splendente come il primo giorno in cui hai messo le mani sulla sua tastiera. Nel carrello c’è un foglio bianco, lo estrai con delicatezza chiedendoti il perché si trovi lì. Non rammenti di aver dattilografato di recente, ma ricordi di aver sempre avuto la sana abitudine di non lasciare i fogli inseriti. Magari il giorno del tuo piccolo incidenteeri in procinto di scrivere qualcosa, ma poi sei dovuta uscire all’improvviso e…
Che stupidaggine! L’abito che indossavi non era di quelli che si infilano al volo per un’uscita improvvisata, semmai per un evento pianificato da tempo. Col palmo della mano cerchi di distendere il foglio, che per la lunga permanenza nel carrello è orribilmente incurvato: ecco perché, sin dall’inizio della tua carriera di dattilografa, hai imparato a non scordare i fogli nel carrello della macchina da scrivere!
«Fine», mormori.
Al centro della pagina che credevi bianca, è impressa la scritta «FINE» a lettere maiuscole.
Chiudi gli occhi e tenti di far riaffiorare i ricordi dalla tua memoria appannata: la parola “fine” non si appone al fondo di una lettera o di un documento di qualsivoglia genere. La parola “fine”, scritta a lettere maiuscole, indica un testo di narrativa e sono decenni che non ti capita di dattilografarne uno.
Incominci ad aprire a uno a uno tutti i cassetti dello scrittoio, alla ricerca del dattiloscritto del quale il foglio con la parola “fine” possa essere la conclusione.
Hai abbandonato il mestiere di dattilografa ormai da tempo, qualche volta ti è capitato di battere a macchina delle missive, ma giusto per non perdere la mano o per fare un favore a qualche conoscente.
«La macchina da scrivere è come un pianoforte», ti ripeteva la signorina Pellissero, l’insegnante di dattilografia con la quale hai studiato. «Se smetti di usarla le dita perderanno la loro agilità».
La signorina Pellissero al tempo delle tue lezioni avrà avuto una sessantina d’anni, forse qualcuno di più o magari molti di meno, ma a te, che di anni ne avevi solo tredici, sembrava una sorta di antica sfinge. Portava un cappello a scodella sulla sommità dei capelli grigi, aveva dita lunghe e scheletriche che piroettavano sui tasti a una velocità inarrivabile, e ostentava una devozione al suo mestiere che è difficile riscontrare persino nei medici o nei sacerdoti.
Ti ha addestrato alla macchina da scrivere con la stessa inflessibile disciplina che un caporale avrebbe riservato a una recluta: «Non guardare la tastiera, Dalia!», ti ordinava. «Le vere dattilografe non hanno bisogno di cercare i tasti con gli occhi, le dita hanno una memoria portentosa, l’importante è consentirgli di svilupparla».
Tu cercavi di obbedire, ma i tasti lucidi e rotondi dell’Olivetti MP1 erano una tentazione troppo forte per il tuo sguardo curioso di ragazzina.
La signorina Pellissero si era così risolta a bendarti, costringendoti per settimane a picchiettare sui tasti in completa cecità. I metodi della severissima insegnante, tuttavia, avevano dato i loro frutti: nel corso della tua carriera hai battuto a macchina nelle condizioni più disparate, persino in piena guerra durante le notti di oscuramento, quando occorreva rimanere tappati in casa a luci spente, affinché i bombardieri inglesi non venissero attirati dalle finestre illuminate, come le falene verso la fiamma di una candela. Dopo il matrimonio, quando ti sei trasferita a Torino, delle volte hai battuto a macchina persino sotto ai bombardamenti. Quando nottetempo suonava la sirena antiaerea, tu non te la sentivi di scapicollarti giù per le scale con lo scialle sopra la camicia da notte, per poi pigiarti in una cantina insieme a decine di altre persone terrorizzate, che avevano tante probabilità di salvarsi quante di fare la fine dei topi, imprigionati dalle macerie o asfissiati dal fumo degli incendi che si scatenavano a ogni crollo. Quando la sirena antiaerea ti destava dal tuo sonno sempre leggero e agitato, preferivi sederti davanti alla macchina da scrivere e, avvolta nel buio, far volare le dita sulla tastiera. Trovandoti nell’oscurità, non potevi trascrivere testi e completare i lavori di battitura che avevi in corso, ti limitavi a eseguire gli esercizi di dattilografia che ti aveva insegnato la signorina Pellissero, o a battere parole e frasi a caso, lasciando le dita libere di correre dietro alla tua immaginazione. Non era ciò che scrivevi, quanto piuttosto il contatto dei polpastrelli sui tasti freddi dell’Olivetti MP1 a rilassarti e a farti attraversare, con relativa calma, quei momenti oscuri non soltanto per l’assenza di lume.
Mentre i tuoi ricordi esplorano quegli anni lontani e terribili, le tue mani scandagliano il contenuto di ogni cassetto dello scrittoio, ancora alla ricerca del misterioso lavoro di battitura.
Riponi il foglio con la scritta «FINE» nell’ultimo cassetto in basso, dedicato alle bozze e alle brutte copie, e abbandoni la tua ricerca.
Ora accarezzi la tua vecchia macchina da scrivere; un lieve formicolio ti scorre lungo le dita facendoti fremere i polpastrelli. Colta da un improvviso ghiribizzo, accosti gli scuri della finestra, infili un foglio nel carrello dell’Olivetti rossa e, immersa nel buio, lasci che il formicolio ai polpastrelli svanisca al fresco contatto con i tasti. Le tue dita danzano sulla tastiera seguendo una coreografia che sfugge alla tua comprensione ma che decidi di assecondare e, senza opporre resistenza, inizi a scrivere una nuova storia.
Capitolo 2
Con due stretti giri di cinghia, Dalia fissò la valigetta della sua macchina da scrivere sul portapacchi della bici, poi la scosse leggermente per verificare che fosse ben ancorata. Era una Olivetti MP1, un gioiellino della meccanica del peso di appena cinque chili e due etti; molto più pratica e maneggevole della recente e tanto decantata Olivetti Studio 42, che pesava di più. E poi era rossa! Quando aveva consultato il catalogo di vendite per corrispondenza, aveva visto che erano disponibili diversi colori: il classico nero, il verde, il rosso, il celeste e l’avorio. Le sue dita avevano tanto indugiato sul modello di colore rosso ma poi, su consiglio del padre, aveva optato per un più rispettabile avorio, meno vivace ma molto elegante. Qualche settimana più tardi, quando aveva aperto la grande scatola, la MP1 si era però rivelata dello stesso colore che era solita
applicarsi sulle labbra di nascosto dal padre. Segnalando l’errore allo spedizioniere avrebbe potuto ottenere il cambio dell’articolo, ma ciò avrebbe comportato rispedire la Olivetti rossa indietro e attendere la consegna di quella color avorio, e lei doveva incominciare a lavorare subito.
Ormai erano trascorsi circa quattro anni da quando Dalia e la macchina da scrivere rossa erano diventate inseparabili. Dalia inforcò la Bianchi Suprema, modello per signora con canna arcuata che, nonostante il costo proibitivo, suo padre le aveva regalato pochi mesi prima per il suo diciassettesimo compleanno, onde evitare che la sottana le si alzasse nel montare e smontare dal sellino, come le accadeva con la bici da uomo che aveva usato fino a quel momento.
«Non correre, sta’ composta e non fermarti a chiacchierare con i garzoni delle botteghe», bofonchiò suo padre, in piedi davanti all’uscio. «Ricorda sempre chi sei!».
Quello era il saluto che l’uomo riservava alla figlia ogni mattina, al quale lei rispondeva soffiandogli un bacio.
«Smorfiosa», borbottava lui.
«Brontolone», sussurrava lei affondando la prima pedalata.
Dalia percorse il viottolo che fronteggiava la casa e, svoltando a sinistra, imboccò la strada provinciale che in una decina di minuti l’avrebbe condotta nel centro storico di Avigliana dove, a due passi da piazza Conte Rosso, sotto ai portici medievali, bassi e dalle volte tondeggianti, si trovava lo studio del ragionier Borio. Per molti anni il ragioniere aveva lavorato alla Premiata fabbrica di cerini Buonaventura, fondata dal compianto bisnonno di Dalia, ma quando l’azienda era andata in fallimento, messosi in proprio, aveva affittato una stanza al pianoterra nella quale offriva vari servizi: contabilità, stesura di contratti e, da quando su preghiera del suo ex datore di lavoro ne aveva assunto la figlia, battitura di testi e lettere. L’unica condizione che il ragioniere aveva posto all’assunzione della ragazzina era stata che fosse munita di una propria macchina da scrivere. La famiglia Buonaventura gli aveva pagato un signor stipendio per più di vent’anni, e quella non era cosa da scordare, ma il padre di Dalia, l’ingegnere, era colui che aveva mandato la fabbrica a gambe all’aria, e neanche quella circostanza poteva essere dimenticata.
Dasy Icardi, nata a Torino, città in cui vive e lavora, è formatrice aziendale, attrice e copywriter. Nel 2004 si è laureata al DAMS e dal 2006 lavora in teatro anche in qualità di autrice e regista. Con Fazi Editore, nel 2019, ha pubblicato L’annusatrice di libri, un romanzo che ha avuto un grande successo di critica e di pubblico e i cui diritti sono stati venduti anche all’estero.