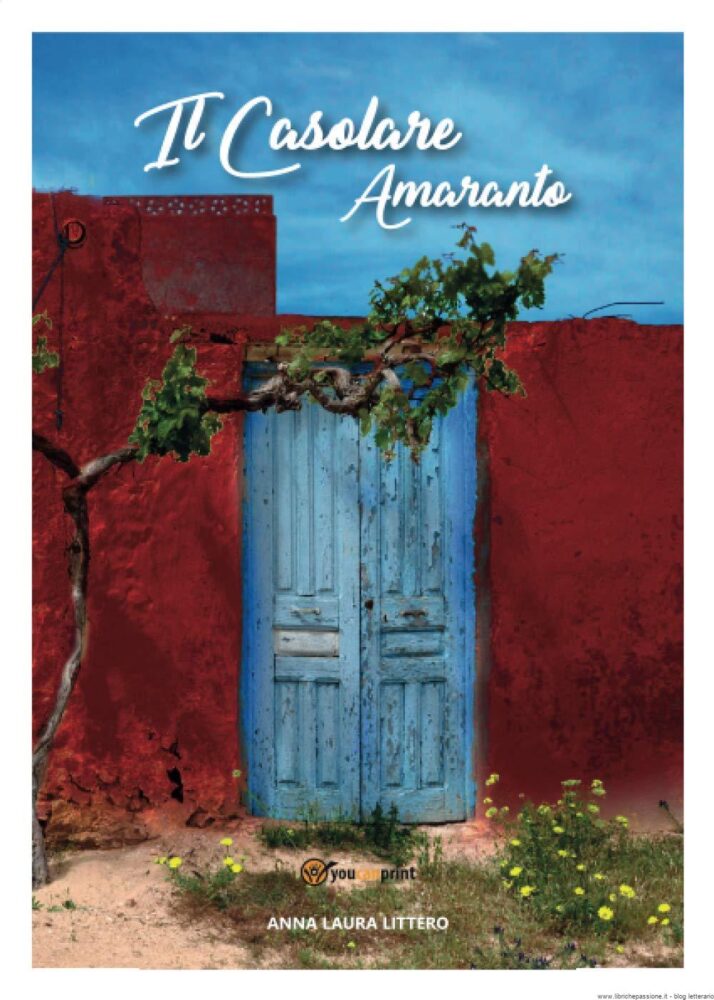La luce del domani
Autrice: Roxanne Veletzos
Traduttore: P. Spinato
Casa editrice: Nord
data di pubblicazione: 6 Giugno 2019
Genere: romanzo
Una bambina salvata per miracolo. Un Paese schiacciato tra Hitler e Stalin. Una scoperta che potrebbe cambiare tutto…
«Un romanzo che getta una nuova luce sulle pagine più buie della storia romena. »
Woman’s World Magazine
«Un esordio potente, uno stile elegante e mai banale. Roxanne Veletzos incanterà i lettori. »
Library Journal
«Ci sono storie che devono essere raccontate, perché sono una testimonianza di ciò che ci rende uomini. Questa è una di quelle storie. »
Armando Lucas Correa
«Storicamente ineccepibile, questo romanzo è un inno alla capacità dell’animo umano di resistere alle avversità. »
Publishers Weekly
«Un concentrato di speranza.»
Kirkus Reviews
«Sapere che la trama di questo romanzo si ispira a fatti realmente accaduti aggiunge un ulteriore elemento di suspense che rende La luce del domani ancora più avvincente. »
Booklist
Bucarest, gennaio 1941. Un uomo e una donna corrono tra i vicoli insieme con la figlia. Sono ebrei, sanno che presto verranno catturati e per loro sarà la fine. Tuttavia c’è un modo per dare almeno una speranza alla bambina. Un modo terribile, che lacera il cuore. Ma non hanno scelta. L’uomo e la donna abbandonano la piccola dietro un portone e scompaiono nella notte.
Natalia è stata fortunata. Condotta in orfanotrofio, è stata poi adottata da una coppia di commercianti, Despina e Anton, che l’hanno fatta subito sentire amata e l’hanno protetta durante i terribili anni del regime nazista. Tuttavia la fine della guerra ha portato l’avvento dei comunisti e, da quando la cartoleria di Anton è stata confiscata dal governo, la famiglia è in gravi difficoltà economiche. Natalia ha lasciato gli studi e si è rassegnata a una vita stretta nella morsa di un Paese oppressivo e violento. Ma tutto cambia nel momento in cui riceve una lettera dai suoi genitori naturali, miracolosamente sfuggiti al pogrom e giunti in America. Quella lettera potrebbe essere la chiave per oltrepassare la Cortina di Ferro ed essere finalmente libera. Eppure la decisione sembra impossibile: se partisse, Natalia volterebbe le spalle alle persone che l’hanno amata e cresciuta; se restasse, rinuncerebbe a un futuro pieno di opportunità…
Sullo sfondo di un Paese schiacciato tra Hitler e Stalin, questo romanzo racconta la storia di due famiglie divise eppure unite dall’amore per una bambina, entrambe pronte a lottare con coraggio e a sacrificare ogni cosa, persino la loro vita, pur di far vedere a quella bambina la luce del domani.
Estratto
Per i miei nonni
Basato su una storia vera
Secondo la commissione Wiesel, tra l’ottobre 1940 e la fine della seconda guerra mondiale, in terra rumena vennero massacrati 380.000 ebrei. Nel gennaio 1941, durante il tristemente noto pogrom di Bucarest, migliaia di ebrei vennero trascinate in strada per essere torturate o uccise.
PARTE PRIMA
ANTON E DESPINA
Capitolo 1
Bucarest, gennaio 1941
La bambina è seduta da sola, immersa nel buio. Scossa dai brividi, si stringe le braccia al petto minuscolo e affonda il viso nel collo del maglione di lana. Cerca di ricordare le parole esatte che sua madre ha pronunciato proprio lì, sui gradini del palazzo. Le ha detto quanto sarebbe stata via? C’era ancora luce, quando i suoi genitori sono spariti dietro l’angolo, la madre che tremava, china in avanti, con indosso il vestito leggero, il padre che trascinava i piedi sul marciapiedi ghiacciato, pochi passi più indietro. Un brivido la scuote quando appoggia le mani sul cemento gelido. Il vento le sferza le gambe nude, mordendo la carne; vorrebbe avere una coperta, un paio di muffole o almeno il berretto, ma lo ha perso chissà dove. Ciononostante preferisce stare lì, in quel freddo glaciale, piuttosto che nell’androne buio che puzza di muffa. L’odore di cavolo cotto che arriva da uno degli appartamenti le fa brontolare lo stomaco. E dire che a casa si rifiutava sempre di mangiarlo, per quanto sua madre la pregasse.
Avvicina le ginocchia al petto, alza lo sguardo sul palazzo a tre piani e sugli ampi balconi tondi che incombono su di lei. No, non ha mai visto prima questo edificio. Non ha mai visto questa strada, deserta e poco illuminata, dove un unico lampione getta un alone di luce sulla neve sporca. Non si vede anima viva. È come se qualcuno avesse spento le luci di questa città un tempo così vivace, vietando qualunque movimento, saluto o risata.
I suoi genitori torneranno da un momento all’altro, si dice, lanciando un’altra occhiata alla strada. Cerca di ricordare le parole di sua madre, la voce dolce che la esortava a non avere paura, promettendole che, se fosse stata coraggiosa, sarebbe andato tutto bene. Eppure non dovrebbero andare in giro a quest’ora, lo sa bene. Solo pochi giorni fa ha sentito i suoi che parlavano del coprifuoco, della Guardia di Ferro che pattugliava la città e arrestava chiunque fosse ancora per strada dopo il tramonto. E ti sparava sotto casa, in modo che i vicini vedessero. Li ha sentiti parlare di altre cose ancora che non volevano sentisse, sussurrando nella stanza accanto alla sua dopo che lei era andata a letto. Le parole le arrivavano ovattate, incomprensibili, ma i picchi di disperazione nella voce la facevano rabbrividire nel letto caldo.
Ci sono rumori in lontananza, adesso: grida, strilli acuti inframmezzati al tonfo ritmico di stivali, finestre che si chiudono sbattendo nella sera. Succede da diverse notti, ma questa volta i suoni sono accompagnati da uno strano odore, simile a quello del carbone bruciato, con una nota dolciastra che le fa venire i conati. La nausea le risale in gola, e lei si tira il bordo del maglione sulla faccia per mitigare il tanfo, obbligandosi a pensare a casa sua e al letto con la trapunta di raso rosa, con la luce che filtra dalla porta socchiusa.
Gli occhi le si colmano di lacrime che non riesce più a respingere. Si vergogna: alla fine non è stata coraggiosa, anche se ha promesso a sua madre che ci avrebbe provato, con tutta se stessa. Farò la brava, mamma. Aspetterò, le ha detto, ma le sembra passata una vita intera da quando ha pronunciato quelle parole.
Appoggia la fronte all’incavo del gomito e i singhiozzi erompono senza freni, tagliando il silenzio e riecheggiando nei cortili e nei vicoli. Sa che non dovrebbe fare rumore, ma non riesce ad arginare quello che le è esploso dentro, qualunque cosa sia. Piange fino a che non ha più lacrime, fino a che i sospiri spezzati non si sono sciolti, diventando una sola cosa col vento. Si raggomitola sul cemento, abbandonandosi infine all’abisso del sonno.
All’improvviso, due braccia robuste la stringono, sollevandola da terra. Spaventata, si sveglia e, sopra di sé, vede il volto di una donna che non conosce. Ha i capelli raccolti in una crocchia grigio argento, qualche ciocca che le ricade sulle guance tonde e rugose. Un lieve odore di sudore e amido l’avvolge mentre la donna se la stringe al petto, così forte che lei non riesce a liberarsi, sebbene ci provi dimenandosi con tutte le sue forze. Ma in quella stretta c’è qualcosa di tenero che le dà calore, e lei ha troppo freddo, è troppo stanca e debole, così le affonda il viso contro il petto e piange. La donna spinge la porta col gomito e porta la piccola nell’ingresso. La bambina vorrebbe chiederle se sa qualcosa dei suoi genitori, se torneranno presto a prenderla, ma, quando apre bocca, l’unica cosa a uscirle dalle labbra è un lungo e acuto lamento.
«Sstt… Ci sono io. Sstt… Va tutto bene. Va tutto bene», le mormora la donna all’orecchio. Alla breve luce dei fari di una macchina, il suo viso splende pallido e grande come una luna che s’intravede tra le nuvole. Gli occhi le scintillano di lacrime e, come se avessero percepito il suo sguardo, si abbassano verso i suoi, ma la luce se ne va subito e spariscono di nuovo, scivolando nel nulla. Rimangono soltanto le braccia, morbide e salde al tempo stesso, e quell’odore che l’avvolge a ondate. «Sei così dolce», sembra che mormori tra sé, nel buio che di nuovo copre ogni cosa. Fa schioccare la lingua. «Sei così dolce. Poveretta.»
Lavora come custode di quel palazzo da vent’anni. Venti lunghi anni nei quali ha avuto modo di conoscere ogni famiglia dell’isolato, quindi potrebbe giurare che quella bambina non appartiene a nessuna di loro. No, arriva di sicuro da un’altra zona della città. Forse i suoi genitori sono venuti a trovare qualcuno lì nel palazzo, e la piccola è sgusciata via senza che se ne accorgessero. Ma chi lascerebbe una bambina libera di girare in bulevardul Dacia? Chi lascerebbe sola una piccola di tre, forse quattro anni, nel bel mezzo di scontri armati e coprifuoco, coi cadaveri ammucchiati sul ciglio della strada? La donna scuote la testa, incredula e disgustata. Non ha una gran cultura, ma sa cos’è il decoro, e questo è sicuramente un gesto aberrante.
Persino ora che dorme, la povera creatura le stringe la mano così forte che non se la sente di spostarsi dalla tromba delle scale. È ancora lì, immobile, con la piccola in grembo. Quando pensa di poterla sollevare, la bambina s’irrigidisce, si dimena e scalcia, e lei non può fare altro che bloccarla col proprio corpo cadente, ripiegandosi su quel fagottino di carne in una preghiera. Una preghiera che ripete qualche ora più tardi, quando se non altro è riuscita a portare la piccola nella sua stanza al pianterreno, e la luce incerta di un’alba invernale filtra dalla minuscola finestra.
La bambina si sveglia e si mette a sedere sul materasso minuscolo. Gli occhi si muovono vacui nel piccolo locale che la circonda, soffermandosi sulla vecchia cassettiera dallo smalto scrostato, sulla cucina che s’intravede dietro la tenda logora, sulla soba arrugginita nell’angolo, con le poche fiamme tremule che sbattono le ali come falene giganti. Stringendosi addosso la coperta, si sposta verso l’angolo più lontano del letto. Sul volto non c’è paura, solo confusione. «Dov’è la mia mamma? Adesso mi viene a prendere?» La voce è così flebile che si sente a malapena.
La donna abbassa lo sguardo sulle proprie mani gelate, che continuano a sfregarsi come se godessero di vita propria. Nella stufa a legna, le braci scoppiettano. Sono diventate cenere quando lei alza gli occhi. «No, tesoro. No.»
Capitolo 2
Anton e Despina Goza erano noti nella vasta cerchia di parenti e amici per la loro puntualità. Non arrivavano mai con un minuto di ritardo, fosse un appuntamento o un’occasione sociale, a prescindere dall’irregolarità dei mezzi pubblici, dal velo di ghiaccio che ricopriva i marciapiedi o dalle condizioni allarmanti della città nelle ultime settimane. Per Despina quella precisione era fondamentale, quasi fosse la caratteristica che la definiva. Seguiva l’etichetta alla lettera, sempre in orario e curata nei minimi dettagli, dal cappello all’ultima moda parigina alle ballerine in pelle di serpente abbinate alla borsa e alla cintura, che metteva in risalto il suo vitino da vespa. Sebbene superasse di almeno una testa le sorelle maggiori, era estremamente femminile, il ritratto di una sobria bellezza dalle mani curate bilanciato da una cornice elegante e solida. Una dea greca, dicevano spesso le amiche di sua madre, con ammirazione e forse un po’ d’invidia per la sua pelle di porcellana, gli zigomi scolpiti e le onde di capelli castani che mettevano in risalto le spalle chiare.
Appena sveglia, quella mattina, aveva posato gli occhi sulla pendola a muro della camera da letto e si era resa conto con grande sgomento che era tardissimo. Ciononostante era rimasta un altro po’ con la testa affondata nel cuscino, ad ascoltare il mondo che a poco a poco si risvegliava al di là della finestra, come l’acqua che iniziava a gorgogliare in un bollitore. Ogni giorno, Despina era salutata dal rumore dei primi veicoli su strada Vlaicu, dai passi sulla strada e dai saluti ovattati. Trovava conforto nelle cose note: il marito che dormiva profondamente accanto a lei, l’inclinazione della luce del sole che si riversava ai piedi del letto in stile vittoriano, le lenzuola di seta color café au lait che le brillavano attorno come fine sabbia del deserto. La sua serenità venne spezzata bruscamente, però. Alla prospettiva del giorno che l’aspettava, il suo stomaco fece una capriola. È da pazzi, farlo proprio adesso. Una follia, con la guerra che sta per bussare alla porta.
Dentro di sé, sapeva che non sarebbe mai arrivato il momento giusto, che il momento «perfetto» era arrivato ed era passato molto tempo prima, forse. Che, a dispetto della sua fortuna e della sua vita invidiabile, non avrebbe mai avuto ciò che più desiderava al mondo. Dio le aveva voltato la schiena, a quanto sembrava, poiché nonostante le invocazioni e le negoziazioni silenziose ancora non aveva concepito un figlio. Nel suo cuore c’era ancora una traccia di speranza, ma Despina era pronta a fare qualunque cosa pur di farla sparire. Sarebbe stato tutto più calmo. Calmo e immobile, come una terra che trovava pace dopo la guerra. Smettila di sperarci, si rimproverava all’infinito, ma il cuore non l’ascoltava.
Se non altro aveva smesso di pregare. Avrebbe dovuto smettere anni prima, quand’era diventato chiaro che il suo utero non era in grado di sostenere una nuova vita, quando le crisi autodistruttive e la disperazione erano diventate talmente frequenti che le sue sorelle avevano deciso di andare a trovarla solo in gruppo, camminando attorno a lei in punta di piedi e cercando di distrarla con sciocchi pettegolezzi. Una parola avventata, una frase superficiale bastava a gettarla in un vortice di abbattimento che durava giorni interi, dal quale riuscivano a strapparla soltanto unendo le forze.
«Sei stata fortunata in mille altri modi, Despina. Concentrati su tutte le cose che hai.» Le sorelle si scambiavano sguardi condiscendenti e intanto tiravano fuori scatole di cioccolatini, le servivano il tè e le massaggiavano le mani mentre lei era accasciata su una sedia, devastata.
Quattro aborti. Ognuno di essi le aveva aperto una nuova ferita nello spirito e nel corpo, e la delusione era diventata così prevedibile da avere perso il suo aspetto più amaro. La speranza, un tempo ardente, si era sgretolata poco alla volta, diventando una debole brace. Eppure il fuoco non si era ancora estinto del tutto. E poi quell’opportunità inattesa. L’appuntamento era stato fissato così in fretta che non aveva quasi avuto il tempo di prepararsi.
Si guardò allo specchio sopra il lavabo e sospirò, toccandosi le borse sotto gli occhi affusolati. Il suo viso sembrava una maschera di gesso, i tratti ellenici più marcati del solito. Durante le ore d’insonnia doveva essersi morsa le labbra, poiché erano gonfie e arrossate, come un frutto maturo sullo sfondo di una tela vuota. Il getto d’acqua fredda sembrò riscuoterla, riportandola alla giornata che aveva davanti.
Sulla soglia incrociò Anton, che entrava in bagno. Lui la baciò sulla guancia, rivolgendole un sorriso distratto ma pur sempre smagliante. «Buongiorno, amore.»
Despina doveva ammettere che era splendido anche nel pigiama di seta a righe, appena alzato, coi capelli in disordine e nell’alito un vago ricordo del whisky della sera prima. Anton si lavò i denti canticchiando. A volte il suo ottimismo sconfinato la irritava, ma faceva parte del suo fascino. Suo marito era dotato di un innegabile carisma. Di fronte all’allegria con cui lui si dedicava a quel compito banale, Despina non riuscì a trattenere un sorriso, nonostante tutto.
Faceva quell’effetto non soltanto a lei, ma a chiunque lo conoscesse. La leggerezza con cui affrontava la vita era contagiosa, irresistibile. Le donne si voltavano a guardarlo per strada. Somigliava a Cary Grant nell’abito di sartoria, una sciarpa d’angora sulle spalle ampie, il cappello sollevato appena in un cenno di saluto. Sotto il cilindro, un sorriso sincero alla bellezza della vita. Gli uomini ricambiavano quel sorriso, dandogli una pacca sulla schiena, trascinati dalla sua joie de vivre, dalla sua fortuna e dal modo in cui accoglieva a braccia aperte la promessa di un nuovo giorno.
Erano passati dieci anni da quando Despina aveva conosciuto Anton, eppure ogni dettaglio di quel giorno era vivido nella sua mente, come se fosse successo solo il giorno prima. Rifletté divertita che non si sarebbero mai incontrati, se quel giorno suo padre non avesse finito l’inchiostro della sua Montblanc, o se avesse deciso di andare a comprarsi lui stesso un boccettino nuovo. Ma era parecchio indaffarato a controllare il libro mastro e l’aria prometteva una primavera imminente, così, quando le aveva chiesto quel favore, Despina era stata felice di accontentarlo.
Suo padre le aveva porto alcune grosse banconote. «Piaţa Romană. Il negozio, lo conosci. E prendimi anche qualche busta. In carta di lino, se le trovi.»
Era la loro routine. Lei andava a comprargli qualunque cosa di cui avesse bisogno ed era autorizzata a tenersi il resto. Suo padre non faceva mai domande e c’era sempre qualcosa che attirava l’attenzione di Despina nelle vetrine sulla strada: un cappellino grazioso, una borsetta in seta, una sciarpa colorata che s’intonava ai suoi capelli.
Pensando a cosa comprare col denaro che avrebbe avanzato quel giorno, Despina aveva percorso i pochi isolati che la separavano da piaţa Romană, camminando senza fretta. Aveva attraversato la strada con la mente altrove, senza preoccuparsi di controllare il nome delle vie: conosceva la strada a memoria. Suo padre si riforniva in quel negozio da anni e lei conosceva piuttosto bene la proprietaria, la signora Zoltof. Così, quand’era entrata, si era stupita di trovare, al posto dell’anziana donna, un ragazzo in cima a una scala, impegnato a sistemare stecche di sigarette sugli scaffali al di sopra della cassa. Aveva pensato di essere entrata nel negozio sbagliato e stava per uscire, quando una voce sicura e amichevole l’aveva salutata dal piolo più alto.
«Buongiorno, signorina.» Il sorriso sulle labbra del ragazzo era caldo e lento, come se già la conoscesse.
Despina si era ritrovata a fissarlo, dimenticando le buone maniere. Un naso romano perfettamente dritto e occhi castano chiaro, che brillavano di una gioia non detta, come il cognac che vorticava sul fondo di un bicchiere. Mentre scendeva dalla scala, apparentemente senza sforzo, lei aveva osservato gli avambracci muscolosi, scuri come il miele in contrasto col bianco delle maniche arrotolate.
«Prego, si accomodi. Mi dica cosa posso fare per lei.»
Era tornata dentro, richiudendosi la porta alle spalle. «Ecco, vorrei della carta da lettere e dell’inchiostro, grazie.» Aveva pronunciato quelle parole in tono secco, alzando il mento, senza sapere bene perché. «Sono la figlia del signor Papodopulos. Una delle figlie, per essere precisi.» Si era sentita ridicola non appena aveva richiuso la bocca. Perché gli sarebbe dovuto importare di chi fosse suo padre? Era lì per comprare carta e inchiostro, sant’Iddio.
Eppure lui sembrava felice del fatto che si fosse presentata. Mentre la raggiungeva dalla parte opposta del bancone, passandosi una mano tra i folti capelli scuri, l’aveva nuovamente abbagliata col suo sorriso irresistibile. «Al suo servizio. Mi dica pure cosa desidera.»
Sentendosi avvampare, Despina aveva sviato lo sguardo, cercando di fissare gli occhi su qualcosa che le desse uno spunto di conversazione. Non voleva pensare al fatto che, sebbene fosse stata educata all’eleganza e alle buone maniere da quando riusciva a malapena a camminare, si stava comportando come una perfetta stupida. Dio mio, che cosa sconveniente. È solo un commesso. Si era voltata, mettendosi a esaminare le centinaia di campioni esposte sui ripiani degli scaffali a muro. «Vorrei cinquecento di queste buste», aveva detto, gelida, porgendogliene una. Non aveva idea di cos’avesse estratto dallo scaffale, ma poco importava. Mentre lui gliela sfilava dalle mani, le loro dita si erano sfiorate. Le guance di Despina si erano fatte ancora più rosse e lei aveva distolto ancora lo sguardo, mettendosi a giocherellare con le minuscole statuine di vetro di una teca. Sentiva addosso lo sguardo del commesso, che sorrideva divertito.
Anton aveva trovato posto nella sua vita sin dal primo istante, come la tessera mancante di un puzzle. Il padre di Despina – un ricco uomo d’affari greco che si era trasferito con la famiglia a Bucarest dopo la Grande Guerra – si era preso Anton sotto la propria ala senza esitazioni, sorpreso lui stesso di quanto fosse affezionato a quel ragazzo. Certo, Anton non era neanche lontanamente colto quanto Despina e la sua famiglia non era ricca, ma la sua figlia minore era cambiata in meglio così tanto da quando l’aveva conosciuto che lui non aveva nulla da ridire.
Da un giorno all’altro Despina aveva abbandonato l’armatura in cui si era rinchiusa da quando si erano trasferiti lì. Quando avevano lasciato la Grecia, dodici anni prima, Despina era una bambina con l’argento vivo addosso e gli occhi vivacissimi. A ventitré anni invece era quasi un’estranea per lui. Sì, era sbocciata, diventando una bellezza, ma di un genere che trasudava freddezza, distacco.
In quel periodo i suoi occhi erano tornati a splendere, però. Svolazzava di nuovo tra le stanze della loro casa, volteggiando in abiti di seta, con le braccia tese verso il cielo, e rideva, ammirando la bellezza e l’unicità di cose su cui non si era mai soffermata prima. La sua energia era contagiosa, smisurata, e si estendeva come un incendio. In breve tempo, tutti si erano ritrovati ad aspettare le visite di Anton con identico entusiasmo, sciamandogli attorno come se fosse il cardine della loro vita.
Non passava settimana senza un invito a cena o per il tè. Il ragazzo cominciava ad aspettare con ansia il momento delle sfoglie appena sfornate, ogni volta diverse, ripiene di formaggio, spinaci o susine, e del brandy invecchiato trent’anni, posato sul carrello bar della biblioteca un attimo prima del suo arrivo. Era lusingato dal suono di quelle giovani voci femminili, delicate come campanelle, che lo accoglievano alla porta, ed era felice quando si accalcavano tutti in macchina diretti a una festa, come se lui fosse già parte della famiglia.
Grazie al padre di Despina, Anton si era fatto una cultura su eventi mondani, politica e affari. Poi veniva l’arte, insieme col crescente apprezzamento dei piccoli lussi del loro stile di vita: calici di cristallo e posate con le iniziali, l’aroma dei sigari d’importazione, la meravigliosa sensazione degli abiti di seta e lino di cui Despina lo ricopriva, nonostante le sue proteste. Li indossava quando la portava all’Opera o alle corse dei cavalli, la domenica. Aveva imparato a consolidare il proprio fascino innato con un’eleganza studiata, a baciare la mano inguantata di una donna, guardandola negli occhi per un istante, a stringere la mano di un uomo con sicurezza, a esprimersi in un modo che induceva rispetto e ammirazione.
In breve, Anton e Despina erano diventati l’argomento dei salotti della numerosa comunità greca di Bucarest, un’immagine di fascino, eleganza e innegabile bellezza. Accanto ad Anton, Despina appariva ancora più bella e radiosa. A mano a mano che le settimane passavano e loro trascorrevano sempre più tempo insieme, in lei si faceva largo una sola certezza: il suo destino si era compiuto il mattino in cui il padre l’aveva mandata al negozio di cui Anton era ormai diventato proprietario, insieme con altri tre esercizi nei settori più floridi della città.
Da allora avevano avuto grandi gioie. Erano successe molte cose, e i momenti felici superavano di gran lunga le delusioni da cui nessun matrimonio era immune, alla lunga. Sembrava che fossero stati davvero fortunati. Di tutti i ricordi della loro vita insieme, quello che Despina rammentava con maggior emozione era un giorno dell’autunno 1935, quando lei e Anton erano usciti dalla Catedrală Patriarhală sulla collina del Metropolita, mano nella mano. Un fotografo aveva sventolato la mano per richiamare la loro attenzione – «Guardate da questa parte, la luce è perfetta» –, sgomitando per aprirsi un varco tra la folla festosa che occupava la scalinata. Persino anni dopo, quando guardava lo scatto nella cornice d’argento, le mancava quasi il respiro, non tanto per la bellezza che irradiavano nel bellissimo abito da sposa color crema e nello smoking nero brillante, quanto per ciò che l’obiettivo aveva catturato nel loro sguardo.
Mentre Despina sorseggiava il caffè, senza quasi rendersi conto che si stava ustionando il palato, il pendolo della sala da pranzo batté nove lenti rintocchi.
Impegnato nella lettura del giornale, Anton la guardò inarcando un sopracciglio, quindi posò il quotidiano accanto al piatto e addentò il pane tostato. «Quanto vorrei saper leggere nel pensiero.»
«Oh, non è nulla», mormorò lei.
«Dimmelo.»
«Non lo so, Anton. E se fosse l’ennesimo… l’ennesimo fallimento?» Detestava quella parola.
Anton rispose senza esitare, come se fosse l’unica opzione possibile. «Be’, in quel caso ci riproveremo.»
Lei accennò un sorriso, già meno inquieta, grata per il suo ottimismo; sapeva però che era difficile anche per lui. La lieve indolenza del suo sguardo, che soltanto lei riusciva a cogliere, durante gli interminabili pomeriggi in cui si ritrovavano in compagnia delle sorelle di lei con la loro parata di marmocchi, le diceva cosa provava davvero nel profondo del cuore. Stava per dire che era meglio lasciar perdere, rimanere a casa e accendere il fuoco. C’era aria di neve.
«Despina, guardami, tesoro.»
«Anton… Credo che…»
«Non rinunceremo», la interruppe lui, con una severità rara. «Non rinunceremo finché non riterrai che è davvero ora di farlo. Cosa che, conoscendoti, cara la mia mogliettina testarda e bellissima, significa mai», aggiunse ridacchiando.
Despina sentì gli occhi che si colmavano di lacrime. Scosse la testa, un po’ per nasconderle e un po’ perché non sapeva che cosa dire. Voleva solo abbandonarsi tra le braccia del marito e dargli un bacio appassionato, ma poi lanciò un’occhiata all’orologio. Se davvero volevano andare, era meglio sbrigarsi.
Anton tirò indietro la sedia della moglie, le prese una mano e se la portò alle labbra. Despina intrecciò le dita alle sue e strinse forte. In quel contatto c’era tutto ciò che importava, e nessuno glielo avrebbe mai tolto, a prescindere da quello che la giornata aveva in serbo per loro.
Capitolo 3
Attraversarono la città della loro giovinezza come in un sogno. C’erano i picchi bianchi degli edifici art déco, il Palatul Telefoanelor, il gioiello della corona su Calea Victoriei, l’Hotel Capitol, con la sua elegante facciata belle époque, dove tante volte avevano sorseggiato drink spumosi nelle calde serate estive. Non c’erano più persone eleganti ad abbellirne la balconata curva con le ringhiere in ferro battuto, né luci accese dietro le ampie finestre; persino i ponti che collegavano le sponde della Dâmboviţa sembravano abbandonati. Il triste viale sboccò presto nella piazza più grande della città, ed ecco il Palatul Regal, con le sue file lunghissime di finestre. Ai cancelli, un pugno di guardie immobili come statuine di cera teneva lo sguardo inespressivo fisso sulla splendida piazza, la cui pavimentazione, un tempo calpestata da centinaia di piedi, splendeva immacolata sotto uno strato di neve fresca.
Non chiacchierarono molto con l’autista. Era difficile scambiarsi convenevoli sugli indicibili avvenimenti che negli ultimi giorni avevano scosso la città. Tuttavia Anton cercò più volte di spezzare il silenzio, accennando al drastico calo subito dai suoi affari. «Chi può volere i tartufi che vendo, in un momento come questo?»
L’autista mosse appena la testa nella sua direzione, annuendo. Sul sedile posteriore, Despina appoggiò il capo al finestrino gelido, guardando gli enormi, pesanti fiocchi che cadevano sul parabrezza, riducendosi a stelle minuscole. Avrebbe voluto che tutto ciò che aveva visto sparisse allo stesso modo, tramutandosi in acqua per evaporare dalla sua mente.
Tre giorni di carneficina, coi quartieri in fiamme, i cadaveri ammucchiati sul ciglio delle strade, finestre rotte e anime straziate, donne che urlavano e il tanfo di carne bruciata. Uomini che sparivano dal giorno alla notte, che si lanciavano dai palazzi con le armi puntate contro la schiena, e il frastuono degli spari al Parcul Cişmigiu. La gente marciava nelle strade brandendo cartelli che recitavano GLI EBREI SONO IL NEMICO e RISOLVIAMO LA QUESTIONE EBRAICA. In molti avevano dipinto una croce cristiana sulla porta, per evitare che la propria casa venisse vandalizzata e la facciata distrutta. Magari erano persone che conosceva, gente perbene, studenti e lavoratori, ragazzi del liceo e gendarmi che avevano giurato di proteggere i cittadini di Bucarest. Alle loro spalle, la folla manifestava coi pugni levati e con toni accesi, coperta dall’anonimato di quell’odio condiviso. Era ormai normale vedere auto che bruciavano in mezzo ai viali, uomini e donne trascinati in strada, percossi e presi brutalmente a calci.
La sera, la furia scemava, ma la paura nell’animo della gente si faceva più acuta. Tutti sprangavano presto le persiane, chiudevano le finestre e tiravano le tende, accendendo la radio per zittire il mondo esterno. Parlavano con indifferenza di loro conoscenti, dei bambini o di quello che avrebbero mangiato per cena, mentre in strada la Guardia di Ferro e il Movimento Legionario marciavano con le baionette inastate.
Correva voce che il braccio armato rumeno di stampo nazista, meglio noto come gli Squadroni della Morte, fosse il più temuto d’Europa. Notte dopo notte, le sue guardie pattugliavano i quartieri della città nelle uniformi verdi, con la croce uncinata sulla manica. Il tonfo degli stivali che marciavano in sincronia perfetta, le voci che si alzavano e calavano all’unisono, intonando il loro inno sinistro, si sentiva a diversi isolati di distanza:
Morte, solo la morte di un Legionario
è la nostra più ambita unione,
per la Santa Croce, per la patria,
sfidiamo foreste e montagne conquistiamo.
Despina rifletté che i rumeni erano sempre stati animati dal patriottismo, tuttavia era un’energia diversa ad alimentare quegli eventi, qualcosa che il suo amato Paese aveva abbracciato, un’ideologia deprecabile che lo toccava nel profondo e poco alla volta gli aveva rubato l’anima. La mano di Hitler si allungava verso il cuore dell’Europa centrale e orientale, anche se non aveva forze sul campo. Per il momento. E presto quella mano avrebbe stretto il collo del popolo rumeno.
Un pomeriggio, poco dopo le vacanze, aveva assistito lei stessa a uno di quegli episodi, mentre tornava a casa con le borse della spesa. La maggior parte dei negozi del suo quartiere aveva chiuso, in risposta ai continui saccheggi, e lei aveva camminato quasi due ore per trovare una drogheria che ancora avesse un po’ di farina, uova e olio. Sulla strada del ritorno, con le sue sporte pesanti, aveva preso una scorciatoia, sebbene avesse promesso ad Anton di rimanere sui viali principali e di stare accanto alle persone che vedeva per strada. Prima di rendersene conto, si era ritrovata in un labirinto di vicoli ricoperti di schegge di vetro e mucchi di macerie bruciate. Anton si sarebbe infuriato se avesse saputo che aveva vagato da sola in quel quartiere razziato, ma lei camminava impavida.
Ben presto era arrivata in Negru Vodă, un viale tranquillo fiancheggiato da enormi querce centenarie. Era una zona piacevole, dove una volta i passanti si prendevano il tempo di salutare, sorridere e stringersi la mano, mentre i bambini giocavano a rincorrersi tra le gambe dei genitori. Quel giorno, però, quand’era arrivata all’angolo Despina si era fermata, trasalendo.
La Grande Sinagoga, uno degli edifici più antichi della città, era in fiamme. I Legionari ballavano attorno al fuoco, urlando di gioia e dandosi pacche sulla schiena. Avevano cosparso i muri di benzina e il tempio era stato devastato dal fuoco. Non rimaneva traccia della sua architettura eclettica. La Menorah e le Antiche Scritture erano andate perdute. Non erano rimasti neppure i bagni.
I volti di quegli uomini erano il ritratto del piacere, coi sorrisi ampi e gioiosi, grotteschi sullo sfondo delle fiamme che avvolgevano i resti dell’edificio. Despina era rimasta pietrificata, incapace di muovere un passo. Uno dei soldati le aveva rivolto uno sguardo sfacciato, accompagnato da un ghigno lascivo, e si era inchinato, sfiorando terra col braccio. Lei si era voltata, mettendosi a camminare più veloce che poteva, con l’eco frenetica dei tacchi che risuonava lungo il marciapiedi. A un certo punto si era messa a correre, disperata: voleva soltanto arrivare a casa il prima possibile, liberarsi dell’orrore che le serrava la bocca dello stomaco e del sapore della bile che le era risalita in gola. Il solo pensiero della scena che si era trovata davanti la fece ancora rabbrividire nauseata. Non era l’unica a sentirsi così, ne era sicura.
Qualcuno sosteneva che lo stesso Hitler fosse preoccupato per la violenza esplosa a Bucarest dal giorno alla notte, così feroce che rischiava di sfuggirgli di mano. Preferiva un approccio tattico per diffondere la sua visione e una guerra civile non rientrava affatto nel suo progetto per la Romania. Ma il Movimento legionario aveva giurato fedeltà alla Germania e ai principi nazisti di Hitler, ed era pronto a sacrificare la vita dei suoi stessi iscritti, delle loro famiglie e degli amici d’infanzia a quello scopo. La brava gente di Bucarest, la folla, aveva seguito l’onda, sicura di rimanere impunita, coperta dall’anonimato.
Despina era ancora immersa nei suoi pensieri quando la Buick si fermò di fronte a un cupo edificio a due piani, con l’intonaco cadente e un tetto in metallo a buon mercato. Sul muro sbiadito dell’ingresso, una targa blu scuro indicava che erano arrivati a destinazione.
L’autista scese e girò attorno al veicolo per aprire la portiera dal lato di Despina, porgendole la mano guantata. Il cuore le batteva all’impazzata mentre scendeva e si stringeva addosso il cappotto. Avevano atteso a lungo quell’appuntamento, dopo numerosi tentativi infruttuosi di fissare una visita con la direttrice. Solo quando Maria, la cugina di Despina, aveva perorato la loro causa, implorando un incontro, i cancelli si erano finalmente aperti. Qui non vendiamo bambini. I loro soldi non hanno valore, per noi, si era sentita rispondere. Poi nell’orfanotrofio già sovraffollato era arrivata quella bambina e la signora Tudor aveva infine accolto le suppliche incessanti di Maria.
La cugina passava tre giorni a settimana all’istituto a fare il bagno ai bambini, a dare loro la pappa, a tagliare capelli e a medicare ferite, a dispetto delle proteste del marito e delle occhiate esterrefatte delle amiche, incapaci di comprendere quella dedizione irremovibile. Perché diamine lo fa? si chiedevano, quando si ritrovavano ai tavolini all’aperto di un locale, alle corse dei cavalli, da un sarto o in una pasticceria sulla trafficata strada Lipscani, dove andavano a comprare i dolci per i bambini. E che dire di quel poveretto del marito? Che figura ci fa? commentavano, mentre Maria preparava la colazione, metteva a scaldare l’acqua per il bagno e curava l’anima e il corpo di quei figli di nessuno.
Despina sapeva cosa si celasse nel segreto del cuore della cugina, la sua più cara amica, con cui condivideva non solo una somiglianza straordinaria, ma anche un legame infinitamente più forte di quello con le sue sorelle.
Sapeva quanto Maria sentisse la mancanza del suo bambino, il suo unico figlio. Despina lo aveva visto per l’ultima volta a nove anni, in un letto d’ospedale, malato di tifo. Se n’era andato così in fretta che Maria era riuscita a malapena ad accarezzarne il corpicino tremante, a confortarlo con parole d’amore in quegli ultimi istanti di vita. Era per lui che lavorava all’orfanotrofio, offrendo i resti del proprio cuore a quei poveri bambini smarriti.
Un dolore comune che le avrebbe unite per sempre. Con quel pensiero, Despina si aggrappò al braccio di Anton e lo seguì oltre il portone in legno, verso quell’ultima possibilità, il posto in cui il loro sogno non era ancora svanito.
Capitolo 4
Si fermò, colpita all’improvviso da un odore che non riusciva a identificare, qualcosa di marcio che l’aveva stordita come un pugno. Immondizia, capì, appoggiandosi al muro. All’improvviso le ginocchia non la reggevano più e il cuore batteva troppo forte, mentre lei osservava lo squallido cortile dell’orfanotrofio San Paolo. In mezzo c’era un bidone di metallo, accanto a una quercia dai rami spogli, tesi verso il cielo plumbeo come in un’invocazione. Decine di bambini urlanti con la medesima uniforme logora color kaki si rincorrevano attorno all’albero, giocando ad acchiapparello, come se quel fetore non li infastidisse minimamente.
Coprendosi il naso con la mano, Despina avanzò tentennando sull’acciottolato irregolare, cercando di soffocare l’apprensione che si era impadronita di lei. Solo a guardare quei poveri piccoli – pallidi come stracci, col naso che gocciolava, coi capelli rasati, con le ginocchia coperte di croste e con lo sguardo vacuo – si sentiva sopraffare da una tale tristezza che sarebbe voluta fuggire. Perché lei e Anton erano lì? Che cosa speravano di trovare, in un posto come quello? Era stato un errore. È un errore, avrebbe voluto dire ad Anton, mentre si aggrappava al suo braccio.
Poi lui si girò a guardarla con un sorriso che gli illuminava il volto, come se stesse osservando un gruppo di bambini che giocava al parco, in una domenica di sole. «Vieni, tesoro. Va tutto bene.» La cinse con un braccio e la guidò con dolcezza attraverso il cortile, verso quello che sembrava l’edificio principale.
L’avevano quasi raggiunto, quando un ragazzino rachitico di una decina d’anni spuntò accanto a loro, svolgendo e riavvolgendo uno yo-yo con un’abilità sorprendente. «Siete in gita presso questo meraviglioso orfanotrofio? Per darci un’occhiata? Io sono il miglior calciatore del mondo. E so contare gli spiccioli.»
Anton si frugò nelle tasche del cappotto ed estrasse una banconota, che porse al ragazzino senza nemmeno guardarla. Lui gliela strappò di mano avidamente e sgranò gli occhi per la sorpresa mentre se la rigirava davanti al naso, cercando di capire quanto valesse. Poi si chinò per infilarsela in una calza. «Grazie, grazie, signore!»
«Prego. Potresti fare qualcosa per noi, in cambio? Puoi portarci all’ufficio della direttrice?»
«Non sarà necessario», disse una voce brusca e acuta alle loro spalle.
Si voltarono confusi verso la signora Tudor, una donna di mezza età dall’aria impettita, coi capelli sale e pepe stretti in un severo chignon e con uno scialle grigio sulle spalle esili.
La donna lanciò un’occhiata all’orologio da polso e spostò lo sguardo su Despina, che non poté fare a meno di arrossire a quel chiaro rimprovero. «Vi stavo aspettando. Lei dev’essere la cugina di Maria.»
«Sì.» Era stato Anton a rispondere, in tono cordiale, poiché sua moglie sembrava ammutolita. Strinse la mano alla direttrice con un entusiasmo esagerato e rimase di ghiaccio quando lei la sfilò dalla sua presa, nascondendosela dietro la schiena rigida.
«Bene. Da questa parte.» Il sorriso di cortesia della signora Tudor non le raggiungeva lo sguardo. Li guidò a passo di marcia lungo un corridoio che sapeva di ammoniaca e vernice fresca, senza mai voltarsi. Poco più avanti li fece accomodare in un ufficio piccolo quanto un ripostiglio, e indicò le sedie davanti alla scrivania. «Prego, accomodatevi.»
Obbedirono. Anton si sfilò i guanti, appoggiandosi allo schienale, mentre Despina rimase sul bordo della seduta.
La signora Tudor spariva quasi dietro l’ampia scrivania di legno. «Per cominciare, vorrei informarvi di alcune cose.» Si fermò, spingendosi gli occhiali enormi sul naso, e aprì un fascicolo. «La bambina di cui avete chiesto notizie… è particolarmente introversa. Di sicuro Maria vi ha già detto che è arrivata qui a fine gennaio, in circostanze insolite. Pare che sia stata trovata di fronte a un palazzo su bulevardul Dacia dalla custode, la quale l’ha tenuta con sé durante la notte e l’indomani l’ha portata al commissariato di zona, nella speranza che qualcuno avesse chiesto notizie della piccola. Nessuno lo aveva fatto, a quanto pare, così la polizia l’ha accompagnata qui.» Si schiarì la gola e prese un sorso dell’acqua che aveva sulla scrivania. «Quand’è arrivata sembrava più o meno normale, in salute fisica e mentale, ma… non ha pronunciato nemmeno una parola. Ci hanno assicurato che sapeva parlare. In qualche modo la custode era riuscita a farsi dire non solo il nome, ma il giorno e il mese di nascita, eppure sembra…» La signora Tudor esitò, come se cercasse l’espressione più adatta. «… del tutto assente. L’unica cosa che pare interessarle è un vecchio pianoforte che abbiamo relegato da tempo in magazzino. Ci si siede davanti e batte sui tasti per ore. A volte si rifiuta persino di scendere a cenare. Be’…» Chiuse il fascicolo e lo scostò con un gesto nervoso. «Volete ancora vederla?» La signora Tudor voleva accantonare la questione il più in fretta possibile. Era sicura che, non appena quei due avessero visto la bambina, l’incontro si sarebbe concluso…
Roxanne Veletzos è nata a Bucarest, in Romania, ma si è trasferita in California assieme alla famiglia quand’era ragazzina. Si è laureata in Giornalismo alla California State University e ha lavorato a lungo come content writer e marketing manager. La luce del domani è il suo romanzo d’esordio ed è ispirato alla storia vera della madre.
ebook a soli 3,99