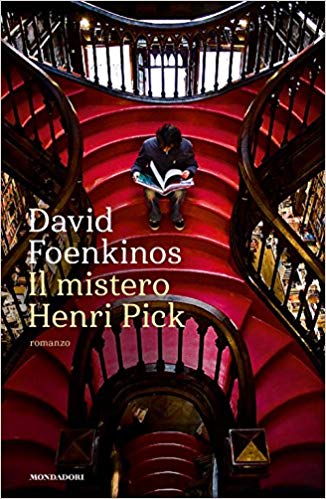TRAMA
«Un romanzo commovente che affronta una tematica forte e attuale: l’importanza della solidarietà.»
Publishers Weekly
«Un libro sul potere della generosità.»
Library Journal
UNA STORIA VERA CHE HA PORTATO LA FELICITÀ NELLA VITA DI MOLTE PERSONE
È il 25 dicembre quando Hope Jensen riceve un dono inaspettato: sulla porta di casa trova un barattolo di vetro pieno di monete, avvolto in un grande fiocco rosso. Nessuna traccia del mittente, nessun biglietto. Il regalo, però, riesce a strapparle un sorriso, dopo tanto tempo. Questo, per lei, è un Natale particolarmente difficile, perché ha appena perso la donna che l’ha cresciuta come una figlia. Quando, grazie al suo talento di giornalista, Hope scopre di non essere l’unica persona ad aver ricevuto un «barattolo di Natale» da parte di un benefattore anonimo, non riesce a crederci. Si trova di fronte a una vera e propria gara di solidarietà, un’iniziativa ispirata da sentimenti di amore e gentilezza. Un piccolo gesto, capace di cambiare la vita di persone che attraversano un momento di sofferenza. Per questo, ognuno di loro decide di farlo proprio e di ricambiarlo. Hope deve scoprire dove tutto ha avuto inizio, perché trovare quel barattolo le ha aperto gli occhi sulla magia delle luci che addobbano la città. Ha fatto crescere dentro di lei un senso di speranza che credeva perduto. Ancora non riesce a immaginare dove la porterà quella ricerca, ma in fondo il desiderio più bello è quello che non abbiamo mai espresso.
Il caso editoriale che ha dato vita al fenomeno dei barattoli di Natale, sempre più diffuso e apprezzato. Perché basta poco per fare del bene e rendere gli altri felici. E quell’amore tornerà indietro, custodito in un vaso di vetro o in altre mille forme. Ma sempre pronto a cambiarci la vita.
ESTRATTO
Per i miei figli
Oakli Shane
Jadi Thompson
e Kason Samuel
PROLOGO
Questa è Hope
Louise Jensen era seduta da sola e si leccava le dita due alla volta, tutta concentrata sul suo piatto di alette e cosce di pollo, quando sentì un pianto smorzato provenire dal tavolo alle sue spalle, al Chuck’s Chicken ’n’ Biscuits sulla US Highway 4. Era un venerdì pomeriggio sul presto. Ed era anche l’ultimo dell’anno.
Non avrebbe mai immaginato di trovare una neonata dagli occhi grigiazzurri abbandonata lì, ma Louise era la classica donna convinta che tutto accada per una precisa ragione. Si chinò a sollevare quel fagotto rosa e lo prese tra le braccia. Infilato tra le pieghe della copertina, che aveva qualche macchia e un motivo a elefanti, vicino al collo della piccola, Louise trovò un biglietto anonimo scritto a mano.
A chi terrà in braccio la mia bambina dopo di me.
Adesso è tua. Non puoi nemmeno immaginare quanto mi mancherà. Ma la amo troppo per farla crescere con un padre violento. La verità e che lui non avrebbe nemmeno voluto che io partorissi, e avrà una vita migliore senza una madre costretta sempre a scappare. Per favore, dille che le voglio bene. E per favore, dille anche che la stringerò di nuovo tra le mie braccia.
Non ho molto da darle, ma con il nuovo anno le offro la vita che suo padre non potrebbe mai donarle. E un po’ di speranza.
Nonostante fosse ormai di mezza età, nonostante facesse la donna delle pulizie e non fosse mai stata sposata e soprattutto non fosse nelle condizioni economiche di potersi assumere la responsabilità di un’altra bocca da sfamare, Louise sapeva che quel momento non era capitato per caso. Ogni anno alla vigilia di Natale cenava da Chuck. Ma la settimana precedente era dovuta rimanere a letto, tutta dolorante per via di una bruttissima influenza. Con la febbre a quaranta e con immenso dispiacere, per la prima volta nella storia era stata costretta a posticipare la sua tradizionale cena a base di pollo. La mattina del trentuno, tre giorni prima di quanto avesse inizialmente pronosticato, Louise era già in piedi e si era arrischiata ad andare da Chuck.
Passò in rassegna la sala e i pochi presenti: i clienti si contavano sulle dita di una mano e di vista li conosceva tutti, ed ebbe l’impressione che, inconsciamente, la madre di quella bambina avesse saputo, chissà come, che l’ultimo dell’anno, proprio a quell’ora, Louise Jensen avrebbe finalmente ordinato la sua tradizionale cena della vigilia.
Osservò gli avventori che, ignari, mangiavano e facevano grandi programmi per l’anno a venire, illuminati dallo sfavillio delle decorazioni natalizie verdi e rosse: Chuck si era lasciato prendere la mano. Sopra le loro teste, dai lampadari scoloriti pendevano delle ghirlande, e a sorvegliare la porta d’ingresso c’era un albero di Natale artificiale. Sulla punta dell’albero, al posto della tradizionale stella o dell’angioletto bianco, era stato sistemato un pollo di peluche con l’espressione imbronciata. Alla cassa, la moglie di Chuck stava cambiando le pile a un Babbo Natale che ballava il boogie woogie.
Louise si sistemò la bambina sotto il cappotto, lasciò una banconota da dieci dollari sul tavolo e sgattaiolò fuori dalla porta laterale. «Buon anno, Louise!» le gridò qualcuno mentre la porta si chiudeva. Voltò la testa e sorrise, ma continuò a camminare di buon passo finché non raggiunse la sua vecchia Chevrolet El Camino arrugginita in fondo al parcheggio. Si guardò intorno, da una parte e dall’altra, più volte, poi sistemò il fagotto con la bambina sul sedile del passeggero, in qualche modo le allacciò la cintura di sicurezza e procedendo a passo d’uomo guidò per circa sei chilometri per raggiungere la zona commerciale più vicina. Per tutto il viaggio parlò ad alta voce, si pose domande che probabilmente sarebbero rimaste per sempre senza risposta e, per la prima volta in vita sua, fu lieta di essersi presa l’influenza.
Anche lei era figlia di una madre single e nel momento in cui si era trovata un primo lavoretto come babysitter per alcuni bambini del condominio, Louise aveva già fatto dell’indipendenza il fondamento dei suoi progetti di vita. All’epoca aveva dieci anni.
Un sano compiacimento per il lavoro scorreva nelle vene degli Jensen da generazioni. Nei ricordi di Louise, sua madre si era sempre data da fare ed era capitato che svolgesse addirittura tre lavori contemporaneamente. Cercava di mettere da parte il più possibile nella speranza che un giorno Louise e suo fratello potessero andare al college e farsi una posizione migliore della sua. Ma Louise non aveva mai preso in considerazione una vita diversa da quella che aveva sempre passato insieme alla madre. Quella donna era il suo punto di riferimento e ogni giorno lavorava finché non le dolevano le mani e la schiena, trattava chiunque come se facesse parte della famiglia e seppelliva le critiche sterili con la concretezza della sua quotidianità, in modo che fosse solo la gentilezza a vedere la luce del sole.
Il fratello di Louise viveva ormai da solo e frequentava una scuola professionale, mentre lei si era diplomata e aveva continuato a lavorare insieme alla madre. La maggior parte dei suoi compagni aveva smesso di crescere prima della fine delle superiori, Louise invece tra i diciotto e i vent’anni si era alzata di altri sette o otto centimetri. Era arrivata a misurare un metro e ottantatré, scalza. I folti capelli bruni le cadevano lungo la schiena e arrivavano ai fianchi. Aveva gli occhi grandi, color cioccolato al latte, occhi che non si dimenticano facilmente.
Louise e la madre lavoravano in ristoranti, alberghi, negozi di alimentari e perfino in qualche stazione di servizio, ma ciò che le due preferivano in assoluto era fare le pulizie per una ristretta cerchia di facoltosi clienti. Insieme erano riuscite a rendere le incombenze domestiche una forma d’arte e pulivano ogni casa come se fosse la loro.
Lavoravano per famiglie danarose. Louise e la madre si inebriavano di quell’atmosfera fatta di mariti, mogli e bambini solitamente ben educati che vivevano la vita a tutta velocità. In apparenza mantenevano un certo distacco professionale, ma nei loro confronti fioriva immancabilmente una muta fiducia e madre e figlia finivano per ammirare e voler bene alle brave persone per cui facevano le pulizie.
Dopo la morte della madre, Louise aveva continuato a lavorare come domestica. Non le era mai sembrato strano il fatto di sentirsi così vicina a sua madre, che per lei era anche un’amica e una socia in affari, come le ricordavano i momenti in cui rincorreva riccioli di polvere o se ne stava a carponi per terra a sfregare i pavimenti di linoleum.
Quando la legò nel seggiolino nuovo, Louise era già persa di quella bimba dall’aria imbronciata. La mattina dopo avrebbe dato la vita pur di tenerla con sé. «Chi trova tiene», disse al telefono a un’assistente sociale.
Approfondite indagini non portarono ad alcuna pista che potesse indicare l’identità della madre. Nessuno ricordava di aver visto la donna quella sera da Chuck, nessuno aveva notato nulla di insolito e soprattutto nessuno era tornato alla tavola calda per chiedere, come ci si sarebbe aspettati: «E quindi, chi si sta prendendo cura di mia figlia?». La madre, questa era la conclusione a cui erano giunti, se ne era andata da tempo. Si era lasciata quella storia alle spalle, e così avrebbero dovuto fare tutti loro.
Dopo mesi di udienze al tribunale per i minorenni, di colloqui, di controlli a sorpresa e montagne di incartamenti, lo stato riconobbe infine ciò che Louise e la sua ristretta cerchia di amicizie avevano sempre saputo: sarebbe stata una madre ideale. Ma non solo: per la piccola, Louise Jensen rappresentava la miglior opportunità per poter vivere una vita felice. Non che quanto stabilito dal tribunale avesse importanza, visto che in ogni caso Louise non avrebbe mai rinunciato a lei.
Di ritorno da quello che sperava fosse l’ultimo appuntamento al tribunale, nello specchietto retrovisore Louise guardò «la bambina», come l’aveva sempre chiamata fino a quel momento.
«Adesso siamo una famiglia», disse ad alta voce. «Che nome ti possiamo dare?»
La chiamò Hope, speranza.
Non ci volle molto a Hope Jensen per rendersi conto che sua madre era pazza. «Ma pazza nel senso buono» diceva ai suoi compagni di scuola. Poco dopo il quinto compleanno di Hope, Louise la portò da Chuck, la fece accomodare al loro tavolo preferito e si preparò a fare quello per cui si era esercitata mille volte davanti allo specchio del bagno. Mentre Hope giocava a tris con le crocchette di patate ancora fumanti, sua madre le mostrò il biglietto scritto a mano e le raccontò senza giri di parole del loro primo incontro. Tra i clienti c’erano facce amiche, persone che avevano capito quello che stava succedendo in quel momento e che osservavano con affettuosa curiosità.
«Allora tu non sei la mia mamma?» chiese Hope alla prima pausa di Louise.
«Ma certo che sono la tua mamma, tesoro mio.» Non era abituata a sentirsi le lacrime agli occhi. «Hope Jensen, io sono tua madre oggi esattamente come lo ero ieri. E lo stesso vale per domani e tutti i giorni a venire.»
Hope annuì, come se quell’informazione non fosse altro che un’altra tessera del variopinto mosaico che stavano componendo insieme. «La incontreremo prima o poi?» chiese Hope.
«Non lo so, amore. Ma scommetto che a lei piacerebbe vederti, un giorno o l’altro.» Allungò le braccia sul tavolo e prese le manine innocenti di Hope tra le sue. «Vuoi sapere una cosa? Non deve essere stato per niente facile dire addio a una delle bambine più speciali che Dio abbia mai creato.»
Hope rimase seduta in silenzio a metabolizzare tutte quelle notizie e intanto cercava di tenere in equilibrio sulla saliera delle bustine di dolcificante. «Mi voleva bene?»
«Certo che sì, tesoro», rispose Louise. «Ti voleva così tanto bene che ha deciso di regalarti una vita migliore.»
Tutte le preoccupazioni di Louise si dissolsero con la domanda successiva.
«Okay, mamma. Adesso posso avere una gazzosa con il lime?»
1
L’ultimo giorno di scuola materna Hope Jensen, camminando mano nella mano con la madre, annunciò di aver finalmente preso una decisione riguardo alla sua futura carriera. «Da grande diventerò presidente degli Stati Uniti oppure sarò una famosa inviata per un giornale.»
«La seconda opzione mi sembra più nobile», la prese in giro la madre.
Hope era d’accordo e puntò a lavorare per la redazione di un giornale.
Chi la conosceva era pronto a scommettere che Hope avesse iniziato a scrivere già nel pancione. Da piccola la si vedeva più spesso con carta e matite tra le mani, che non con sonagli e biscotti. Per tutta la seconda elementare fu costantemente impegnata a scrivere una serie di spettacoli teatrali su un’allegra banda di coniglietti motociclisti. In terza compose uno struggente racconto su un topolino senzatetto che salvava la famiglia vincendo alla lotteria. In quarta e in quinta scrisse un bollettino periodico intitolato «Notizie dagli Jensen». All’inizio delle scuole medie quella ragazzina allampanata aveva ormai una lista di abbonati a dir poco sbalorditiva che comprendeva cugini di ogni grado, insegnanti ed ex maestri e persone con cui, come si scoprì in seguito, non aveva alcuna relazione. Ogni due settimane, sempre di lunedì, quaranta lettori sparpagliati in sei diversi stati e in Canada, ricevevano un articolo di quattro pagine.
Hope diventò una giovane donna di straordinaria bellezza. Con il passare degli anni i suoi occhioni grigiazzurri avevano preso ricche sfumature verdi. «I tuoi non sono occhi: sono pietre preziose», le diceva Louise. I capelli, spesso raccolti in una coda di cavallo, erano scurissimi e in netto contrasto con la sua carnagione chiara e con quegli occhi.
Hope pensava spesso alla misteriosa donna che l’aveva abbandonata a un tavolo del Chuck’s Chicken ’n’ Biscuits. «Mamma, pensi che abiti ancora da queste parti? Mi assomiglia? Secondo te anche lei preferisce la limonata rosa? Penserà mai a me?»
«Può darsi», era la risposta di rito a quelle domande impossibili. In cuor suo Hope credeva veramente che prima o poi avrebbe avuto le risposte che cercava, ma la ragione le diceva il contrario.
A partire dalla sua seconda vigilia di Natale, e per tutte le vigilie a venire, Hope e Louise Jensen mantennero viva la tradizione di andare a cena da Chuck. Arrivavano sempre molto presto e ordinavano sempre gli stessi piatti: pollo, panini con burro fresco e torta offerta dalla casa, accompagnata da tutto il gelato alla vaniglia che riuscivano a ingurgitare. Mangiavano con calma gustandosi ogni boccone, si raccontavano aneddoti e si confidavano quello che immaginavano la vita avesse in serbo per loro.
«Non si può mai sapere», ripeteva Hope alla madre man mano che si avvicinava lo scoccare della terza ora. «Magari è l’anno buono.»
«Può darsi» le rispondeva la madre. Ma la donna del mistero non arrivava mai.
«L’anno prossimo, ne sono certa!» diceva Hope, come se fosse un fatto assodato.
«La gioia», così le amiche di sua madre chiamavano Hope, fu la prima studentessa del secondo anno di superiori a essere nominata caporedattore del giornalino scolastico. Affidare gli articoli, revisionarli e vendere spazi pubblicitari le piaceva, ma solo scrivere le dava un vero brivido. «Nelle sue vene non scorre sangue, ma inchiostro», diceva raggiante sua madre.
Gli anni delle superiori stavano per rimanere solo un ricordo tra le pagine dell’annuario quando Hope toccò l’apice della sua carriera: un articolo di approfondimento sul consulente dell’ufficio orientamento che, senza un costosissimo trapianto di fegato, sarebbe morto. Il corpo studentesco raccolse quasi diciannovemila dollari. Il consulente sopravvisse e il toccante pezzo di Hope si aggiudicò il primo posto ex aequo a un concorso nazionale di giornalismo riservato agli studenti delle superiori.
Per guadagnarsi qualche credito formativo in più, ma anche perché già sapeva come si sarebbe guadagnata da vivere in futuro, Hope fece domanda e si aggiudicò un tirocinio al «Daily Record». Era l’unico giornale degno di tale nome pubblicato tra la sua città e le quattro limitrofe. Fece tutto quello che le veniva chiesto e di lì a breve né il distributore dell’acqua, né la fotocopiatrice o l’affrancatrice automatica ebbero più segreti per lei. Erano passate solo due settimane dal giorno del diploma quando le venne offerto un lavoro remunerato.
Partì da un minuscolo cubicolo alla sezione annunci. «È un inizio», aveva detto alla madre la sera in cui avevano fotocopiato e incorniciato la sua prima busta paga. Hope, la bambina prodigio, era sulla strada verso il Premio Pulitzer e il suo obiettivo era diventare una grande giornalista americana. Alla parete sopra la scrivania erano appesi i primi piani dei suoi idoli (Bernstein, Woodward e Graham) che formavano un quadrato insieme a una quarta cornice in cui non c’era alcuna foto. Dietro il vetro era attaccato con del nastro adesivo un foglio bianco su cui, tutto in maiuscolo e con un pennarello nero, aveva scritto: LA PROSSIMA SARÒ IO.
Il lavoro la teneva impegnata solo ventotto ore a settimana, quindi aveva tempo libero in abbondanza e poteva frequentare dei corsi al college pubblico. Quando qualcuno chiamava il giornale, all’altro capo del telefono trovava la frizzante diciottenne che scriveva i migliori annunci che si potessero comprare per ventinove dollari a settimana. «Di case così non ce n’è!», «Una Firebird rosso ciliegia: impossibile passare inosservati!». Nessuno sapeva scriverli come Hope.
Dopo un anno passato a scrivere annunci e a pubblicizzare l’ennesima offerta speciale «solo per questa settimana», Hope fu promossa alla sezione Eventi e scrisse briosi pezzi sulle fiere d’autunno, sui mercatini di libri e sulle bancarelle di torte fatte in casa per raccogliere fondi destinati alla caserma dei pompieri. «Queste cose le potrei scrivere a occhi chiusi», diceva alla madre.
«Porta pazienza, tesoro. Ci vuole pazienza.»
Dopo un altro anno e mezzo di duro lavoro, e un intero anno di scuola, Hope stava per completare l’ultimo trimestre del programma di giornalismo. «È arrivato il momento di fare di più», disse al suo capo. Prima della busta paga successiva fu promossa di nuovo, questa volta alla pagina degli editoriali. Ordinarono tacos e nachos da asporto e diede la grande notizia alla madre.
Durante la cena Hope fantasticò ad alta voce sui suoi futuri successi. «Scriverò uno speciale, me lo sento, e finirà in prima pagina! La chiamano “sopra la piega”, la parte alta.»
«Non sapevo che…»
«Ovviamente vincerà il premio come miglior pezzo dell’anno. E prima ancora della consegna della targa dorata, starò già scrivendo per il “Washington Post”.»
Finirono i nachos senza lasciarne nemmeno una briciola, raccolsero anche le più microscopiche e si leccarono addirittura le dita. Buttarono via le vaschette di alluminio e i sacchetti di carta e poi Louise chiamò la figlia, ancora persa nelle sue fantasticherie, e la fece sedere sul divano perché anche lei aveva una notizia importante. Poche parole, una frase tanto semplice quanto scioccante.
«Ho il cancro.»
Louise abbracciò la figlia in lacrime e la tenne stretta a sé sul divano fino all’alba.
L’ AUTORE

Jason F. Wright, giornalista e scrittore, è autore di libri di grande successo, sempre in classifica su «New York Times» e «Wall Street Journal». Scrive per «The Washington Times», «The Chicago Tribune» e «Forbes». Vive con la moglie e i figli nella Shenandoah Valley, in Virginia.