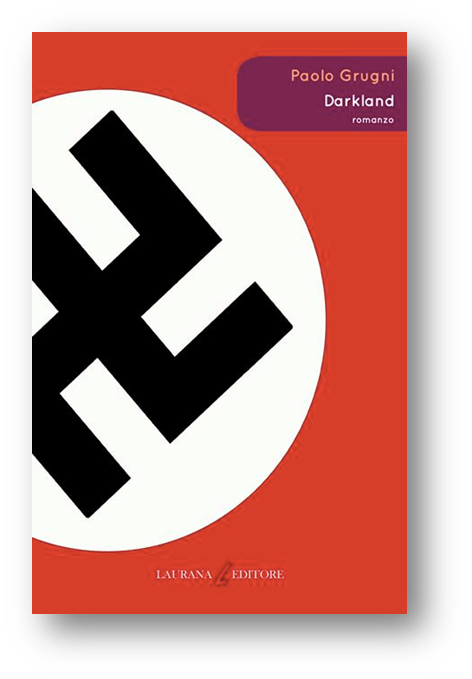Con la sua passione ha creduto nel cambiamento.
Con la sua forza lo ha reso possibile.
È l’autunno del 1894 e la ventiquattrenne Maria è una brillante studentessa di medicina. Eppure sono tempi difficili per una donna all’università: Maria non può neanche raggiungere il dipartimento di Anatomia senza essere accompagnata da un uomo. Nonostante questo, tra pregiudizi e umiliazioni, Maria riesce a studiare e ben presto inizia a lavorare come assistente in due ospedali romani. È allora che si trova costretta ad aprire gli occhi sulla realtà: intorno a lei esiste un mondo di povertà e miseria, e sono i più fragili, i bambini, a subirne le conseguenze peggiori. Sarà qualche anno più tardi, quando comincerà a lavorare in una clinica psichiatrica, che Maria scoprirà davvero la sua vocazione. Qui, infatti, conosce il dottor Giuseppe Montesano, che sta conducendo una ricerca sui bambini affetti da disturbi mentali. Bambini definiti “anormali”, chiusi in un muro impenetrabile di silenzio. Ma quando Maria dà loro dei semplici giochi, quel muro crolla. Sono i primi passi di quello che diventerà il “metodo Montessori”, che si basa su un principio fondamentale: la libertà del bambino di esprimersi, senza costrizioni o barriere. Maria, però, non è solo una brillante scienziata: è una donna, fragile, appassionata, combattiva. E l’amore per il collega Montesano la porterà a prendere la decisione più difficile della sua vita.
Bestseller nella classifica dello Spiegel, in corso di traduzione in undici Paesi,
La donna che insegnava la libertà non è solola storia incredibile di Maria Montessori, è anche l’omaggio a tutte le donne capaci di osare e di superare i limiti del proprio tempo.

Manicomio di Ostia presso Roma
1894
Le campane della chiesa di Sant’Aurea annunciarono la messa vespertina. Il loro basso clangore metallico riecheggiò tra le case, s’infiltrò fra le spesse mura dell’antico edificio che, un tempo, era stato un convento. Quel suono trasmetteva una sensazione di tranquillità, di familiarità. Risvegliava vaghi ricordi di una vita libera, di risate e giochi spensierati. Cortili punteggiati di galline che i bambini inseguivano nel tentativo di acchiapparle. Botteghe aperte inondate di sole. Legna appena tagliata che diffondeva nell’aria il suo odore aromatico. Il suono delle campane si fece sempre più fioco, e svanirono così anche le immagini nostalgicamente evocate di un tempo passato.
Luigi era accovacciato su un materasso duro. Lo avevano di nuovo chiuso nella minuscola cella, del tutto spoglia a eccezione di un letto d’acciaio. Attraverso una finestrella quadrata sulla parte più alta del muro, scorgeva il cielo che si tingeva di un azzurro sempre più scuro, che preannunciava l’imminente tramonto. Non sapeva bene perché fosse ancora lì. La sua permanenza in quella stanzetta aveva qualcosa a che fare con una macchia color ruggine che, accusatoria, lo fissava dalla parete grigia. Gli ricordava un animale, del quale aveva dimenticato il nome, proprio come cancellava dalla memoria, una dopo l’altra, persone e immagini legate al suo passato. Forse quella chiazza era il suo stesso sangue ormai secco. Avrebbe imbrattato il muro fino a quando la camera non fosse stata ridipinta. Ma potevano volerci degli anni, perché i fondi scarseggiavano, e chi arrivava in quel posto non valeva nulla per le autorità, addirittura meno rispetto alla marmaglia che affollava le vie dei quartieri poveri di Roma.
Nell’istituto di Ostia, che sorgeva nella zona del porto, erano ricoverati i malati di mente, gli idioti, gli storpi dei quali ci si sbarazzava per proteggere il resto della società dai loro comportamenti imprevedibili. Luigi, con i suoi otto anni, non era tuttavia l’ospite più giovane. Nello stanzone adiacente c’erano bambini che avevano appena cominciato a muovere i primi passi. Invece di rallegrarsene, però, e traballare sorridenti in giro per la stanza, sedevano sui loro lettini e fissavano con occhi vacui le coperte disadorne.
Perché Luigi non era con loro? Aveva morso di nuovo qualcuno? Uno dei guardiani gli aveva dato del mostro pericoloso, del selvaggio che non aveva ancora imparato a sottomettersi alle regole della società. Ricordava vagamente il sapore del sangue. Il suo? L’unica arma che possedeva era la bocca. E con quella si difendeva dagli attacchi degli adulti quando lo spogliavano con le loro manacce e gli gettavano addosso l’acqua gelida per evitare che puzzasse come una bestia. Una pratica penosa e umiliante, che si ripeteva ogni settimana.
Sì, era possibile che avesse affondato i denti nella stoffa ruvida e maleodorante della sua camicia, le cui lunghe maniche erano legate ben strette dietro la schiena. Riusciva a malapena a muoversi. E la macchia sulla parete? Strizzò gli occhi. Le ciglia trattenevano minuscole gocce scure e ormai asciutte. La tempia destra pulsava. Forse lo avevano sbattuto contro il muro. Fece una smorfia e sentì la pelle dell’occhio destro tendersi. Era ferito ma non gli importava. Andava bene così, il dolore gli era amico, gli serviva a comprendere che era ancora vivo. Fintanto che lo avesse provato, aveva la certezza di non essere morto. Tutto era preferibile al terribile vuoto che accompagnava le sue giornate, una dopo l’altra. Un vuoto che riusciva a riempire soltanto con l’inutile battaglia contro i suoi guardiani.
Desiderò che le campane della chiesa suonassero ancora, per far riaffiorare i ricordi più felici, quelli per i quali valeva la pena di lottare. Più tempo passava rinchiuso lì dentro, però, più le immagini nella sua mente sbiadivano. Il suo timore più grande era che, a un certo punto, si sarebbero spente per sempre. Paventava il momento in cui si sarebbe arreso al proprio destino come gli altri bambini, rassegnati e inermi. Con la testa appoggiata sulle ginocchia ascoltò il silenzio. Era cupo, minaccioso, un buco senza fondo nel quale pian piano finivi per sprofondare. Luigi aspettava le campane che, a una certa ora, avrebbero chiamato di nuovo i fedeli alla preghiera strappandolo, per qualche istante, a quella vuota oscurità.
Roma
Autunno 1894
«Dov’è papà?» In sala da pranzo, Maria, agitata, camminava avanti e indietro e al passaggio di ogni carrozza si precipitava alla finestra che sporgeva sulla strada per guardare dabbasso.
«Arriverà a momenti» la tranquillizzò la madre, Renilde Montessori. Alzò lo sguardo dal ricamo, un centrino di pizzo che intendeva sistemare sul lucido comò in legno di ciliegio, affinché ogni visitatore potesse apprezzare la sua abilità e la cura con cui si dedicava alla propria casa. «Tuo padre sa che oggi deve accompagnarti all’università.»
«A volte mi viene da pensare che ritardi di proposito, per rendermi le cose ancora più complicate. Come se non bastassero già tutti i problemi che mi danno, in università.
Ogni giorno devo impormi agli occhi di compagni invidiosi e professori ignoranti che preferirebbero non vedere neanche l’ombra di una donna nelle loro preziose aule.» Maria ritornò al tavolo da pranzo e si accasciò con poca eleganza su una sedia. Spazientita, tamburellò con le lunghe ed esili dita sulla superficie di legno.
«Sciocchezze. Tuo padre sta per arrivare. Lo sa che non puoi andare da sola al dipartimento di Anatomia e che solo lui può accompagnarti. Sarebbe sconveniente per una donna come te andare in giro senza un cavaliere.» Renilde, corrucciata, appuntò con aria di rimprovero gli occhi sulla mano della figlia. «Smettila di fare quel rumore!» disse severa.
Contrita, Maria appoggiò la mano in grembo. Nonostante i suoi ventiquattro anni, in certe occasioni – e in particolar modo davanti alla madre – si sentiva una bambina che meritava di essere rimproverata per l’irruenza del suo comportamento. Eppure, era una delle prime donne in Italia a studiare con successo Medicina, e nell’ultimo mese aveva addirittura vinto l’ambito premio della Fondazione Rolli: una consistente borsa di studio del valore di mille lire che l’aveva resa finanziariamente autonoma dai genitori.
«Se si trattasse di una normale lezione o di un qualunque altro seminario, non mi importerebbe di arrivare in ritardo» disse Maria. Essendo una donna, era costretta a entrare dopo i colleghi, e giacché molti ritardavano, doveva sistematicamente attendere, perdendosi così la parte introduttiva di ogni spiegazione. «Qui però stiamo parlando del mio primo ingresso in sala anatomica, e per di più di una lezione privata. Arrivare in ritardo sarebbe imbarazzante. Il professor Bartolotti non gradirebbe una simile mancanza di rispetto.»
«Lo so, Maria. E lo sa anche tuo padre, credimi.»
Da giorni, in casa Montessori non si parlava d’altro e Maria non perdeva occasione di esternare i propri timori. Aveva orrore della sala riservata alla sezione dei cadaveri e, se avesse potuto scegliere, l’avrebbe evitata. Senza le ore di Anatomia, però, laurearsi era impossibile, e così non le restava che superare l’ostacolo.
Renilde posò il ricamo su un tavolino e guardò la figlia con aria incoraggiante.
«Hai fatto tanta strada, finora. Ce la farai anche stavolta.» Al contrario del marito, Alessandro Montessori, impiegato al ministero delle Finanze, la madre aveva sin da subito accolto con entusiasmo e appoggiato con convinzione la decisione di Maria di diventare una delle prime donne laureate in Medicina in Italia. La scelta della figlia non era giunta inaspettata per lei. Terminati gli studi primari, Maria si era iscritta in un istituto tecnico dove, due anni dopo, aveva conseguito il diploma in Scienze naturali. La Medicina era stata una logica conseguenza degli studi intrapresi. Alessandro aveva una visione completamente diversa della situazione, ma Renilde era orgogliosa della figlia e forse anche un po’ gelosa, perché lei stessa era dotata di uno spirito brillante e di un vivo interesse per le scienze. Purtroppo, a lei era stato impedito di diplomarsi, un privilegio che le donne del neonato Regno d’Italia stavano conquistando un passo dopo l’altro.
«Potresti sfruttare l’attesa in maniera utile e sistemarti i capelli» consigliò Renilde. «Hai una ciocca fuori posto che non solo ti fa sembrare trascurata ma anche frivola. Non puoi permetterti che si spettegoli su di te.»
Maria fece una smorfia. Le critiche materne sul suo aspetto erano diventate un’abitudine. Renilde Montessori, nata Stoppani, proveniva da una famiglia di latifondisti di Chiaravalle, una cittadina nei pressi di Ancona. Come molti italiani, era convinta che la chiesa cattolica non rappresentasse soltanto l’unico vero credo, ma anche che impartisse le regole di vita fondamentali alle quali attenersi. E la pudicizia sembrava essere per lei una delle virtù più elevate.
Maria stava per seguire il consiglio della madre, quando udì aprirsi la porta d’ingresso al piano terra.
«Alla buon’ora!» Scattò in piedi, scordandosi del tutto i capelli scompigliati; afferrò la tracolla di cuoio piena di libri e appunti, e si precipitò verso le scale. Per evitare di portare un peso eccessivo, aveva suddiviso i volumi in piccoli fascicoli, stratagemma che le permetteva di avere a portata di mano solo il materiale che le serviva davvero. Terminati gli esami, li avrebbe fatti nuovamente rilegare. Nonostante quel trucchetto, la sacca era comunque abbastanza pesante.
«Maria!»
«Sì?» Si voltò a guardare la madre.
«Sarai di ritorno per cena?»
«Non lo so.»
«Ieri Flavia ha preparato la pasta fresca e stasera vuole servirla con burro e salvia. È uno dei tuoi piatti preferiti.»
«Per quanto mi tenti, mamma, purtroppo non so dirti quanto a lungo mi tratterrò in sala anatomica.»
Renilde ci rimase male. Non gradiva la prospettiva di dover attendere fino a tardi per il ritorno della figlia. Le chiacchierate serali con lei erano il momento più interessante della sua routine quotidiana, sempre uguale. Da anni conosceva nel dettaglio la vita di Maria e sperava che le cose non cambiassero mai.
«Ti aspetterò.»
«A presto.» Maria lanciò al volo un bacio alla madre e corse con poca signorilità lungo il corridoio fino all’atrio, le sottane raccolte in una mano per evitare di inciampare, il piccolo orologio d’oro che portava al collo che dondolava a destra e a sinistra.
All’ingresso trovò ad attenderla il padre, un uomo prestante e molto attento al suo aspetto. Alessandro Montessori aveva già consegnato alla domestica Flavia la borsa portadocumenti, ma non il cappello. In una mano ancora inguantata stringeva il bastone da passeggio.
«Continua a correre così e vedrai che inciamperai nei tuoi stessi piedi» le fece notare con un leggero tono di biasimo.
Maria, dal canto suo, era semplicemente felice che avesse ripreso a parlarle. Più di due anni prima, quando gli aveva comunicato di voler studiare Medicina chiedendogli la sua opinione al riguardo, non le aveva rivolto la parola per settimane, ignorandola come se non esistesse. Ricordava ancora la tortura dei pranzi insieme. Per fortuna, quella fase era ormai acqua passata, soprattutto grazie al contributo di due eventi importanti: il conferimento della borsa di studio della Fondazione Rolli e l’onore che le era stato tributato due anni prima alla Festa dei Fiori di Villa Borghese, durante la quale la regina d’Italia, Margherita, le aveva consegnato una bandiera e un bouquet. La foto dell’evento, che ritraeva lei e la sovrana, era stata poi pubblicata insieme a un articolo nel quale il reporter non aveva soltanto lodato la bellezza di Margherita, ma anche la grazia e l’eleganza della giovane studentessa di Medicina.
Sebbene Alessandro guardasse di nuovo la figlia con orgoglio, sembrava che i giorni in cui avevano condiviso un rapporto di caldo e incondizionato affetto appartenessero al passato. E tutto questo proprio per la decisione di intraprendere quel corso di studi contro la sua volontà.
«Tra un’ora devo essere nella sala anatomica» gli disse, fremente.
«Non è il posto adatto per una fanciulla» bofonchiò lui.
«Ti sono grata del passaggio» replicò Maria, fingendo di non aver sentito.
In silenzio, il padre aprì la porta d’ingresso e le cedette il passo. Maria prese lo spolverino che Flavia le porgeva. La domestica lavorava presso la famiglia ormai da un anno, al posto di Silva che, nubile e incinta, aveva dovuto lasciare la casa quando aveva confessato le proprie condizioni. Renilde non tollerava la debolezza morale. Tanto moderna era per quel che riguardava l’educazione della figlia, quanto arretrate erano le sue idee sui rapporti tra uomini e donne.
Invece di indossarlo, Maria si gettò l’indumento su una spalla. Non sentiva freddo. Al contrario. L’agitazione dell’attesa le aveva imperlato la fronte di sudore, che adesso le colava lungo le tempie. Il cuore palpitava forte, i respiri erano brevi e affannosi. Forse quella mattina avrebbe dovuto stringere meno i lacci del corsetto. L’esperienza, tuttavia, le aveva insegnato che poteva influenzare gli sguardi dei colleghi con il proprio aspetto. Più sottile era la vita e, di conseguenza, più femminile la silhouette, più suscitava ammirazione, addolcendo gli sguardi ostili quando percorreva i lunghi e tetri corridoi dell’università.
Svelta, uscì sul pianerottolo e precedette il padre lungo l’ampia scala a chiocciola che conduceva al pianterreno. Davanti al portone, li attendeva una carrozza scura. Alessandro Montessori era appena rientrato dal ministero delle Finanze, dove lavorava come primo revisore. In genere, camminava lungo il Tevere per rincasare. Il fatto che oggi avesse chiamato una vettura diede a Maria la certezza che qualcosa non andava.

Laura Baldini è lo pseudonimo di Beate Maly. Amata da critica e pubblico per i suoi romanzi storici, è tradotta in tutte le principali lingue europee. Vive con il marito e i tre figli a Vienna.
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso