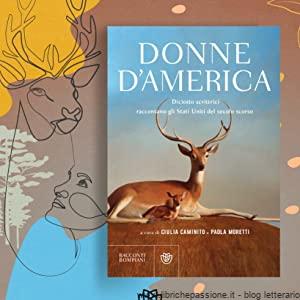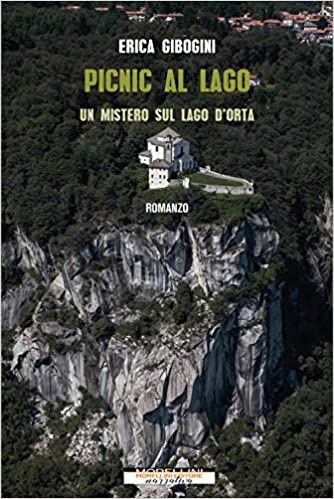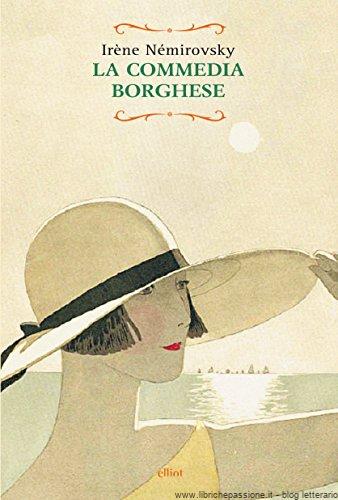

Nel 1934, dopo il successo della trasposizione cinematografica di David Golder, Paul Morand chiese a Irène Némirovsky di affidargli i suoi scritti “per il cinema” con l’idea di riunirli in volume nella collana “Renaissance de la nouvelle”, nuovo progetto dell’editore Gallimard. Nacque così la raccolta dei films parlées, racconti sul crinale tra nouvelles e scenarios che avrebbero dovuto innescare un cambio di rotta nel tragitto creativo dell’autrice, da sempre sensibile alle possibilità espressive del grande schermo. I brani qui riuniti percorrono, talvolta anticipandoli, alcuni dei luoghi più autenticamente némirovskiani della narrazione: la classe media provinciale, previdente e fasulla nella Commedia borghese; lo scetticismo per i fanatismi nei Fumi del vino; il rancore filiale e la gelosia materna in Film parlato; le età della vita in Ida. È una scrittura, quella di questi racconti, puramente descrittiva, acuminata e profondamente letteraria, ispirata e proiettata a quella tecnica da “macchina da presa” cui la narrazione, secondo l’autrice, non doveva rinunciare. Nell’avvertenza che compariva come introduzione all’edizione francese fu la stessa Némirovsky a spiegare: “Ho sempre pensato che il cinema sia imparentato soprattutto con il racconto, che questi due generi abbiano delle leggi simili. Il ro manzo usa digressioni e riflessioni; si può permettere di dilungarsi e, in alcuni casi, deve farlo. Il cinema e il racconto esigono sobrietà, i dialoghi non possono essere eccessivi. La loro maggiore preoccupazione è di spiegarsi completamente, in spazi brevi”.

I fumi del vino
La Finlandia, in tempi turbolenti. Estati brevi, lunghi e rigidi inverni. Soltanto a mezzogiorno, squarciando una nuvola, un raggio rosso accende la neve, brilla e si ritrae. Subito dopo, arriva il crepuscolo. Tutto tace, tutto si chiude nelle case, sotto il lume, e presto si addormenta. Le slitte sono rare e scivolano silenziose. A volte, si sentono tintinnare lontane campanelle, nella caligine della sera, nella neve. Poi il silenzio, il profondo silenzio.
Nevica. Le slitte trasportano in città dei tronchi d’albero tagliati nelle foreste vicine. L’odore dolce del legno si spande nell’aria, la linfa cola ancora dall’incisione inflitta di fresco. La respirazione dei cavalli e quella degli uomini, addormentati sotto i teloni coperti di neve, si confondono e si sollevano in fumo. I laghi gelano. I torrenti, gli stagni, il golfo davanti alla città sono coperti da un carapace di ghiaccio. Si cammina, e per chilometri si vedono solo lande innevate, completamente intatte, e all’improvviso, all’orizzonte, una casupola isolata, nascosta, investita dal ghiaccio e dal vento. Le foreste sono profonde e prive di uccelli. Il suolo è marcato da tracce di bestie, ma non vi si fa caso; non si sentono voci umane, né rumore di passi.
Quindici anni prima di questo, i paesi vicini erano in agitazione e la tranquilla Finlandia aveva fatto fuoco a sua volta. Ma in una giornata invernale fredda e tranquilla, tutto sembra uggioso e indolente.
Due contadini si spostano di villaggio in villaggio, risalendo verso il nord, si fermano in tutte le stazioncine gelate, sotto la pensilina di legno, e incollano al muro i manifesti rossi con il martello e il fucile tracciati in nero: il richiamo al saccheggio. Il vento selvaggio lacera e fa a pezzi la carta, e i pezzi volano nell’aria. I contadini hanno poggiato a terra le loro lanterne, e il vento percuote la fiamma attraverso la sottile barriera di vetro. Alcuni castelli sono bruciati; le statue accecate, abbattute, cadono nei parchi. Un pianoforte, gettato nel lago, affonda lentamente nell’acqua, rompendo il ghiaccio. Le cantine vengono saccheggiate, ma erano mezze vuote già da un pezzo.
«In città» dicono i contadini senza rimorso «ne avranno delle altre!». Poi, le fiamme ricadono, la cenere si disperde. Dalle finestre spalancate soffia il vento. Le foglie morte coprono un vecchio specchio rotto gettato nel prato. Esemplari maschili di oche passano nel cielo con strida acute. Nevica. I fiocchi sono leggeri e il vento li disperde con facilità. Sul campo è disteso il cadavere di un soldato, a terra, tranquillo e con gli occhi chiusi. I corvi hanno spiccato il volo sghignazzando. Più tardi, il cadavere sprofonderà sempre di più nella neve spessa e in primavera verrà ricoperto dalle erbe trepidanti, dall’avena selvatica, dai fiori.
In città, è tutto tranquillo. L’inverno intorpidisce gli abitanti. La bandiera rossa è piantata in cima agli antichi edifici di Stato, rossi anche loro, color del sangue rappreso, del sangue nerastro e corrotto. Le aquile imperiali sono state smurate. I soldati della milizia fanno la ronda. Ma la vita scorre uggiosa e tetra al pari di prima. Eppure in alcune case, pacifici appartamentini borghesi, arredati alla tedesca, con la pianta verde sul tavolino tondo di lacca, tra il pianoforte verticale e la gabbia del canarino, ci sono uomini che restano nascosti per tutto il giorno in una stanza senza luce, con le finestre chiuse, e quando sulla terra gelata risuona il passo dei miliziani, aspettano, chiudono gli occhi, abbassano il collo, come bestie prese in trappola, e in cuor loro contemplano disperatamente – per l’ultima volta, pensano – un’immagine. Ognuno la sua, ma si somigliano tutte tra loro più di quanto non credano. Questi uomini sono gli ufficiali dei reggimenti russi che, rifugiatisi in Finlandia, sono stati colti tra due rivoluzioni, tra due fuochi, e temono i soldati insorti. I miliziani chiudono un occhio, fingono di dimenticare l’ordine di massacrarli che arriva loro quotidianamente. Quegli ufficiali sono di origini finlandesi, ma hanno trascorso la loro esistenza in terra straniera. I miliziani non li odiano, nutrono per loro soltanto un indulgente disprezzo. I mesi passano.
È sera, e nevica. I fiocchi bianchi, accecanti e tristi rigano il cielo, formano una massa scura e silenziosa. Il suonatore dell’organetto di Barberia corre più veloce. La cinghia taglia la spalla curva, la scimmia si nasconde sotto un lembo della vecchia mantellina.
Il professor Krohn torna a casa; insegna matematica al collegio. È un uomo grande e grosso, con le spalle gettate all’indietro, il volto ornato da un’onda di barba bionda, ha gli occhi pallidi, sgranati sotto gli occhialetti. Porta una redingote fin dall’alba, è soddisfatto di se stesso e della vita. Stringe sotto il braccio la cartella piena di compiti in classe degli allievi. Incrocia davanti alla porta di casa sua le cugine della moglie, le due signorine Illmanen, che vivono nella stessa casa, sopra il suo alloggio. Christine e Minna Illmanen sono due creature lunghe e allampanate, pallide, fragili, trasparenti, angeliche, con le bende di lino, i cappellini neri con il sottogola, i mantelli dal collo triplo. Sono così alte che devono abbassare la testa per passare sotto il portico, così magre e così diafane che sembrano più delle ombre che delle donne viventi. Sono impacchettate in scialli, indumenti di lana, fisciù avvolti gli uni sugli altri, e che non irrobustiscono quasi per nulla i loro seni piatti. Scambiano con il professor Krohn un buongiorno sussurrato, appena percettibile, e passano. Le campane della sera suonano, il loro rintocco soffocato si perde nella neve. Il professor Krohn, ancora una volta, pensa meccanicamente: “Un tempo, erano delle belle ragazze, e che cosa sono diventate? Cagionevoli di salute…”.
Parlano poco, si imporporano appena sentono il suono della loro stessa voce. La più giovane, Minna, si tiene ancora diritta, mentre Christine comincia a incurvarsi. Ha il petto incavato; la spina dorsale, flessibile, fragile, si piega come un giunco. Un vago odore di medicine, di tintura di iodio, di tisane insipide, tenute perennemente a riscaldare a fuoco lento sulla lampada ad alcol, sembra aleggiare sulla loro scia. La loro giovinezza è passata, i loro anni più belli sono trascorsi in un
appartamento chiuso, al riparo dalla vita, che si allontana rapidamente da loro e non penetra attraverso le finestre doppie sigillate appena arriva l’inverno.
La violenza della neve raddoppia. Nei templi protestanti, in una stanzetta spoglia, illuminata crudamente ad acetilene, alcune vecchie signore cantano con le bocche sdentate i salmi del Signore, e sui cappellini neri corvini l’uva artificiale trema a tempo.
A tutte le finestre, dietro le tende di velluto, le lampade sono accese. Una vecchia lampada a petrolio brucia anche nel quartier generale della milizia, installata in uno degli antichi palazzi. Sulle poltrone di seta vengono strascicati gli stivali pesanti, ai ritratti sono stati bucati gli occhi. Di ora in ora, gli uomini che hanno terminato la ronda rientrano e altri si alzano.
Hjalmar, colpendo il pavimento con il calcio del fucile, cammina in lungo e in largo nella strada deserta. Non c’è niente da osservare, sembra. I due contadini passano, tenendo in mano le loro lanterne e sotto il braccio il pacco di manifesti rossi. Cominciano a incollarli sulla palizzata. Le loro barbe rade, gialle e ruvide come la stoppa, ondeggiano al vento.
Più tardi, la moglie del professor Krohn, Aïno, passa a sua volta. Sta tornando dal tempio, e stringe le due mani fredde nel suo manicotto. Si affretta in quel tratto di strada buia, illuminata dalla neve spessa. Un lampione che ha una luce rossastra in cima è piantato al centro di un ammasso di neve indurita, ogni fiocco di neve è attraversato dalla luce e si stacca in una serie di stelle distinte, fragili e perfette. Aïno sporge meccanicamente le labbra per assaggiare il loro sapore di fiamma e di gelo, le si sciolgono in bocca. Hjalmar la vede arrivare, fischia malinconicamente. Lei si avvicina e, nel chiarore torbido che cade su di loro, vede il suo volto. Vede i suoi capelli biondi, le lunghe guance pallide e scavate, gli occhi che hanno il colore dell’acqua e un’espressione addormentata e dolce. Ma scorgendo il soldato, Aïno rallenta il passo e a sua volta lo guarda. Lui inclina verso di lei il suo alto berretto, con la stella sopra. I denti bianchi brillano sul volto duro, ossuto, arrogante, ma che poco a poco si addolcisce in un sorriso. Aïno, suo malgrado, lo guarda senza abbassare gli occhi. Un leggero sorriso reticente incava delicatamente l’angolo delle sue labbra, e il lungo mento trasparente sussulta. Tacciono. Tuttavia, a un movimento incerto del soldato verso di lei, Aïno indietreggia, timorosa, e impallidisce. Come ha potuto, anche solo per un istante, fermarsi e sorridere a quel contadino, a quel cacciatore d’orsi? Si allontana in fretta, scappa, scompare nella notte. Lui sogghigna incollerito: «Borghesia, sciocca e prudente borghesia!».
La città dorme. Solo i miliziani, da un posto all’altro, montano la guardia, impassibili, silenziosi, innalzando i loro volti immobili e freddi.
A casa Krohn, i coniugi finiscono di mangiare nella piccola sala da pranzo angusta, sotto il globo di porcellana del lampadario. Poi Aïno sparecchia. Suo marito legge. Aïno sospira…


Iréne Némirovsky nata a Kiev nel 1903 da una famiglia di ricchi banchieri di origini ebraiche, visse a Parigi dove, appena diciottenne, cominciò a scrivere. Nel 1929 riuscì a farsi pubblicare il romanzo David Golder, ottenendo uno straordinario successo di critica e di pubblico. Irène continuò a scrivere, ma presto fu costretta a usare un altro nome, perché gli editori, nella Francia occupata dai tedeschi, avevano paura di pubblicare i libri di un’ebrea. Nel luglio del 1942 fu arrestata e deportata ad Auschwitz, dove ad agosto, a trentanove anni, morì, lasciando incompiuto il suo ultimo capolavoro, Suite francese. La Newton Compton ha pubblicato anche Due; Come le mosche d’autunno – Il ballo; Il vino della solitudine; I cani e i lupi; Il calore del sangue – Il malinteso; Jezabel; Il signore delle anime; David Golder; I fuochi dell’autunno, La preda e la raccolta I capolavori.
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso