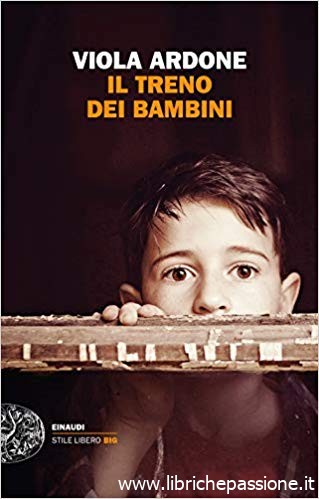
Trama
È il 1946 quando Amerigo lascia il suo rione di Napoli e sale su un treno. Assieme a migliaia di altri bambini meridionali attraverserà l’intera penisola e trascorrerà alcuni mesi in una famiglia del Nord; un’iniziativa del Partito comunista per strappare i piccoli alla miseria dopo l’ultimo conflitto. Con lo stupore dei suoi sette anni e il piglio furbo di un bambino dei vicoli, Amerigo ci mostra un’Italia che si rialza dalla guerra come se la vedessimo per la prima volta. E ci affida la storia commovente di una separazione. Quel dolore originario cui non ci si può sottrarre, perché non c’è altro modo per crescere.
«Un romanzo appassionante e scritto benissimo. La storia di questo bambino del dopoguerra, della sua lotta per la sopravvivenza e l’amore, tiene incollati alle pagine».
Marion Kohler, DVA-Penguin, Germania
«Originale, emotivo, di grande qualità letteraria. Un libro che tutti dovrebbero leggere».
Anne Michel, Albin Michel, Francia
«Uno splendido romanzo. Viola Ardone ci fa riflettere, con delicatezza e maestria, su come certe decisioni possano cambiare per sempre la nostra vita».
Elena Ramírez, Seix Barral, Spagna
Estratto
a Giaime
Parte prima
1946
1
Mia mamma avanti e io appresso. Per dentro ai vicoli dei Quartieri spagnoli mia mamma cammina veloce: ogni passo suo, due miei. Guardo le scarpe della gente. Scarpa sana: un punto; scarpa bucata: perdo un punto. Senza scarpe: zero punti. Scarpe nuove: stella premio. Io scarpe mie non ne ho avute mai, porto quelle degli altri e mi fanno sempre male. Mia mamma dice che cammino storto. Non è colpa mia. Sono le scarpe degli altri. Hanno la forma dei piedi che le hanno usate prima di me. Hanno pigliato le abitudini loro, hanno fatto altre strade, altri giochi. E quando arrivano a me, che ne sanno di come cammino io e di dove voglio andare? Si devono abituare mano mano, ma intanto il piede cresce, le scarpe si fanno piccole e stiamo punto e a capo.
Mia mamma avanti e io appresso. Dove stiamo andando non lo so, dice che è per il mio bene. Invece ci sta la fregatura sotto, come per i pidocchi. È per il tuo bene, e mi ritrovai con il mellone. Per fortuna che pure all’amico mio Tommasino gli fecero il mellone, per il suo bene. I compagni nostri del vicolo ci sfottevano, ci dicevano che parevamo due cape di morte uscite da dentro al Cimitero delle Fontanelle. Tommasino in principio non era amico mio. Una volta l’avevo visto che si fotteva una mela dal banco di Capajanca, il verdummaro che tiene il carretto a piazza Mercato, e allora ho pensato che non potevamo essere amici, perché mia mamma Antonietta mi ha spiegato che noi siamo poveri, sí, ma ladri no. Altrimenti diventiamo pezzenti. Però Tommasino mi ha visto e ha rubato una mela pure per me. Poiché la mela io non l’avevo rubata ma l’avevo avuta regalata, me la mangiai, infatti stavo con la fame agli occhi. Da quel momento siamo diventati amici. Amici di mele.
Mia mamma cammina in mezzo alla via senza guardare mai a terra. Io trascino i piedi e sommo i punti delle scarpe per far passare la paura. Conto sulle dita fino a dieci e poi ricomincio daccapo. Quando farò dieci volte dieci, succederà una cosa bella, cosí è il gioco. La cosa bella fino a mo non mi è mai capitata, forse perché ho contato male i punti. A me i numeri mi piacciono assai. Le lettere invece no: da sole le riconosco, ma quando si mischiano per fare le parole mi confondo. Dice mia mamma che io non devo crescere come lei, ed è per questo che mi ha mandato a scuola. Io ci sono andato, ma non mi sono trovato bene. Prima di tutto i compagni strillavano e me ne tornavo a casa con il male di capa, la stanza era piccola e puzzava di piedi sudati. Poi dovevo rimanere tutto il tempo fermo e zitto dietro a un banco a disegnare le asticelle. La maestra teneva la scucchia e parlava con la zeppola in bocca e a chi la sfotteva gli arrivava una scoppola sulla testa. Io in cinque giorni ne ho avute dieci. Me le sono contate sulle dita come i punti delle scarpe, ma non ho vinto niente. Cosí a scuola non ci sono voluto andare piú.
Mia mamma non era contenta, però ha detto che almeno mi dovevo imparare una fatica e cosí mi ha mandato a fare le pezze. All’inizio ero contento: si trattava di stare tutto il giorno in giro a raccogliere gli stracci vecchi casa per casa oppure da dentro alla monnezza e portarli al mercato da Capa ’e fierro. Dopo qualche giorno però mi ritiravo cosí stanco che mi rimpiangevo le scoppole della maestra con la scucchia.
Mia mamma si ferma davanti a un palazzo grigio e rosso, con le finestre grandi. – È qua, – dice. Questa scuola mi sembra piú bella di quella di prima. Dentro ci sta il silenzio e niente puzza di piedi. Saliamo al secondo piano e ci fanno aspettare in un corridoio sopra una panca di legno finché una voce non dice: il prossimo. Visto che nessuno si muove, mia mamma capisce che il prossimo siamo noi, e cosí entriamo.
Mia mamma si chiama Antonietta Speranza. La signorina che ci aspettava si segna il nome su un foglio e dice: – A voi vi è rimasta solo quella –. Io allora penso: ecco qua, mo mia mamma gira i tacchi e ce ne torniamo a casa. Invece no.
– Voi le date, le scoppole, maestra? – chiedo e mi copro la testa con le braccia, per sicurezza. La signorina ride e mi prende la guancia tra il pollice e l’indice, ma senza stringere. – Accomodatevi, – dice, e noi ci sediamo di fronte a lei.
La signorina non somiglia proprio a quell’altra, non tiene il mento in fuori ma un bel sorriso e tanti denti bianchi e dritti, i capelli tagliati corti, e porta i pantaloni, come i maschi. Noi restiamo zitti. Dice che si chiama Maddalena Criscuolo e che forse mia mamma se la ricorda, perché aveva combattuto per liberarci dall’oppressione dei nazisti. Mia mamma fa su e giú con la testa, ma si vede benissimo che lei questa Maddalena Criscuolo prima di mo non l’aveva mai sentita nominare. Maddalena racconta che in quelle giornate lei ha salvato il ponte del rione Sanità, perché i tedeschi lo volevano far saltare in aria con la dinamite e quindi alla fine le hanno dato una medaglia di bronzo e un attestato. Io penso che era meglio se le davano le scarpe nuove perché ne tiene una buona e una bucata (zero punti). Dice che abbiamo fatto bene ad andare da lei, che molta gente si vergogna, che lei e le compagne sue hanno dovuto bussare casa per casa e convincere le mamme che era una cosa buona, per loro e per i figli loro. Che hanno avuto molte porte in faccia e pure qualche malaparola. Io ci credo, perché anche a me, quando vado a chiedere le pezze usate, spesso mi dicono le maleparole appresso. La signorina dice che tante brave persone si sono fidate di loro, che mia mamma Antonietta è una donna coraggiosa e che a suo figlio gli sta facendo un regalo. Io di regali non ne ho avuti mai, tranne la scatola vecchia del cucito dove ci ho messo tutti i miei tesori.
Mia mamma Antonietta aspetta che questa Maddalena finisce di parlare, perché le chiacchiere non sono arte sua. Quella dice che ai bambini bisogna dargli un’opportunità. Io ero piú contento se mi dava pane, zucchero e ricotta. Me la mangiai una volta a una festa degli americani dove mi ero infilato con Tommasino (scarpe vecchie: perdo un punto).
Mia mamma resta zitta, perciò Maddalena continua a parlare: hanno organizzato dei treni speciali per portare i bambini là sopra. Allora mia mamma risponde: – Ma siete sicura? Questo qua, lo vedete?, è un castigo di dio! – Maddalena dice che ci metteranno a tanti di noi dentro al treno, mica solo a me. – Quindi non è una scuola! – capisco finalmente io, e sorrido. Mia mamma Antonietta non sorride. – Se tenevo scelta non stavo qua, questo è l’unico che tengo, vedete che dovete fare.
Quando ce ne andiamo, mia mamma cammina sempre avanti a me, ma piú piano. Passiamo per il banco delle pizze, dove ogni volta io mi attacco alla sua veste e non smetto di piangere fino a che non mi arriva un pacchero. Lei si ferma. – Cicoli e ricotta, – dice al giovine dietro al banco. – Una sola.
Io questa volta non ho chiesto niente e penso che, se mia mamma, di testa sua, mi vuole comprare la pizza fritta a metà mattinata, ci sta la fregatura sotto.
Il giovine incarta una pizza gialla come il sole e larga piú della mia faccia. Io la prendo con tutte e due le mani per paura di farla cadere. È calda e profumata, ci soffio sopra e l’odore dell’olio mi entra nel naso e nella bocca. Mia mamma si abbassa e mi guarda fisso. – Allora, hai sentito pure tu. Ormai sei grande, stai per compiere otto anni. La situazione nostra la sai.
Mi pulisce l’unto dalla faccia con il rovescio della mano. – Fammi assaggiare pure a me, – e con un pizzico se ne stacca un pezzo. Poi si alza e ci avviamo a casa. Non chiedo niente e mi incammino. Mia mamma avanti e io appresso.
2
Del fatto di Maddalena non si è parlato piú. Io ho pensato che forse mia mamma se l’era scordato o aveva cambiato idea. Invece poi qualche giorno dopo viene a casa nostra una suora, la manda padre Gennaro. Mia mamma spia da dietro i vetri: – E mo che vuole questa capa ’e pezza?
La suora bussa un’altra volta, cosí mia mamma posa il cucito e va ad aprire, ma giusto uno spiraglio, ché quella riesce a infilare nella porta solo la faccia, tutta ingiallita. La capa ’e pezza chiede se può entrare, mia mamma fa sí con la testa, ma si vede che non tiene proprio genio. La suora dice che mia mamma è una buona cristiana, che Dio vede tutti e ogni cosa e che le creature non appartengono né alle madri né ai padri, sono figlie di Dio. Quelle comuniste invece vogliono che partiamo col treno per andare in Russia, dove ci tagliano le mani e i piedi e non ci fanno tornare piú. Mia mamma non risponde. È molto brava a stare zitta. Cosí alla fine la capa ’e pezza si scoccia e se ne va. Io allora chiedo: – Ma tu veramente mi vuoi mandare in Russia? – Lei riprende il cucito e si mette a parlare da sola: – Ma quale Russia e Russia… Io non conosco né i fascisti né i comunisti. Non conosco nemmeno i preti e i vescovi –. Mia mamma con gli altri parla poco, ma da sola di piú. – Fino a mo ho conosciuto solamente fame e fatica… La vorrei vedere a quella capa ’e pezza, senza un uomo vicino e con un figlio… è facile parlare, quando figli non se ne tengono. Ma dove stava lei quando Luigino mio cadde malato?
Luigi era mio fratello maggiore e, se non aveva la cattiva idea di prendersi l’asma bronchiale da piccolo, mo teneva tre anni piú di me. Cosí, quando sono nato, ero già figlio unico. Mia mamma non lo nomina quasi mai, però tiene una foto sopra al comò con un lumino davanti. Il fatto me lo ha raccontato la Zandragliona, che abita nel basso di fronte al mio ed è una brava femmina. Mia mamma ci soffrí talmente che tutti pensavano che non si riprendeva. E invece poi nacqui io e lei è stata contenta. Anche se io non la faccio stare contenta come lui. Altrimenti a me mica mi mandava in Russia.
Esco di casa e vado nel basso della Zandragliona, che sa sempre tutto e, quello che non sa, se lo fa raccontare. Lei dice che non è vero che mi porteranno in Russia, che conosce Maddalena Criscuolo e le altre: loro ci vogliono aiutare, ci vogliono dare una speranza. Ma che me ne faccio io della speranza? Io la speranza la tengo già nel cognome, perché faccio Speranza pure io, come mia mamma Antonietta. Di nome invece faccio Amerigo. Il nome me l’ha dato mio padre. Io non l’ho mai conosciuto e, ogni volta che chiedo, mia mamma alza gli occhi al cielo come quando viene a piovere e lei non ha fatto in tempo a entrare i panni stesi. Dice che è proprio un grand’uomo. È partito per l’America per fare fortuna. Tornerà?, ho chiesto. Prima o poi, ha risposto. Non mi ha lasciato niente, solo il nome. Sempre qualcosa è.
Da quando si è saputo il fatto dei treni, dentro al vicolo abbiamo perso la pace. Ognuno dice una cosa diversa: chi sa che ci venderanno e ci manderanno all’America per faticare, chi dice che andremo in Russia e ci metteranno nei forni, chi ha sentito che partono solo le creature malamenti e quelle buone se le tengono le mamme, chi non se ne fotte proprio e continua come se niente fosse, perché è ignorante assai. Io pure sono ignorante, anche se dentro al vicolo mi chiamano Nobèl perché so un sacco di cose, nonostante che a scuola non ci sono piú voluto andare. Imparo in mezzo alla via: vado girando, sento le storie, mi faccio i fatti degli altri. Nessuno nasce imparato.
Mia mamma Antonietta non vuole che vado raccontando i fatti suoi. E io non lo dico mai a nessuno, che sotto al letto nostro ci stanno i pacchi di caffè di Capa ’e fierro. E manco che Capa ’e fierro il pomeriggio viene a casa nostra e si chiude dentro con mia mamma. Chissà alla moglie che le racconta, forse che va al biliardo. A me mi manda fuori, dice che devono faticare, lui e lei. Allora io esco e vado a cercare le pezze. Stracci, scarti, vestiti usati dei soldati americani, roba sporca e piena di pulci. All’inizio, quando veniva lui, io non me ne volevo andare: non ci potevo pensare che Capa ’e fierro veniva a fare il padrone in casa mia. Poi mia mamma ha detto che gli devo portare rispetto perché lui è uno che tiene amicizie importanti e perché ci dà a mangiare. Ha detto che con il commercio ci sa fare e che da lui tengo solo da imparare, che mi può fare da guida. Non ho risposto, ma da quel giorno ogni volta che arriva lui me ne esco io. Le pezze che raccolgo le porto a casa, mia mamma le deve pulire, strofinare, ricucire, cosí alla fine gliele diamo a Capa ’e fierro, che tiene il banco a piazza Mercato e riesce a venderle a quelli meno poveri di noi. Intanto guardo le scarpe e conto i punti sulle dita e quando farò dieci volte dieci succederà la cosa bella: mio padre ritornerà ricco dall’America e Capa ’e fierro lo chiuderò fuori, io a lui.
Una volta però il gioco veramente ha funzionato. Davanti al teatro San Carlo ho visto un signore con le scarpe talmente nuove e splendenti che facevano cento punti tutti insieme. E infatti, quando sono tornato a casa, Capa ’e fierro stava fuori la porta. Mia mamma aveva visto passare sua moglie al Rettifilo con una borsetta nuova sotto al braccio. Capa ’e fierro ha detto: – Devi imparare ad aspettare. Aspetta e viene pure il tuo momento –. Mia mamma ha risposto: – Oggi però aspetti tu, – e quel giorno in casa non l’ha fatto entrare. Capa ’e fierro è rimasto fuori al basso, si è acceso una sigaretta e si è incamminato con le mani in tasca. Io mi sono messo appresso a lui, solo per il gusto di vederlo amareggiato, e gli ho detto: – Oggi è festa, Capa ’e fierro? Non si fatica? – Lui si è accovacciato davanti a me, ha fatto un tiro dalla sigaretta e, quando ha cacciato fuori l’aria, dalla bocca sono usciti tanti piccoli cerchi di fumo. – Guagliò, – mi ha detto, – donne e vino sono la stessa cosa. O domini o ti fai dominare. Se ti fai dominare perdi i sensi, diventi schiavo, e io sono sempre stato un uomo libero e sempre lo sarò. Vieni, andiamocene all’osteria, oggi ti faccio bere il vino rosso. Oggi Capa ’e fierro ti fa diventare uomo!
– Che peccato, Capa ’e fierro, non vi posso accontentare, tengo che fare.
– E che tieni da fare, tu?
– Devo andare a fare le pezze, come al solito. Valgono quattro soldi ma ci dànno a mangiare. Permettete.
L’ho lasciato da solo, mentre gli anelli di fumo della sigaretta scomparivano nell’aria.
Le pezze che trovo le metto in una cesta che mi ha dato mia mamma. Dato che la cesta quando si riempie diventa pesante, io ho iniziato a portarla sopra alla testa, come ho visto fare alle femmine dentro al mercato. Ma poi, porta oggi e porta domani, mi sono caduti i capelli e sono rimasto col cocuzzolo pelato. E secondo me per questo mia mamma mi ha fatto fare il mellone, quali pidocchi!
Durante il giro delle pezze chiedo torno torno del fatto del treno, ma niente. Chi dice bianco, chi dice nero. Tommasino continua a ripetere che lui non deve partire perché a casa sua non gli manca niente e sua madre, donna Armida, non si è mai ridotta a chiedere la carità. La Pachiochia, che è la capa del vicolo nostro, dice che fino a quando ci stava il re certe cose non succedevano e le mamme i figli loro non se li vendevano. Dice che non c’è piú di-gni-tà! E, ogni volta che lo dice, fa vedere le gengive marroni, stringe quei pochi denti gialli che si ritrova e sputa dai buchi di quelli che non tiene piú. La Pachiochia è nata già brutta, credo io, e perciò un marito non ce l’ha mai avuto. Ma di questa cosa non si può parlare perché è il suo punto debole. E pure del fatto che non tiene figli. Una volta teneva un cardellino, ma se ne fuggí. Manco del cardellino si può parlare, con la Pachiochia.
Anche la Zandragliona è signurína. Non se ne è saputo mai il motivo. Chi dice che non si è decisa tra quelli che l’avevano chiesta e poi alla fine è rimasta sola, perché in realtà è ricca assai e non vuole dividere con nessuno i denari suoi. Chi dice che aveva tenuto un fidanzato ma le è morto. Chi dice che aveva tenuto un fidanzato ma si scoprí poi che era già sposato. Io dico che sono tutte malelingue.
Solamente una volta la Pachiochia e la Zandragliona si trovarono d’accordo: quando salirono i tedeschi fino a dentro al vicolo a prendersi la roba da mangiare e tutte e due gli nascosero le cacate dei palumbi dentro al casatiello, dicendo che erano cicoli di maiale, una specialità tipica della cucina nostra. Quelli se lo mangiarono dicendo gut, gut! mentre la Pachiochia e la Zandragliona si davano di gomito ridendo sotto ai baffi. I tedeschi non li vedemmo piú, nemmeno per farci una rappresaglia…






