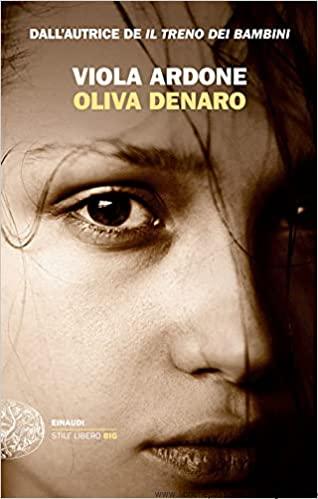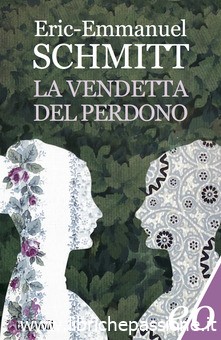Disponibile dal 10 Febbraio 2022


Questo romanzo narra una saga familiare che si svolge in un periodo di tempo che va dall’avvento del fascismo fino ai giorni nostri. È la storia di tre donne: nonna, madre e figlia, tutte non udenti. Rosa viene dal tempo antico e contadino. Impara una lingua simile a quel che vede e tocca: forte e sanguigna. Quella lingua è come una madre, se la porta con sé fino alla fine, e per essa si scontra col mondo civilizzato che non la capisce, e che lei non può comprendere. Da Rosa nasce Laura, che cresce nella grande città, conosce la lingua della gente, la governa, la padroneggia. Ma quella lingua che tutti parlano in realtà non le appartiene. Riconoscerlo è doloroso, richiede fatica, ci vuole coraggio. Una volta accettata la verità, sarà difficile tornare indietro. E da Laura nasce Francesca che è il prodotto dell’oggi. Parla la lingua di tutti, usa codici sofisticati, alterna tivi, evoluti. Ma Francesca sospetta che non bastino, lo capisce poco alla volta mentre l’ansia del mondo lentamente la assale. Il silenzio del mondo è un romanzo sulla diversità dell’essere sordi, sul linguaggio, sul dolore del comunicare. Un libro dove i gesti sostituiscono le parole, dove l’ascolto è qualcosa che va inventato nuovamente, ogni giorno. Ma è anche un romanzo che l’autore ha cucito per sé.
«È una storia che mi riguarda» ha scritto Tommaso Avati, «perché parla della sordità che io conosco per averla sperimentata sulla mia pelle fin dalla nascita. So cosa voglia dire non udire, vivere in un mondo ovattato e separato, distante e mai davvero raggiungibile dagli altri, persino dai tuoi cari». Ora questo mondo ovattato e separato, per certi versi irraggiungibile, è diventato un romanzo, tutto al femminile, pieno di poesia, sorprendente e di una spietata dolcezza.
«L’avrebbe ricordata per sempre, fino a che fosse vissuta: era sorda come lei ma aveva questo misterioso e favoloso potere, la capacità magica di tenere le parole tra le dita».

Il linguaggio è una pelle, e io sfrego il mio contro quello degli altri. È come se avessi parole a mo’ di dita o dita sulla punta delle parole.
Roland Barthes, Frammenti di un discorso amoroso
I segni, nella vita di Francesca, erano importanti. In qualunque modo si manifestassero, avevano sempre qualcosa di speciale da dirle. Il primo, quello che le avrebbe annunciato la direzione che stava per prendere la sua vita, si sarebbe presentato il giorno stesso in cui nacque, e avrebbe assunto la forma di uno sputo.
Francesca Del Re venne al mondo in una mattina tiepida di maggio del 1983 e rimase per un lungo momento in silenzio. Con quei suoi occhi azzurri enormi, meravigliosamente aperti, e un ciuffo di capelli ricci al centro della testa era bellissima, attentissima, ma non piangeva. Tutto il reparto ostetricia del San Giacomo si fermò per un istante a guardarla, l’infermiera che preparava le garze per il cordone diede una gomitata alla sua collega e si girarono tutti: quella neonata entrava nella vita con la stessa nonchalance di chi stesse facendo il suo ingresso in una sala da tè. Emetteva solo una specie di lamento, lento, pacato e misurato, che suonava piú come una litania che come un pianto, sembrava una melodia anonima, di quelle che si canticchiano distrattamente e pareva che non le uscisse dalla bocca, bensí dal naso. E non disse nemmeno una parola… Fu questo che pensò sua madre Laura mentre le mettevano in grembo la piccola. Pensò al titolo di quel libro di Heinrich Böll che anni prima aveva portato in dono al suo migliore amico. Pensò a quello che poteva aver significato quel libro per lui, in quel momento cosí peculiare della sua vita. E per sua figlia? Cosa avrebbe significato? E non disse nemmeno una parola… Sarebbe stata perfettamente sana come il padre, o completamente sorda come lei e come sua madre?
«Ci sente?» chiese con un filo di voce a una infermiera che prendeva la neonata per pulirla.
«A noi sembra di sí, risponde agli stimoli».
Quando l’infermiera portò la neonata all’esterno per mostrarla ai parenti, la vecchia nonna Rosa riuscí ad appropriarsene ancora prima di papà Domenico che continuava a chiedere: «È sorda?», e non lo domandava alle infermiere né all’ostetrica che era appena uscita dalla sala parto, lo chiedeva a quella specie di sciamano di sua suocera, usando la lingua dei segni. Ma la vecchia Rosa era distratta, continuava a tenere stretta la piccola, la guardava, la scrutava, come se ora esistesse solo lei al mondo. Intanto avevano fatto uscire anche la madre che era stravolta, riusciva appena a tenere gli occhi aperti, la spingevano verso la sua stanza e anche lei voleva conferme che la bambina sentisse.
«Secondo noi ci sente benissimo» insisteva l’ostetrica. E fu allora che l’anziana si girò, diede le spalle a tutti per non farsi vedere, tirò fuori la lingua e sputò un sostanzioso proiettile di saliva brillante proprio sul volto della neonata. Poi la mise contro luce ammirandola come se si fosse trattato di una grossa pietra preziosa e finalmente capí. Alzò gli occhi verso la dottoressa e, anche se non aveva potuto udirla perché era sorda come una campana, immaginava benissimo quel che aveva appena detto. La fissò con uno sguardo che racchiudeva una vita intera e quello sguardo diceva: “Bella mia, credi di saperne piú di me solo perché hai un camice bianco? Lo sai da dove vengo io? Lo sai che al nostro paese ci siamo inventati una lingua che tu non impareresti nemmeno in un milione di anni? Una lingua complicata, speciale, capace quasi di farti vedere le cose, tutte, anche quelle che non si vedono. Chi ti credi di essere allora con quella tua aria da saputella? Dici che la bambina ci sente? E credi che basti fare un esame medico per poter stabilire se un bambino è sordo o se lo diventerà? Ci vuole ben altro per riconoscere un sordo. Ci vuole un sordo per riconoscerne un altro».
Questo le avrebbe detto la nonna se solo avesse saputo parlare. Perché i suoi occhi avevano visto, e lei ora non aveva dubbi. Francesca sarebbe stata sorda, non sapeva quando, forse non oggi né domani o tra un anno, ma sarebbe successo. Avevano un bel dire tutte le ostetriche e i medici che la bambina aveva tutte le carte in regola. Francesca Del Re sarebbe stata sorda, eccome. «È sorda, è sorda!» continuava a esclamare in segni la vecchia sperando che la capissero tutti e soprattutto il genero. Quella donna ne aveva subite tante da parte degli udenti che avere una nipote sorda – ora – le sembrava una specie di riscatto o di vendetta, le dava insomma una gioia immensa. E saltellava, allora, danzava come una sciamana, eccitandosi a tal punto che per un attimo, quasi, la neonata non le cadde in terra.
Rosa
1.
Quando si sedeva a tavola, Pietro Innocenti faceva sempre il segno della croce. Ma lo faceva un attimo dopo aver cominciato a mangiare, dopo aver messo in bocca la prima cucchiaiata di minestra, come se prima di ringraziare l’Altissimo volesse in qualche modo sincerarsi della bontà della pietanza. Assaggiava il cibo, masticava, ingoiava e poi – mai davvero persuaso fino in fondo – si decideva a segnarsi. A volte, per la quantità piú che per la qualità, il cibo lo indisponeva al punto tale che, dopo essersi segnato e aver terminato il pasto, infiocchettava il tutto con una sonora e franca bestemmia.
Viveva insieme a sua moglie Lina in una casa tipica di mezzadri, di proprietà di don Marrani che era anche padrone della terra che lavoravano. Insieme a loro c’era Martino, fratello minore di Pietro e reduce della Grande Guerra, divenuto cieco in seguito a una infezione contratta in campo di prigionia a Meschede. La loro era l’ultima casa prima del bosco, lunga e stretta, con una terrazza in cima alle scale dove a volte cenavano nei mesi caldi. La cucina, dove si svolgeva la maggior parte della vita domestica, era grande, con due porte sul retro che davano sull’aia. Di sopra c’erano due camere, una per i due coniugi, e una per Martino. In una stanza al piano terra mettevano il grano e allevavano i bachi da seta. Accanto alla casa avevano una specie di stalla in cui poltrivano due bestie da soma che, in regime di convivenza, facevano compagnia a una dozzina di pecore. Sempre lí Pietro e Lina tenevano gli attrezzi da lavoro, le zappe e le vanghe, mentre nello stalletto avevano una decina di galline con due maiali e nel fienile le foglie di pioppo per le pecore. Nel campo coltivavano soprattutto il grano, e nel piccolo orto, accanto a cui transitava un ruscello, crescevano pomodori, lattughe, misticanza e a volte cavoli e peperoni. L’acqua per annaffiare proveniva dal torrente e quella da bere la prendevano alla fonte, a un miglio di distanza giú per la discesa. C’era sempre moltissimo lavoro e Pietro non poteva contare sull’aiuto del fratello cieco che sapeva fare solo il tessitore, né su quello della moglie che era filatrice e che, soprattutto, in quegli anni era sempre incinta.
Lei, il segno della croce, lo faceva prima di sedersi, e per tante volte quanti erano i bambini che le erano morti. Il gesto sacro, per Lina, non rappresentava tanto un ringraziamento per il (poco) cibo quotidiano, quanto un pensiero rivolto ai figli deceduti subito dopo la nascita. Il cuore dei loro bambini si stancava di battere sempre dopo pochi giorni dalla nascita: bastava loro il tempo per guardarsi attorno, rendersi conto di dove erano capitati e della miseria che li circondava per farsi un’idea del tipo di vita che li attendeva e decidere quindi di togliere le tende in gran volata. Che morissero, a ben vedere, era anche una fortuna: un figlio significava una bocca in piú da sfamare, ma un figlio, soprattutto maschio, aveva anche braccia che sarebbero cresciute, diventate forti, e che avrebbero potuto lavorare sui campi. A ogni modo quel figlio non arrivava, o meglio, arrivava e se ne andava, e allora si continuava a provarci, e cosa avrebbero dovuto fare? Ci si sposava per quello, per fare l’amore che significava fare figli e se non arrivavano ci si provava ancora e se morivano si seppellivano, spesso senza nemmeno un funerale, e poi si tornava a provarci.
Ora, tanto per cambiare, Lina Innocenti era di nuovo incinta, quasi al termine ormai. E come sarebbe andata questa volta? Erano questi i pensieri che le attraversavano la mente dopo aver fatto ripetutamente il segno di croce ed essersi seduta a tavola riempendo con minestra di patate e cavolo il piatto di Pietro e quello di Martino. Del suo si occupava per ultimo. Nonostante necessitasse legittimamente di nutrimento in quantità, i due uomini avevano comunque la precedenza: il marito era praticamente l’unico a lavorare, si spezzava la schiena su quel campo dalla mattina alla sera e quando arrivava l’ora di cena il suo stomaco reclamava rabbiosamente la grandissima parte dei viveri che riuscivano a mettere a tavola. Martino invece non era mai riuscito a placare davvero e definitivamente l’appetito: dopo aver passato diversi mesi in una condizione di indigenza difficilmente immaginabile come quella di recluso in un campo di prigionia tedesco, e dopo aver insomma conosciuto la fame vera, quella che ti spinge a nutrirti del legno della branda su cui dormi e della calce che tiene insieme i mattoni della baracca in cui sei prigioniero, non era mai riuscito – nemmeno dopo anni – a sedare la fame. Ne aveva patita talmente tanta che ora ce l’aveva cronica. E quindi prima c’erano loro, suo marito e suo cognato, e quel che rimaneva, insieme forse a un pezzetto di formaggio e a qualche carota, se lo mangiava lei.
Martino Innocenti il segno della croce non lo faceva proprio. Lui di solito si gettava sul cibo subito dopo essersi seduto e senza avvertire bisogni spirituali di sorta. D’altra parte era cieco, quindi non aveva un lavoro, quindi non aveva un soldo, quindi era costretto a vivere a casa del fratello, quindi non aveva una donna e quindi era talmente incazzato col mondo visibile (che peraltro lui non poteva vedere) da esserlo, per la proprietà transitiva, anche con quello invisibile e ripudiare ogni forma di credenza religiosa scegliendo la via agnostica. In quel periodo poi, come se non bastasse, era ancora piú afflitto. Il destino infatti aveva deciso di giocargli un altro brutto tiro.
«Due calzini…» continuava a borbottare incomprensibilmente senza smettere di mangiare. Pietro e Lina si guardarono, perché quando Martino parlava non si capiva mai bene a chi si riferisse. Ma spesso nemmeno a cosa si riferisse. Dov’erano quei due calzini? Nel piatto in cui stava mangiando? Nella sua fantasia? Ripresero a succhiare la minestra, come se le parole pronunciate dal fratello non fossero state altro che il principio di una barzelletta abortita.
«Due calzini!» ripeté il cieco, questa volta alzando il capo.
«Ma dove sono?» chiese Lina.
«Nello stanzino, li ho sentiti» rispose lui, ma ancora non si capiva cosa ci fosse di cosí interessante in quel paio di calze.
«Li ho finiti ieri, e allora?» confermò sua cognata.
«Ma per chi sono?».
«Caccetta».
«Il fabbro?».
«Lui».
«E che ci dà in cambio?».
«Olio e sale».
«E quanto ce ne dà?».
«Una bottiglia e un chilo».
A quella notizia Martino si portò le mani alla faccia scuotendo la testa.
«Ti servono dei calzini?» gli chiese ora suo fratello. Aveva approfittato che Martino togliesse momentaneamente la mano dal suo pane per sottrarglielo, staccarne furtivamente due pezzetti e rimetterlo a posto.
«Mi servono i soldi. Pensavo che potevamo venderli quei calzini».
Ci si stava avvicinando alla scadenza del pagamento della tassa che il governo fascista aveva appena imposto e che sembrava ritagliata attorno a Martino Innocenti. Gli uomini tra i venticinque e i trentacinque anni che non fossero ancora sposati erano costretti a versare allo Stato settanta lire che sarebbero poi diventate cento tra i trentacinque e i cinquant’anni. Martino ne aveva ancora trentaquattro di anni, ma quelle settanta lire non sapeva proprio dove andarle a pescare.
«Mi servono quei soldi» ribadí mentre una densa perturbazione attraversava i suoi occhi già sufficientemente obnubilati.
«A noi però serve il sale» eccepí il fratello.
«E anche l’olio» aggiunse la cognata.
«E allora devo andare in galera? Devo farmi arrestare cosí voi avete l’olio e il sale?».
«Ma non ti arrestano…» lo rassicurava Pietro. Il contadino nutriva grande fiducia verso il governo fascista. Aveva anche acquistato la tessera del partito solo per poter avere la camicia nera e indossarla ogni tanto sui pantaloni di canapa e sugli zoccoli quando andava in piazza o a messa la domenica.
«Se uno spiega che hai questo problema, che non ci vedi, e che quindi non hai una casa, quindi non hai soldi, quindi non è facile trovarti una donna, il Duce lo capisce».
«Ah ah ah!» rise rabbiosamente Martino. «Io sono cieco ma tu sei scemo!».
«Va bene, io sono scemo… come fanno a sapere se hai pagato o no? Dimmelo. Ti vengono a cercare?».
«A Livio lo sono venuti a cercare per meno» disse il fratello.
«Che aveva fatto?» chiese Lina.
«Non era andato al raduno, ecco
che aveva fatto».
«Troveremo una soluzione». Pietro era il maggiore dei due e non si perdeva mai d’animo.
«Parli facile tu» gli rispose Martino, che l’animo, insieme a un paio di cornee, li aveva persi al fronte.
Pietro sembrò pensarci su per un istante, poi:
«Che fine ha fatto la figlia di Anna?» chiese a sua moglie.
Lei lo guardò in modo severo.
«Che fine ha fatto?» insistette.
«Ma chi, la ricamatrice?» chiese lei.
«Sí, la ricamatrice».
«Sta sempre con la madre».
«Ma è ancora vedova?».
«Lui non è certo risorto».
«E non potrebbe andare bene?» propose Pietro abbassando la voce.
«Per lui?» chiese Lina guardandolo di sottecchi.
«Per lui, sí».
Lina ci pensò su un attimo, guardò suo cognato con l’aria di chi osservi qualcuno per la prima volta in vita sua, poi, improvvisamente, scosse energicamente il capo.
«Potrebbe andare bene o no?» gridò Martino che non la poteva vedere.
«Ho detto di no!» gridò a sua volta Lina.
«Guarda che sono cieco mica sordo».
«E manco io!» rispose lei.
«Perché non va bene?» chiese Pietro alla moglie.
«Non va bene perché porta ancora il lutto e non ha nessuna voglia di sposarsi un’altra volta!».
«Con un cieco…» aggiunse vittimisticamente Martino.
«Con chiunque» rettificò lei.
«Figurarsi un cieco» ribadiva Martino.
«Comunque non va bene» si inseriva Pietro.
«Ma comunque com’è…?» insisteva il fratello, che gli erano bastati pochi secondi a parlare di una sconosciuta per farci già la bocca. Coi suoi trentaquattro anni suonati non aveva mai avuto grandi esperienze con l’altro sesso e spesso gli bastava pensare a una femmina, ma anche meno, gli era sufficiente che qualcuno parlasse di una donna qualsiasi per iniziare ad avvertire quell’improvviso e impetuoso rigonfiamento tra le gambe. Quando accadeva a tavola, almeno, non lo poteva vedere nessuno.


Tommaso Avati si è sempre diviso tra cinema e letteratura. Nel 2014 ha vinto il Montreal World Film Festival per la miglior sceneggiatura per Il ragazzo d’oro. Nel 2020 ha vinto il Nastro d’argento al miglior soggetto per il film Il signor Diavolo. Ha scritto due romanzi, Ogni città ha le sue nuvole (2017) e Quasi tre (2018). Vive a Roma.
Per preordinare e acquistare il libro cliccate sul link in basso