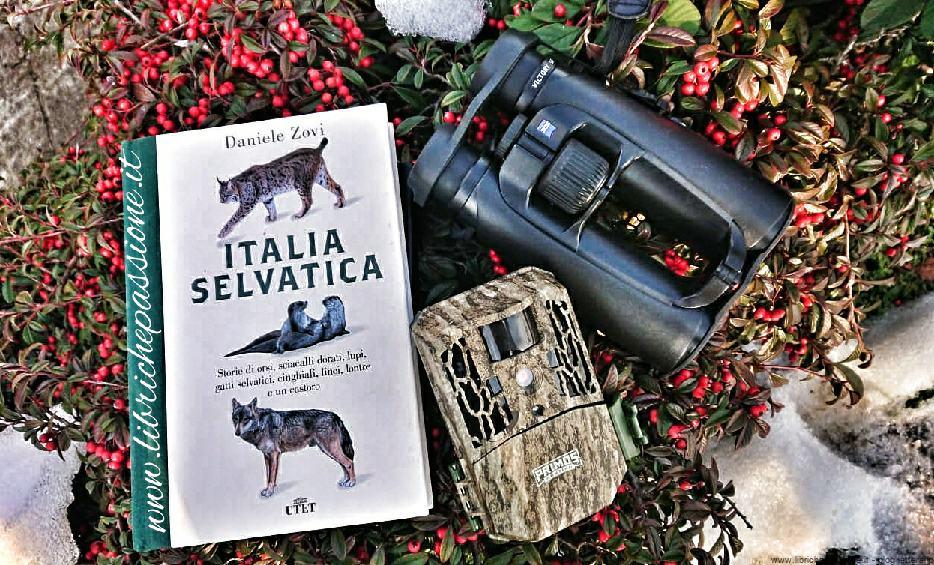Il rumore del mondo
Autrice: Benedetta Cibrario
Casa editrice Mondadori – data di pubblicazione 2 Ottobre 2018
Trama
FINALISTA PREMIO STREGA 2019
L’ufficiale piemontese Prospero Carlo Carando di Vignon, di stanza a Londra, sposa Anne Bacon, figlia di un ricco mercante di seta. Quando, dopo essere stata vittima del vaiolo, arriva a Torino, Anne è molto diversa.
La vita coniugale si annuncia come un piccolo inferno domestico, ma il suocero Casimiro la invita a occuparsi della proprietà del Mandrone, il cui futuro soltanto a lui – conservatore di ferro – sembra stare a cuore. Tra i due si stabilisce un’imprevedibile complicità e Anne matura amore e dedizione per la vita appartata e operosa che vi conduce. La storia della famiglia Vignon si intreccia ai fili dello spirito del tempo, e non di meno a quelli della seta.
Anne Bacon scopre come conquistarsi un posto nella storia di un paese non ancora nato, di un orizzonte ideale che infiamma il mondo. Progressisti e conservatori, al di là degli schieramenti politici, si trovano davanti alla necessità di rispondere al cambiamento e lo fanno agendo – nell’economia, nel costume, nella morale, nella cultura. E l’Italia appare, vista da lontano (complici anime migranti come Anne, e il suo entourage femminile), vista come utopia e come sfida.
Estratto
A mia madre e a Paolo
Penso di poter dire che la vita italiana piace moltissimo a tutti noi.
CHARLES DICKENS a THOMAS MINTON, 12 agosto 1844
Parte prima
IL MONDO INGLESE
1
Normandia, estate 1838
Alle prime luci dell’alba le campagne intorno a Rouen, dopo una settimana di pioggia, avevano una lucentezza di smalto. Anne Bacon strofinava i piedi l’uno contro l’altro, tentando di scaldare le dita gelate. Aveva brividi in tutto il corpo e le labbra secche. Avrebbe bevuto volentieri un po’ d’acqua, ma si sentiva troppo debole per sollevarsi dal letto. Provò a girarsi sul fianco. Se Eliza non era ancora arrivata con una tazza di tè, doveva essere ancora molto presto.
Erano stati i brividi a svegliarla. Per riprendere sonno, la cosa migliore era concentrarsi su un pensiero semplice, cucire un’asola oppure lucidarsi le unghie finché non brillavano come bottoni di madreperla; invece si sentiva incapace di fermare l’assalto delle immagini che arrivavano a ondate, terre emerse alla superficie della coscienza e subito inabissate di nuovo, per lasciare il posto ad altre immagini e altri suoni.
La stanchezza era il lato peggiore. Non aveva più forze. Devo dormire, pensò. Provò a immaginare di avere tra due dita il capo di un filo e un ago sottilissimo di cui faticava a vedere la cruna.
Parlavano tutti a bassa voce. Si muovevano per la stanza cercando di non fare rumore. Camminavano a passi leggeri, sbirciavano dalla porta socchiusa. Un uomo le aveva slacciato la camicia e tastato il collo. Un’altra figura – una donna – le aveva sollevato la testa per metterle in bocca una cannuccia, ma aveva spinto troppo e le aveva ferito il palato. Sentiva ancora fastidio. Mosse la lingua e sentì altre lacerazioni. Quando la donna aveva estratto la cannuccia, un rivolo era colato dalla bocca e qualche goccia tiepida era scivolata attraverso il mento, lungo il collo. Le aveva bagnato la camicia e il guanciale.
Socchiuse gli occhi. Non c’era più nessuno. L’avevano lasciata sola. Dov’era Eliza? Dov’erano tutti? Soltanto chiudendo gli occhi riusciva a vederli. Miss Jenkins che legge un libro a voce alta, nel salotto inondato di luce. Eliza che apparecchia il tavolino da tè davanti alla finestra. Suo padre le appoggia le mani sulle spalle: «Ora facciamo un gioco, Anne».
Le benda gli occhi e rovista in un cesto pieno di scampoli.
«Dimmi cos’è» la sfida, mettendole in mano un lembo di stoffa.
Lei non vuole deluderlo. Le stoffe hanno nomi difficili da ricordare. Lampasso, broccato, mussola bengalese. Da quando le associa a una sensazione, è più facile. La mussola è una farfalla: stessa leggerezza, stessa trasparenza. L’organza è fragile e rigida al tempo stesso: un tulipano. Rara, anche, come i tulipani che fioriscono per sole tre settimane. Lei indovina e lo sente contento. La soddisfazione di suo padre la riempie di orgoglio.
Colori. Stoffe. Voci.
«Di certo sarebbe un peccato se due ragazze belle come le vostre non spiccassero il volo» ha detto Miss Jenkins, «non si può mai dire dove potrebbero arrivare», e suo padre ha annuito. Ventimila sterline all’anno di rendita negli ultimi cinque anni, con cui ha acquistato Bounds Green. Ci vanno in primavera, da Harley Street sono due ore e mezzo di carrozza. La strada è pianeggiante, in leggera salita. Attraversa campi e brughiere, costeggia un lago fangoso in cui i ragazzi si tuffano nelle giornate di sole, restando a pochi metri dalla riva. Nell’ultimo miglio la strada s’inerpica tra sponde di erica e rovi, fa un paio di curve morbide e sbuca in una radura punteggiata di querce. Da lassù si vede Londra in lontananza, i campanili delle chiese si riconoscono con facilità. Uno dei suoi passatempi preferiti, nelle giornate di bel tempo, è contarli. Il numero non è mai lo stesso. Lei e Grace aguzzano la vista ma ce n’è sempre qualcuno che sfugge alla conta, nascosto da una nuvola passeggera.
La casa non è grande, una costruzione a due piani con l’ingresso sormontato da un timpano. Avrebbe bisogno di qualche miglioria, ma il bosco è magnifico, pieno di selvaggina. La proprietà comprende anche terreni da pascolo, due mulini ad acqua dati in affitto e la palude che adesso fluttua verso di lei. Bagliori di verde e blu intenso, l’odore della marcita, un intrico di canne e ciuffi di crochi sparsi lungo gli argini fradici. Nei giorni di sole e di vento le nuvole corrono da una sponda all’altra, s’infilano tra le erbe acquatiche e spariscono inghiottite dalle rive. L’inquieto cielo anglosassone è un frutto maturo nascosto tra i cespugli. Deve dirlo a Margaret. Deve dirlo a suo padre. Una stoffa che avesse un colore simile al cielo riflesso nell’acqua andrebbe a ruba. Piccole squame d’oro e d’argento su un fondo blu. Pennellate più chiare, qualche tocco di verde e di azzurro. Un motivo capace di catturare il movimento e fissarlo nella trama di un tessuto.
Mentre Anne oscillava tra il sonno e la veglia, fuori dalla finestra al primo piano della locanda del Vieux Pommier la campagna sembrava percorsa da uno spirito d’impazienza. Tanto l’aria finalmente tersa quanto il cielo sgombro di nuvole lasciavano immaginare che sarebbe stata la prima giornata veramente calda della stagione. Le siepi di biancospino lungo la strada erano prese d’assalto dalle farfalle e la rosa banksiae contro il muro di cinta si era spogliata dei fiori, lasciando per terra manciate di petali gialli.
Ogni cosa – pascoli, frutteti, mulini ad acqua, boschi e torrenti, i tetti di ardesia che asciugavano al sole – era lustra e splendente, pronta per il ritorno di una divinità pagana mai veramente spodestata; tuttavia, di questa esplosione di vitalità di cui la campagna dava prova Anne non aveva la minima consapevolezza, confinata a letto dopo essere svenuta sull’impiantito del Vieux Pommier, appena scesa di carrozza. Eliza Backway, la cameriera, e la sua compagna di viaggio, Theresa Manners, avevano convinto il proprietario della locanda a sistemarla in una camera e a mandare subito a chiamare il medico del paese. Il dottor Réglat aveva dato la sua diagnosi: vaiolo. «Possiamo soltanto aspettare» aveva detto.
Eliza si era sistemata sulla panca e aveva tirato fuori dalla tasca un fazzoletto di batista con un ago appuntato. Sentendo il sole scaldarle le braccia e il viso, si era spostata più all’ombra. Una corta striscia di giardino la separava dalla strada deserta, percorsa soltanto da un cane svogliato, incerto se accucciarsi o andarsene; come tutti qui attorno, pensò lei di malumore. Piccole inquietudini le attraversavano la mente. Dopo l’annuncio del dottor Réglat c’era stato un impaurito fuggi fuggi e la locanda si era svuotata. I tre locali al pianterreno erano bui e inospitali, con tavoli addossati alle pareti e lunghe panche di quercia grezza. Grosse macchie di umidità chiazzavano l’intonaco. In poche settimane di sole, l’estate normanna avrebbe asciugato muri e pavimenti.
Eliza sfilò l’ago dal tessuto e cominciò a orlare il fazzoletto, arrotolando la stoffa tra le dita. Cucì assorta per un po’, poi si fermò per controllare il lavoro. Punti appena visibili, regolari. Se si fosse messa d’impegno, lo avrebbe finito per l’ora di pranzo. Diede ancora un paio di punti e poi si interruppe per guardarsi attorno. La fioritura dei tigli e il verde lucente dei pascoli suggerivano che ovunque, nell’universo, si stava celebrando un risveglio. Al piano di sopra, la padrona lottava contro la morte. Il pensiero continuava a impigliarsi nell’immagine di Anne scivolata a terra, il viso bagnato di sudore e le guance rosse. C’era una mostruosa bizzarria nel destino, rifletté, un capriccio: la natura non è semplicemente indifferente alle sventure degli uomini, se ne fa beffe.
Con l’espressione contratta riavvolse il fazzoletto intorno all’ago e se lo rimise in tasca. Dall’interno della locanda non arrivava più alcun rumore.
L’attesa era silenzio. Il silenzio, attesa.
I suoni che provenivano da fuori – uno scampanio, il chiasso degli storni che avevano colonizzato il grande faggio davanti alla finestra – svegliarono Anne gradualmente. Sollevò la testa aprendo appena gli occhi, nel timore che la luce del giorno, pur attenuata dalle tende, fosse troppo vivida. Sulla parete davanti al letto qualcuno aveva appeso un drappo ricamato. Melagrane – due o tre già spaccate dall’esuberanza dei chicchi –, rose selvatiche e foglie: il drappo era di seta finissima color perla, intessuta di fili d’oro.
Sentì una fitta di mal di testa e richiuse gli occhi. Avrebbe voluto guardare ancora il ricamo, ma non riusciva a sopportare la luce. Sembrava uno scampolo di seta iridescente, ora più luminoso, ora più tenue.
Pensò che non appena si fosse sentita meglio si sarebbe alzata e sarebbe andata a dargli un’occhiata da vicino. Se la seta era della stessa qualità del ricamo, si trattava certamente di una delle stoffe più pregiate dell’assortimento. Seta tessuta a Spitalfields o a Lione. Di prima scelta, senza dubbio: il colore cangiante, la lucentezza, non lasciavano dubbi. Era certamente un disegno di Margaret. Doveva trattarsi di una delle sete più costose ricamate dalle lavoranti di suo padre.
La testa le scoppiava, ma pensò con sollievo che non era più il dolore insopportabile, incessante, di prima. Adesso, per quanto lancinanti, erano soltanto fitte. Per quanto tempo aveva dormito? Tra le ciglia continuava a vedere il ricamo intessuto di fili d’oro, ma ora sembrava un disegno diverso, non più rose selvatiche e melagrane ma una rete da pesca in cui si dibatteva, con guizzi simili al fremere delle foglie, una manciata di pesci.
Ogni più piccolo movimento le costava fatica. Le facevano male anche le dita, intorpidite dalla fasciatura di garza che le avvolgeva le mani.
Perché Eliza non veniva a vedere come stava? Aspettò ancora. Di solito entrava senza bussare e scostava le tende con un gesto rapido. «Ora di alzarsi, Anne» diceva, «la città è già sveglia.»
«Alzarsi? È ancora notte lì fuori. Mi bastano dieci minuti. Solo dieci minuti, poi mi alzo e farò tutto di corsa.»
Nel dormiveglia la sentiva muoversi per la stanza, brusca e precisa. Spostava uno sgabello o apriva le ante dell’armadio. Non faceva troppo rumore, ma neppure si sforzava di essere davvero silenziosa. Quell’andirivieni avrebbe potuto senz’altro essere rimandato, pensava Anne. Il silenzio imperfetto in cui Eliza la lasciava dormicchiare significava che non cedeva senza condizioni alle sue richieste.
Era stupefacente ascoltare, con la testa tuffata nel cuscino, quante cose riuscisse a fare: sbatacchiava la brocca piena d’acqua, la versava nel catino, portava via il vaso da notte, apriva il cassettone per prendere la biancheria pulita, e ognuno di quei gesti era sottolineato dal fruscio della gonna sul pavimento e da uno sgocciolio di parole sussurrate, «questo è a posto», «ecco fatto», «bene così». Finalmente la porta si apriva e si richiudeva un’ultima volta e Anne si godeva il silenzio appena conquistato. A breve Eliza sarebbe tornata e non le avrebbe concesso altro tempo: la gonna e il corpetto erano già posati sul piccolo sofà, insieme alla camicetta, alle sottogonne e alle calze. Avrebbe dovuto abbandonare la tana morbida e calda che aveva scavato nel materasso, senza osare allungarsi a sfiorare le lenzuola fredde.
Sarebbero stati freddi anche il pavimento e le mani di Eliza che le tiravano i lacci del corsetto. Meglio restare immobile fino all’ultimo secondo e poi strofinare i piedi con furia, per riscaldarsi. Dal letto riusciva a vedere la finestra, un rettangolo opalescente, via via più intenso. Con la luce, aumentavano d’intensità anche le voci. Londra si sveglia tutta insieme, pensava, mentre si addormenta poco per volta, un quartiere dopo l’altro. Non esiste un posto più sicuro, vivace e misterioso della grande città in cui vive. Che bellezza avere davanti una lunga giornata piena zeppa di cose da fare. Una ricca colazione a base di tè, panini al burro, pancetta e uova, prosciutto, cetrioli sottaceto; una passeggiata al parco, a piedi o in calesse, lezioni di francese e disegno, qualche visita, la scelta di un nuovo cappello da pomeriggio.
«Fortunati quelli che si svegliano sempre di buonumore» diceva Eliza quando rientrava con il vassoio del tè e la trovava sprofondata tra i cuscini, lo sguardo allegro. Intendeva: le ragazze giovani e ricche, con il cervello pieno di cianfrusaglie come il suo cestino da cucito. Mozziconi di nastri, bottoni spaiati, un mucchietto di ganci e di spilli.
Chiamò Eliza per avere un po’ d’acqua, due, tre volte, ma non ebbe risposta. Si sentiva ancora molto debole, anche se meno dei giorni precedenti. La danza dei pesci sembrò fermarsi per poi riprendere con rinnovato vigore. Voleva assolutamente guardare da vicino quel drappo ricamato. Era compito di William controllare le pezze che arrivavano in magazzino. Capitava spesso che stoffe all’apparenza perfette una volta srotolate rivelassero fallature o strappi e andassero restituite al mittente o tagliate in scampoli. William sceglieva i migliori e li appendeva con due pinze alle pareti divisorie del magazzino. In un batter d’occhio il legno verniciato si rivestiva degli stessi colori incantevoli – giallo paglierino, verde brillante, rosa fucsia – degli abiti eleganti delle signore che affollavano il negozio. Possibile che fosse stato William ad appendere il drappo? Le sembrava vagamente di sapere che non era possibile, che William – e non solo lui, ma anche il magazzino con il suo odore di polvere, umidità e spezie esotiche; le strade sudicie di Spitalfields o il bancone di mogano tirato a specchio su cui Mr Davis o Mr Shannon stendevano e tagliavano le stoffe – era altrove, in un luogo ormai lontanissimo da lei; una distanza più interiore che geografica.
Le pulsavano le tempie. Si domandò, con la lucida concretezza della gioventù, se stesse per svenire. Aveva sentito dire che certe febbri rimescolano il cervello e trasformano individui perfettamente sani in creature dementi. Non si era mai sentita così debole: e se quei pensieri senza un filo logico fossero stati una specie di delirio? Magari era arrivata a quello che Miss Jenkins chiamava “l’orlo del precipizio”. Possibile che non sapesse come ci era arrivata? La gente moriva di continuo. Non soltanto i soldati o i manovali, i marinai e tutti quelli che facevano mestieri pericolosi. Morivano le madri, i garzoni, i bambini, le sguattere. Ne morivano ogni giorno, in ogni casa, in ogni quartiere, nelle campagne e nei villaggi. E, nonostante la morte fosse così frequente, non aveva mai visto morire nessuno in vita sua. Cani, gatti, volpi, istrici, sì, naturalmente, ma era diverso.
Non aveva idea di cosa aspettarsi.
Sua madre, la piccola e affannata figlia di un chirurgo di Devonshire Street, era morta di polmonite. Una sera, tornando da teatro, aveva cominciato a tossire. In due giorni si era aggravata e i salassi erano stati inutili. Era morta alle tre del mattino, mentre lei e Grace dormivano. Se la venticinquenne Mary Cline Bacon non avesse avuto la discrezione di andarsene a quell’ora antelucana, Anne e Grace sarebbero state quasi certamente chiamate dal padre ad assistere la moribonda, nonostante fossero due bambine di appena quattro e sei anni; e questo perché Mr Bacon era in tutto e per tutto un figlio del suo tempo, convinto che la lezione morale implicita
nella morte di qualcuno che avrebbe potuto mietere ancora molto nel gran raccolto della vita fosse un insegnamento esemplare. Un’efficace opportunità di elevare spiritualmente le sue figlie, un bagno di realismo e disincanto che le avvertisse per tempo della fragilità e dell’azzardo dell’umana esistenza. La convinzione di Mr Bacon che le sciagure avessero sempre almeno un lato da cui potevano essere considerate esemplari era del resto largamente condivisa nella sua cerchia più intima: e per lungo tempo la morte della sfortunata Mrs Bacon si tirò dietro quest’impressione di spreco, come se avesse scelto lei di morire nel cuore della notte e in perfetta solitudine, commettendo così un’indelicatezza ancora maggiore rispetto a quella di lasciare dietro di sé un vedovo e due orfane, e tutto per l’imperdonabile inaccortezza di non essersi coperta a sufficienza andando a teatro.
Anne fremette pensando alla frase preferita del nonno: “La morte precoce indica l’incapacità dell’organismo di reagire al male”. Era terribile, pensarci. Avere un corpo che non ti ubbidisce e si piega alla malattia. Henry Cline era stato un pioniere della chirurgia al St Thomas Hospital, prima che una nuova generazione di chirurghi lo allontanasse dal tavolo operatorio per le sue opinioni troppo antiquate. Vedovo, si era ritirato in campagna, in un cottage in affitto non lontano da Bounds Green, dove passava le giornate a inventare il modo per farle, appunto, passare. Era mutevole nelle sue passioni tanto quanto era stato costante nella professione. Per qualche mese aveva accarezzato l’idea di mettere insieme gli appunti dei suoi studenti e scrivere un manuale di anatomia, ma il progetto era stato abbandonato, senza una spiegazione. Anne pensava che la ragione fosse da attribuirsi al rimpianto di non essere più ammesso al tavolo operatorio; ma non se ne parlò mai, nemmeno di sfuggita. Cline aveva cominciato allora a interessarsi di erboristeria, che chiamava con sussiego “la scienza dei semplici”, finché, come spiegò, la semplicità non lo ebbe profondamente annoiato, spingendolo a interessarsi del suo opposto: azioni di Borsa e modeste speculazioni finanziarie; cautela, fortuna e favorevoli congiunture dei mercati internazionali gli procurarono dei guadagni che, nel suo intimo, considerava tanto immeritati quanto graditi. Pensò che fosse opportuno investirli in qualcosa di solido e tangibile e comprò una casetta a due piani con un po’ di terra, Primrose Cottage.
Durante la settimana di Natale, Cline si trasferiva in Harley Street.
Ogni anno arrivava di buon mattino, intirizzito e bellicoso. Anne e Grace lo osservavano dal pianerottolo, vagamente impensierite, finché Eliza o Miss Jenkins non salivano a chiamarle. Se non erano ancora pronte, Miss Jenkins scendeva a intrattenere l’ospite mentre Eliza si affrettava a vestirle, spazzolarle, allacciare grembiuli e infiocchettare trecce: poi le spediva, con l’aiuto di una scarica di colpetti sulle spalle e un concerto di «su, su» a salutare il nonno. Huntley Bacon sarebbe rientrato dal negozio solo a metà pomeriggio, in tempo per il tè: preferiva non modificare le sue abitudini, e soprattutto mai all’approssimarsi del Natale e dell’impennata delle vendite che si registrava in quel periodo.
Per Anne e Grace quell’uomo bizzarro e corpulento che passeggiava avanti e indietro tra il salotto e lo studio, le mani ficcate nelle tasche della giacca, era una misteriosa propaggine della famiglia nei cui confronti provavano attrazione e sospetto; era il padre della loro defunta madre e veniva in Harley Street per vederle, questo lo capivano. Di lei, tuttavia, non avevano alcun ricordo preciso, solo immagini sfumate che forse erano addirittura ricostruzioni artificiali; se mai c’era stata qualche somiglianza di tratto tra padre e figlia, non avrebbero comunque saputo coglierla nello sguardo acquoso di Cline, nella sua fronte liscia e lucida su cui la parrucca si ostinava a non volersi sistemare definitivamente.
Dopo aver fatto scaricare al garzone una cassetta di mele del suo frutteto, Cline faceva chiamare la cuoca ordinandole un budino per la sera, che doveva avere la giusta dose di uvetta, cannella e zenzero. Quindi si sedeva vicino al fuoco – «In questa casa fa sempre freddo! Legna giovane e carbone scadente, non è vero?» – finché le guance non gli si arrossavano e la grossa testa squadrata cominciava a ciondolare, ma solo per risollevarsi bruscamente, come se, di tutte le cose al mondo che potevano capitargli, scivolare nel sonno fosse di gran lunga la più insensata. Allora si aggrappava al cordone e suonava perché Eliza gli portasse il giornale e una tazza di brodo, corretto con un dito abbondante di sherry; e solo dopo aver letto il giornale da cima a fondo, essersi acceso la pipa e aver sorseggiato il brodo con una raffica di sommessi gorgoglii, Henry Cline approdava a uno stizzito conforto che gli permetteva di rivolgere la sua attenzione alle bambine.
«Allora» diceva, «venite un po’ qua e fatemi vedere come siete diventate.»
A turno, Grace e Anne gli si avvicinavano. Cline le studiava pensieroso, poi afferrava le mani dell’una o dell’altra con la sua, grande e ricamata di vene azzurre, e ispezionava lentamente dorso e palmo; quindi, sollevava il mento di entrambe tra pollice e indice e spostava la testa di qua e di là, come uno scultore che cerchi il profilo migliore del modello. Pretendeva di controllare dentatura e lingua e tastava misteriosamente la nuca, risalendo via via fino alla sommità del cranio. Poi discendeva seguendo quello che sembrava uno schema prestabilito, tamburellando con le dita macchiate di tabacco sulla testa delle bambine. Concluso l’esame con un buffetto, dichiarava di non aver trovato tracce di segatura nel cervello. Ma mancava ancora una piccola, ulteriore verifica per fugare qualsiasi dubbio che residui focolai di dabbenaggine potessero annidarsi segretamente da qualche parte: «Leggetemi qualcosa a voce alta, avanti! E poi voglio sentirvi recitare un paio di filastrocche. Un uomo deve pur sapere se il suo stesso sangue non si è annacquato! Siete le sole nipoti che possiedo, vorrei saggiare un po’ di che materia siete fabbricate! Coraggio» proseguiva, vedendo le facce costernate delle bambine «anche se, come immagino, mi deluderete, non vi frusterò! Soltanto, dovrete sapere che mi avete rattristato. E non è mai una bella cosa rattristare un vecchio. Scommetto che, se vi facessero esercitare» e dicendo “vi facessero” Cline roteava il dito in alto e alzava tutte e due le sopracciglia «sareste bravissime. Non c’è dubbio, non c’è dubbio su questo! La natura umana progredisce, se stimolata a dovere. Altrimenti se ne va in malora, corrotta dalla pigrizia. L’intelligenza è scomoda, bambine mie! Ne so qualcosa, io. Ah, sì. Vi costringe a lambiccarvi il cervello e a difendervi dagli stupidi. Credetemi, vi renderà più spesso sole che in compagnia, più dubbiose che certe, più irrequiete che soddisfatte. Ma non dovrete mai rinunciarvi se, come spero, avete la fortuna di possederla. Sarebbe il peggiore dei delitti. Verrei io stesso a bastonarvi se lo faceste, ve lo garantisco. Le nipoti di Henry Cline non devono diventare due sciocche! Non lo sopporterei, nossignore, proprio non potrei. Sarebbe un insulto. Rivolto a me e a vostra madre. Aveva una bella testa, poverina, ah sì!, davvero una bella testa e così poca salute.» Arrivato a questo punto, Cline emetteva un profondissimo sospiro e scivolava inesorabilmente nel passato. «Mi assomigliava. Ah, sì che mi assomigliava! Una goccia d’acqua. Stessa cocciuta perseveranza. Quando si è cacciata in testa di sposare vostro padre non c’è stato nulla da fare. Ah sì, che peccato…! Sarebbe stata perfetta come moglie di un medico, aveva intuito, sensibilità e intelligenza; e invece…»
Grace arrossiva di collera e dispiacere, ogni volta che il nonno faceva, con parole più o meno simili, quei discorsi. Anne soffriva nel vedere la pena della sorella, ma non era convinta che il nonno venisse soltanto per essere spiacevole e ingozzarsi di oca arrosto, come diceva Grace; era sinceramente contento di trascorrere qualche giorno in Harley Street. Non era con loro che ce l’aveva, per niente; era – ci avrebbe scommesso – soltanto arrabbiato perché la sua unica figlia era morta. Spiegava con pazienza a Grace che bisognava essere indulgenti e sorvolare sulle cattiverie. Non piaceva a nessuno passare da solo le feste natalizie. Una volta considerate quelle spruzzatine di acidità come una forma di debolezza, la grossa figura del nonno rimpiccioliva e metteva meno paura; i suoi borbottii, i suoi «ah sì», diventavano perfino un po’ ridicoli.
Appena Huntley Bacon rientrava – sempre piuttosto tardi, quando era buio già da un pezzo – Cline lo aggrediva: «Queste due bambine mangiano a sufficienza, Bacon? Sono più ingiallite che mai. Devono prendere un limone spremuto in mezzo bicchiere d’acqua, tre volte alla settimana. L’acido citrico migliora l’appetito e disinfetta lo stomaco. Dopo pranzo devono fare una passeggiata, mezz’ora almeno, ben coperte e con i piedi asciutti. Anche quando piove. Se rimangono al chiuso, si guastano. Ah sì, sono davvero due cosine malmesse. Venite qui, fatevi guardare ancora. Be’, Grace, sei cresciuta di almeno un palmo dall’ultima volta. Molto bene. Non troppo magra, per nulla grassa. Le donne non devono essere spilungone, ma nemmeno delle bamboline, per carità. Misura in tutte le cose, ecco quello che ci vuole. Siediti qui, Anne, accanto a me. Dopo mangiato mi farai vedere se sai scrivere senza errori St Andrew Undershaft, St Thomas Hospital, St Botolph’s Bishopsgate. Hai dodici anni, ormai. L’ortografia non dovrebbe avere più misteri per una dodicenne istruita come si deve. E intanto, per scaldarci un po’, immagino tu sappia dove si trovano l’India e il Giappone. E naturalmente, il Brasile e la Giamaica».
Anne deglutiva, lo stomaco contratto. Sapeva dov’erano il Brasile e la Giamaica, piuttosto vagamente. Ma il Giappone? La guardavano tutti con annoiata benevolenza. Se avesse sbagliato – e sarebbe accaduto – il nonno Cline avrebbe ricominciato con la solita tiritera: «Due figlie femmine e nemmeno una moglie per casa, Bacon, non è una buona idea, oh no, non lo è affatto».
Lo faceva apposta per irritare suo padre. Aveva sentito dire anche da Eliza che il chirurgo Cline aveva fatto il diavolo a quattro quando la sua unica figlia aveva voluto sposare il figlio di un tintore di stoffe arricchito. «Tuo nonno» le aveva detto Eliza rimboccandole la coperta «ha dimenticato di essere il figlio di un sarto di Bishopsgate.»
Anche la storia della dote, che Henry Cline aveva già assegnato alle nipoti, era tirata in ballo per tenere viva l’irritazione di Huntley. «Con i tuoi commerci e i miei risparmi, quando saranno in età da marito avranno la fila alla porta, Bacon. Se avrai dato loro istruzione, educazione e buone maniere, nessuno si ricorderà che il piedistallo su cui sono salite è un groviglio di fili di seta e studi anatomici. Pensaci. Possono scendere o salire sulla scala sociale, ma spetta a te imprimere la direzione. Un buon patrimonio è lo châssis. Educazione e istruzione sono ottime ruote. Sani e onesti princìpi sono le redini. L’ambizione, naturalmente, è la frusta. Infine, la carrozza: tendine di seta, lanterne di ottone e maniglie d’argento. A quanto vedo, sono già due graziose carrozzelle. Tutto il resto dipende da te, Huntley Bacon.»
Bacon stringeva i denti. Era immensamente irritato. Bastava che trascorressero insieme mezz’ora perché si dessero sui nervi a vicenda. Possibile, si chiedeva Anne, che si azzuffassero ancora per sua madre? Eliza le aveva detto che, scegliendo Huntley Bacon, lei aveva lasciato il nonno da solo. E lui si era inselvatichito, diventando aspro come le mele che coltivava a Primrose Cottage.
«Non hai figli maschi. Sono le femmine, il problema. Crescono in casa.»
«Infatti. Non ho figli maschi da mandare in collegio e cui affidare i miei commerci quando sarò troppo vecchio per occuparmene. Ho due bambine e due ottime donne, assunte per occuparsene. Il mio tiro a quattro è più che sufficiente per condurre agilmente la mia carrozza.»
Non c’era volta che suo padre non cascasse nella trappola che Cline gli tendeva per puro divertimento. Le bambine erano sue, sue e di Mary. Come le avrebbe educate, nutrite o agghindate era affar suo. Che bisogno c’era di ribadire l’importanza di un’ascesa sociale? Nemmeno una volta, nella vita, aveva preso la rincorsa per azzerare le distanze che lo separavano da quelli che erano nati già ricchi e avevano studiato e viaggiato. Concentrarsi su un obiettivo simile avrebbe voluto dire perdere di vista lo scopo di tutto: fare bene il proprio lavoro. E il lavoro, da parte sua, lo aveva ripagato: la fatica fisica – sguazzare a piedi nudi in una vasca di tintura e correre a rotta di collo ai magazzini sul fiume – si era trasformata in fatica mentale, dove occorrevano intuito e pazienza, polso fermo e capacità di gestione. Da garzone era diventato impiegato, da impiegato assistente, da assistente socio e, infine, padrone della baracca. Corse, preoccupazioni, rischi, intuizioni e affanni erano stati i mattoni su cui aveva costruito la sua posizione; ma mai, si vantava, tra quei puntelli c’era stato il desiderio di arrampicarsi più in alto di dove la natura l’aveva collocato alla nascita. Avere come scopo l’ascesa sociale era qualcosa che lo faceva inorridire; e, aggiungeva irritato, avrebbe dovuto far inorridire anche Cline, che si vantava di avere opinioni non conformiste e poi si perdeva in sciocchezze simili. Sia l’uno sia l’altro avevano fatto strada – eccome se ne avevano fatta! Forse Cline l’aveva dimenticato? – attraverso una selva spinosa, zeppa di insidie. Se Cline il suo passaggio l’aveva aperto a forza di bisturi, lui l’aveva lastricato di seta lucente. Un bel pezzo di strada davvero. Certo che le sue figlie, una volta cresciute, sarebbero andate avanti e non tornate nella boscaglia! C’era bisogno di dirlo? Cosa temeva suo suocero, che non fosse all’altezza del compito? Che non sapesse com’era facile fare un salto all’indietro e ripiombare nella sozzura da cui era venuto? Era per questo che non si concedeva la minima distrazione, per questo che passava le sere a raschiare la carta con il pennino riempiendo dozzine di taccuini di cifre e scarabocchi. S’imponeva rigore anche nell’ora in cui i londinesi preferiscono bere uno sherry e fumare un sigaro.
«Le tue figlie mi preoccupano, Huntley.»
«Grace e Anne sono affidate a un’istitutrice e a Eliza.»
«Crescono bene? Si sono alzate di un palmo, questo lo vedo. Pensi che avranno una mente svelta? Una buona indole?»
Una fiamma di fastidio incendiava gli occhi di Bacon. «Sono certo che è così» rispondeva asciutto.
«Huntley, faresti bene a riprendere moglie. Una casa deve avere una padrona che la governi.»
«Non ho tempo di prendere un’altra moglie.»
«Che sciocchezza. Le bambine dovrebbero essere accudite da una madre.»
«La madre delle mie figlie è quella che ho sposato e che le ha generate.»
Anne frugava nei ricordi cercando almeno un’immagine di sua madre, ma non la trovava. La miniatura sullo scrittoio del nonno non somigliava per niente a quella che suo padre teneva sulla mensola del camino, a parte il fatto che entrambe ritraevano una ragazza con i capelli sbiaditi e gli occhi seri. Aveva piedi piccolissimi, questo lo sapeva perché Eliza aveva conservato i suoi stivaletti, minuscoli e rigidi.
E adesso che si sentiva così debole e così stanca, bagnata di sudore e con la testa confusa, stava per morire come sua madre? Eliza avrebbe conservato anche i suoi, di stivaletti, per tirarli fuori un giorno lontano e dire a tutti “ecco le scarpe di Anne”? Mary Bacon era morta per essere soltanto andata a teatro; era svanita e quello che restava di lei, la ragazza muta del ritratto e quella spiacevole nube di tensione tra
suo padre e il nonno, era solo una specie di sogno, non una madre vera. Non poteva dubitare che fosse esistita, ma non riusciva a darle concretezza; e gli stivaletti non erano la prova di niente. Se lei fosse morta, ancora più giovane, sola e senza figli, sarebbe diventata qualcosa del genere: un mucchio di vestiti da dare via, un paio di stivaletti, una scatola di forcine.
Erano pensieri abbastanza deprimenti. Quando era partita da Londra, aveva sentito una morsa di panico. Riusciva a ricordare il cigolio delle ruote sul selciato, lento e regolare, che metteva voglia di dormire. Aveva pensato di aver vissuto una vita abbastanza lunga, diciannove anni; seduta in carrozza, si avviava a percorrerne un altro tratto, un po’ nebuloso, da cui non sapeva cosa aspettarsi; l’unica certezza era che avrebbe lasciato la sua famiglia. Si sarebbero tenuti in contatto scrivendosi centinaia di lettere, ma si sarebbero rivisti chissà quando; preferiva non pensarci, perché poteva anche darsi il caso che passassero anni.
Il nonno era anziano ma in ottima salute. Badava a se stesso con attenzione. Indossava sempre un panciotto di fustagno pesante e sciarpe di lana e di seta. Quando non metteva la parrucca – un vezzo fuori moda cui rinunciava di rado – portava i capelli incipriati all’antica e legati da un nastro di velluto, marrone come la marsina e il panciotto. Aveva le guance ricoperte da un velo opaco di peluria rada e giallastra. Dopo mangiato si avviava in salotto e sprofondava nella poltrona preferita di suo padre, invitando le nipoti a sederglisi accanto. Era il momento peggiore della giornata, perché aveva spostato la poltrona proprio accanto al camino e il caldo era insopportabile. Come se non bastasse, il nonno aveva lo stesso odore della dispensa nel sottoscala, una miscela pungente di tabacco, vino e orina. Aveva larghi occhi celesti, rotondi, con due borse un po’ tumefatte, chiazzate di rosso, e lunghe dita pallide che muoveva con precisione. Eliza le aveva raccontato che i chirurghi imparano il mestiere sui cadaveri. Li aprono e li scrutano annotando ogni cosa. Il nonno fa lo stesso con la pernice arrostita, aveva pensato Anne. La scarnifica e raduna sul bordo del piatto un mucchietto di cartilagini e ossicini.
Le sere del periodo natalizio scoppiettavano di frecciatine e battibecchi.
Sedute su due sgabelli, Anne e Grace tacevano con trepidazione. Il nonno in gioventù era stato un giacobino. Lo ammetteva lui stesso, con un certo vanto: «Volevano cacciarmi dall’ospedale perché approvavo gli insorti francesi. Avevo degli amici a Parigi…».
Attaccava più o meno così, un anno dopo l’altro. Una storia affascinante, benché l’avessero sentita un mucchio di volte. Riunioni clandestine, tradimenti, processi, esecuzioni. Huntley Bacon, invece, odiava quei discorsi. La semplice menzione di Parigi gli faceva venire in mente «l’insopportabile arroganza di un popolo naturalmente elegante, perfino quando mette in tavola un filone di pane». Bisognava ammetterlo, il pane era lievitato a dovere, e gustosissimo. I francesi erano da due secoli i padroni del commercio di lusso: ogni dama di rango aveva un terzo del guardaroba – se non la metà, gemeva Huntley – tessuto, cucito o ricamato in Francia. Erano loro, i francesi, a dettare le regole: taglio degli abiti, scollature, ampiezza delle gonne e lunghezza delle mantelle. Senza contare gli accessori, le fibbie, i pettini di tartaruga e di madreperla, gli orologi, gli orecchini, i guanti. Sopraffatto da quella visione, un’armata di accessori e chincaglierie molto più temibile, a parer suo, delle armate napoleoniche, Huntley Bacon fissava, con intensa concentrazione, un nodo nel legno del pavimento; e intanto gli occhi sbiaditi di Cline sembravano farsi più scuri e profondi.
«La politica è affascinante, bambine. Quando ero uno studente di anatomia, ho imparato che il modo più sicuro di trovare un rimedio ai malanni del corpo è studiare minuziosamente il suo funzionamento. Non ero il solo a pensare che i guasti di una società potessero essere riparati allo stesso modo, grazie all’osservazione ravvicinata del suo funzionamento. Tra i miei amici ve n’erano alcuni che volevano studiare il fenomeno più di altri. Un braccio di mare ci separava da quello che credevamo fosse il futuro. Resistere a un richiamo simile sarebbe stato quasi impossibile per un uomo di scienza. Era una rivoluzione costruita e innescata da medici e avvocati: uomini moderni, d’intelletto e ragione. E qualcuno, come il povero John Bruce, andò a osservarla troppo da vicino.»
Huntley Bacon, quando saltava fuori il nome di John Bruce, alzava stancamente un dito, per indicare le figlie.
«Una grande occasione sprecata, ecco come la vedo io» diceva Cline. «Il sole della libertà è tramontato nel mare dell’irragionevolezza. Quando hanno messo in funzione la ghigliottina, non c’era più una testa sul collo con cui ragionare. I miei amici sono riusciti a svignarsela, tranne il povero John Bruce che ci ha rimesso la testa.»
Chi fosse e che cosa avesse portato “il povero John Bruce” a farsi tagliare la testa dai francesi era un mistero che Cline non aveva mai avuto intenzione di svelare.
Anne e Grace scrutavano il padre e il nonno, preoccupate che la conversazione degenerasse nell’ennesima discussione. Gli sforzi che facevano – loro due a imparare a memoria poesiole da recitare, la cuoca a preparare i dolci preferiti dal nonno – sembravano non essere mai abbastanza.
L’ingresso di Eliza, con un vassoio di tremolanti coppe alla vaniglia spolverate di zucchero, era la salvezza. Il profumo che si spandeva per la stanza spazzava via i mercanti francesi, la ghigliottina, il governo del popolo e il resto. Soltanto Huntley Bacon, con gli occhi fissi sul vassoio d’argento, diceva che la Francia gli pesava sullo stomaco come un macigno. Prima la Rivoluzione, poi quel fanatico, piccolo corso. Con il risultato che le strade di mezza Europa erano rimaste bloccate, i magazzini lungo il Tamigi stipati fino al soffitto di merci destinate ai francesi rimaste invendute. Un momento d’oro per i contrabbandieri. I mercati erano impazziti. Un mucchio di gente era fallita.
«Dovresti essere grato ai francesi» diceva Cline al genero, ingoiando cucchiaiate di crema. «La merce rara è quella che fa ricco il mercante, con le guerre degli altri si fanno affari d’oro… La crema che si mangia in casa tua, Huntley, è davvero sorprendente. Non posso che apprezzare la saggezza con cui la cuoca dosa la cannella.»
«Ho lavorato sodo» replicava Huntley di pessimo umore. «Per la vita che faccio posso ringraziare me stesso e nessun altro, a parte l’Onnipotente.»
«Spero che l’Onnipotente impieghi il suo tempo in occupazioni più alte che fare ricchi i mercanti di Londra, Huntley.»
«Vi prego di ricordare che in questa casa ci sono giovani orecchie.»
«Giovani orecchie e palati esigenti. La vaniglia ha un sublime tocco di zenzero al fondo che ti assolve dalla tua mancanza di esprit.»
Alle bambine risultava evidente come la Francia, la Rivoluzione, la testa di John Bruce non fossero altro che immagini fluttuanti, prive di consistenza, sogni. La lealtà verso il padre le faceva fremere davanti all’ironia sprezzante del nonno, ma sulla crema aveva ragione, accarezzava il palato e scendeva giù morbida, di velluto.
«Il tuo lavoro è la seta, giusto?» aveva sussurrato un pomeriggio all’orecchio del padre, e lui aveva sorriso.
«La seta è il nostro oro» le aveva risposto con bonaria solennità. «Dalla seta arriva tutto quello che abbiamo.»
Il nonno, le guance rosse e splendenti come due coste di rabarbaro, per una volta si era detto d’accordo. «Ah sì, l’abilità di tuo padre come mercante è straordinaria. Dicono che sia tra i migliori, a Londra. Dovresti esserne fiera» aveva concluso, a malincuore.
«Lo sono» aveva detto Anne scendendo dallo sgabello, e si era guardata attorno. L’oca arrostita e croccante, l’argenteria, i bicchieri di cristallo. Il nuovo servizio di piatti con le tenui pagode azzurrognole immerse in un bosco di salici. Il vino francese, spumoso come schiuma di birra chiara, e il tavolo di mogano con le gambe tornite, i biscotti al burro e le gelatine di frutta verdi e rosse. La crema vanigliata al profumo di cannella.
Ecco a cosa serviva la seta.
«Che bel lavoro che fai» aveva detto.
2
Alla fortuna non si può chiedere troppo
Non voglio morire.
Non adesso.
C’erano pensieri più dolci in cui scivolare. Se fosse stata a casa li avrebbe avuti tutti intorno. A preoccuparsi per lei. Era la più giovane delle sorelle – «la più facile» diceva Miss Jenkins. Non aveva mai avuto il temperamento di Grace, capace di sollevare un polverone per una sciocchezza. Aveva sempre preferito evitare gli scontri e cercare una mediazione. Tutti sostenevano che aveva un carattere amabile e allegro, che avrebbe affrontato la vita senza scontrarvisi perché era fiduciosa e ottimista. Ecco, disse a se stessa, è arrivato il momento di essere entrambe le cose, ottimista e fiduciosa. Non sarebbe affatto morta. Se anche si era trattato di una malattia grave, l’avrebbe superata. Sarebbe guarita e la vita avrebbe ripreso a scorrere come al solito. Era questo che significava essere ottimisti, no? Non prendersela, non vedere tutto nero. Obbligarsi a considerare le cose da più punti di vista e scegliere il più favorevole. Avrebbe alternato i soggiorni a Londra a quelli fuori città, sarebbe andata in campagna e a fare compere. Sarebbe andata in Mount Street a sbirciare le clienti che aspettavano di essere servite da Mr Davis e Mr Shannon.
Quello di suo padre era il negozio più affollato ed elegante del quartiere, rivestito da una boiserie di mogano lucido sulla quale spiccavano diverse stampe navali in cornici di ciliegio. Riproducevano brigantini e golette, vascelli e battelli a vapore placidamente ormeggiati in acque tranquille o appena increspate, tranne una gouache – la preferita, senza dubbio, di Anne – dove un grosso mercantile era pericolosamente inclinato sullo sfondo di un mare color piombo. L’arredamento era stato studiato da Mr Bacon in persona: le navi, si supponeva, solcavano senza sosta i mari per rifornire l’Inghilterra di ogni ben di Dio, incluse le stoffe allineate con cura sugli scaffali, i filati necessari a produrle, le cocciniglie e l’indaco per tingerle; e lo stesso valeva per il legno di mogano americano, pagato tre ghinee la libbra. Un moro reggitorcia in ottone argentato a Sheffield, comprato da Mr Bacon a un’asta da Bonhams, occupava una nicchia semicircolare, accanto a due poltrone di velluto blu scuro. Nelle intenzioni di Huntley Bacon, l’arredo doveva suggerire come la ditta H.W. Bacon fosse in grado di vendere agli inglesi ciò che gli inglesi sopra ogni cosa apprezzavano: una equilibrata mescolanza di esotismo e raffinatezza, tradizione e intraprendenza.
Con queste premesse non c’era da stupirsi se, di tutta Londra, il luogo che ad Anne piaceva di più era proprio il negozio di suo padre, al numero 12 di Mount Street. Lei e Grace ci andavano raramente, perché la veloce ascesa sociale della famiglia aveva finito per modificare le abitudini dei Bacon. Era preferibile che due ragazze benestanti e di una certa avvenenza non fossero troppo associate a un’impresa commerciale, sia pure di successo. Anne aveva aggirato l’ostacolo convincendo Grace a fare la passeggiata giornaliera sempre, più o meno, in direzione di Mount Street, in modo da riuscire a guardare le tre vetrine dall’altro lato del marciapiede. I vetri smerigliati e incisi con il nome “H.W. Bacon” e, a lettere più piccole, “Silk Merchant and Mercer since 1789” la riempivano di orgoglio; aveva confidato a Prospero, cercando di condividere con lui quel piccolo segreto, quanto le piacevano l’odore di legno incerato e quell’allegra profusione di tessuti variopinti, ma lui aveva creduto che scherzasse. Anne non ne aveva più parlato. La verità pura e semplice, quella che Prospero non aveva compreso, era che agli occhi di Anne tanto il magazzino di Spitalfields quanto, soprattutto, il negozio di Mount Street erano davvero luoghi straordinari. In entrambi, riconosceva un mondo a sé racchiuso nel mondo infinitamente più grande e dispersivo di Londra: file e file di stoffe impilate ordinatamente negli scaffali di legno scuro, una quantità di tessuti di ogni meraviglioso colore e consistenza, sete ricamate, a righe, cotoni stampati, mussole, batiste, organze, taffettà. Mr Davis e Mr Shannon, eleganti e cerimoniosi, trattavano ogni cliente con la dovuta cortesia e, tuttavia, con molto distacco, come se quello che sarebbe accaduto allo scampolo di seta o di lampasso una volta tagliato dalle loro forbici affilate non fosse certo affar loro; e conservavano gelosamente i campionari, grossi cataloghi rilegati in tela grezza, in cui una mano paziente e sconosciuta aveva attaccato uno per uno minuscoli ritagli di stoffa, scrivendo accanto a ognuno provenienza, costo, manifattura e disponibilità del tessuto.
«Il tuo futuro marito non è un commerciante» l’aveva rimproverata Miss Jenkins, quando le aveva confidato come l’avesse stupita – e anche ferita – il distacco di Prospero. «Non puoi aspettarti che capisca. A Londra, il successo nei commerci è garantito dalla legge e auspicato dai politici. Fa circolare il denaro e le idee. Ma i commercianti non si mescolano all’aristocrazia. Ci sono delle regole.»
«Oh sì, questo l’ho già sentito dire decine di volte. La frase preferita di papà, ogni volta che assolda un avvocato per riscuotere un debito, è: “Siamo un popolo che, una volta stabilite le regole del gioco, le osserva fino in fondo”.»
«Tuo padre è un imprenditore di grande talento.»
«È quello che dicono tutti» aveva risposto Anne, con fierezza. «Se sarà eletto Master della Clothworkers’ Company metteranno il suo stemma sulle vetrate istoriate.»
Miss Jenkins aveva sorriso: «Tuo padre non possiede uno stemma, Anne».
Miss Jenkins non aveva quasi mai intenzione di essere sgradevole. Era il suo amore per la precisione a farla parlare con franchezza tagliente; ma, poiché apparteneva a quella specie d’individui capaci di osservarsi in azione dall’esterno – perfino con un buon grado di oggettività –, aveva colto lo sconcerto di Anne.
«Mi ha chiesto un suggerimento» aveva aggiunto con voce più carezzevole. «Ci sto pensando da un po’. Potrebbe adottare come emblema un cinghialino e un motto semplice e di buonsenso.»
«Vorreste proporgli un cinghiale?»
«Perché no? È un modo d’interpretare letteralmente il cognome Bacon e di elevarlo un po’ senza esagerare. Fa pensare alla caccia, uno sport da gentiluomini.»
«Un cinghiale, Miss Jenkins!» Era scoppiata a ridere. «Pensate proprio a tutto.»
Miss Jenkins, moderatamente irritata dalla reazione di Anne, aveva messo a tacere il sospetto che la più giovane delle sue ragazze la stesse prendendo in giro, ma non era riuscita a trattenersi. «Ho creduto mio dovere suggerire a tuo padre che sulle vetrate della Clothworkers’ Company sarebbe stato più decoroso vedere un cinghiale che un trancio di pancetta di maiale. Se ti sembra così divertente…»
«Oh, papà ne sarà sorpreso e soddisfatto, probabilmente.»
«Anne, un cinghiale è sempre meglio che un pezzo di lardo. Presto baderai anche tu a simili sottigliezze. Tuo padre è perfettamente rispettabile, ma…» E qui Miss Jenkins intenzionalmente aveva punto: «Non può mettere piede da White’s. Il mese prossimo sposerai un uomo di condizione superiore alla tua. Per quanto tuo padre sia un uomo di grandi mezzi è comunque… quello che voglio dire è che… insomma, Prospero Vignon si è invaghito di te al punto da non badare alla tua provenienza».
«Voi non vedete che barriere e ostacoli e…» Anne si era sforzata di rintuzzare Miss Jenkins «…cose romanzesche, ecco. È tutto molto più semplice nella vita. Le persone pensano, decidono e fanno. Soprattutto quando c’è un sentimento. Non passano il tempo a rimuginare, a temere passi azzardati. A pentirsi. Prospero è stato in casa nostra, ha incontrato mio padre. Non ci guarda dall’alto in basso, ne sono sicura! E non voglio che voi mi facciate sentire in difetto o inferiore. Comunque» aveva detto con un’ombra di petulanza, «tra gli antenati di Prospero c’erano dei proprietari di filande.»
Miss Jenkins aveva intrecciato le dita sul tavolo, come faceva sempre quando considerava chiusa una conversazione. «Non parlargli più del negozio di tuo padre. Gli uomini come Prospero sono abituati a pensare che le donne non dovrebbero avere troppe idee né troppe opinioni. Rispetta le sue consuetudini.»
«Le rispetterò.» Ma ad Anne non piaceva per niente lasciar cadere le questioni, per cui aveva aggiunto: «Mio padre è un uomo perfettamente rispettabile, Miss Jenkins. Proprio voi dovreste saperlo. E anche noi lo siamo. Non c’è nulla di cui Prospero debba vergognarsi».
«Anne, non offenderti. Tuo padre si guadagna da vivere. E tuo nonno è addirittura un chirurgo.»
Da quando Miss Jenkins badava a certe cose?
«È stato presidente del Royal College of Surgeons, e Chantrey gli ha perfino fatto un busto.»
«Un chirurgo, per quanto stimato, entra dalla porta dei fornitori.»
«Ma questo è ingiusto, no?»
Miss Jenkins l’aveva fissata, un lungo sguardo. Huntley Bacon le aveva lasciato mano libera nell’istruzione delle ragazze. Insieme avevano letto qualche passaggio di Rousseau, dal momento che molti princìpi dell’Émile coincidevano con le opinioni inglesi in materia di educazione, e specialmente con le sue personali – benché la irritassero certe convinzioni così stantie sull’inferiorità femminile –, e le aveva fatte esercitare nella lettura ad alta voce sulla sua copia delle Lettres sur les Anglais.
Si era prefissa di impartire alle figlie di Bacon un’istruzione di prim’ordine; metodica, articolata, aperta e quasi sperimentale. Non le aveva mai considerate semplicemente la motivazione del suo soddisfacente salario, né teste da farcire di nozioni, bensì menti da formare attingendo a tutto ciò che Londra, nella sua pienezza, offriva. Proprio come i commerci avevano arricchito un popolo e l’avevano reso libero, un’istruzione adeguata avrebbe elevato Grace e Anne. Anche se non le avrebbe rese del tutto libere, perché si trattava pur sempre di ragazze, impacciate da più obblighi – ragionevolmente, si diceva – dei loro coetanei uomini. Miss Jenkins era fermamente convinta di aver fatto un ottimo lavoro; Grace e Anne erano sveglie e brillanti, affettuose e sensibili. Nel cielo della libertà da lei intravisto, tuttavia, di tanto in tanto si addensava qualche nuvola: i ragionevoli limiti che aveva eretto intorno alle sue pupille confliggevano con l’idea di pensare ed esistere senza essere sottoposte a regole; l’educazione, rifletteva, altro non è che equilibrio tra buonsenso e abitudini sociali, una forma di compromesso necessario, se non ineludibile. Questo genere di riflessioni ogni tanto la turbavano, ma da tali derive tornava sempre baldanzosa, convinta di essere un’educatrice per vocazione e non per mestiere. E la vocazione consente, si consolava, qualche incertezza; ne ha perfino bisogno, per uscirne rinvigorita.
BENEDETTA CIBRARIO è nata a Firenze nel 1962, da padre torinese e madre napoletana. Vive a Londra. Nel 2007 esordisce con il romanzo Rossovermiglio(Feltrinelli, premio Campiello 2008). Rossovermiglio viene tradotto e pubblicato in diversi paesi, tra cui la Germania, l’Olanda, il Portogallo, la Grecia. Nel 2009 esce Sotto cieli noncuranti (Feltrinelli, premio Rapallo Carige 2010) e, successivamente, Lo Scurnuso (Feltrinelli, 2011).