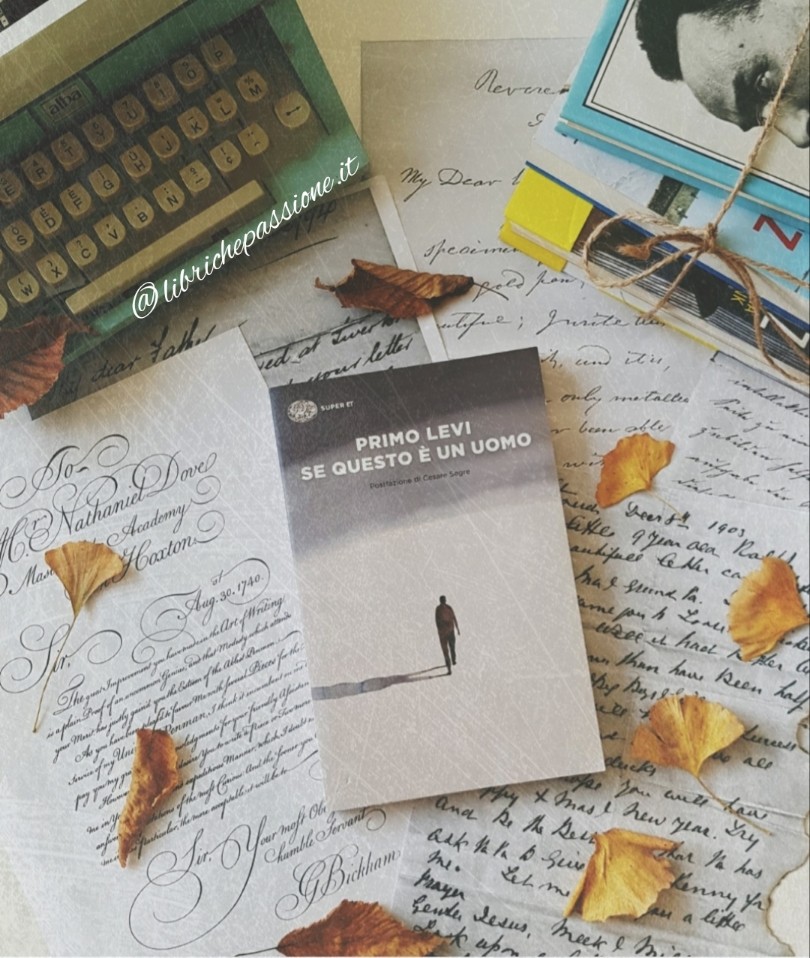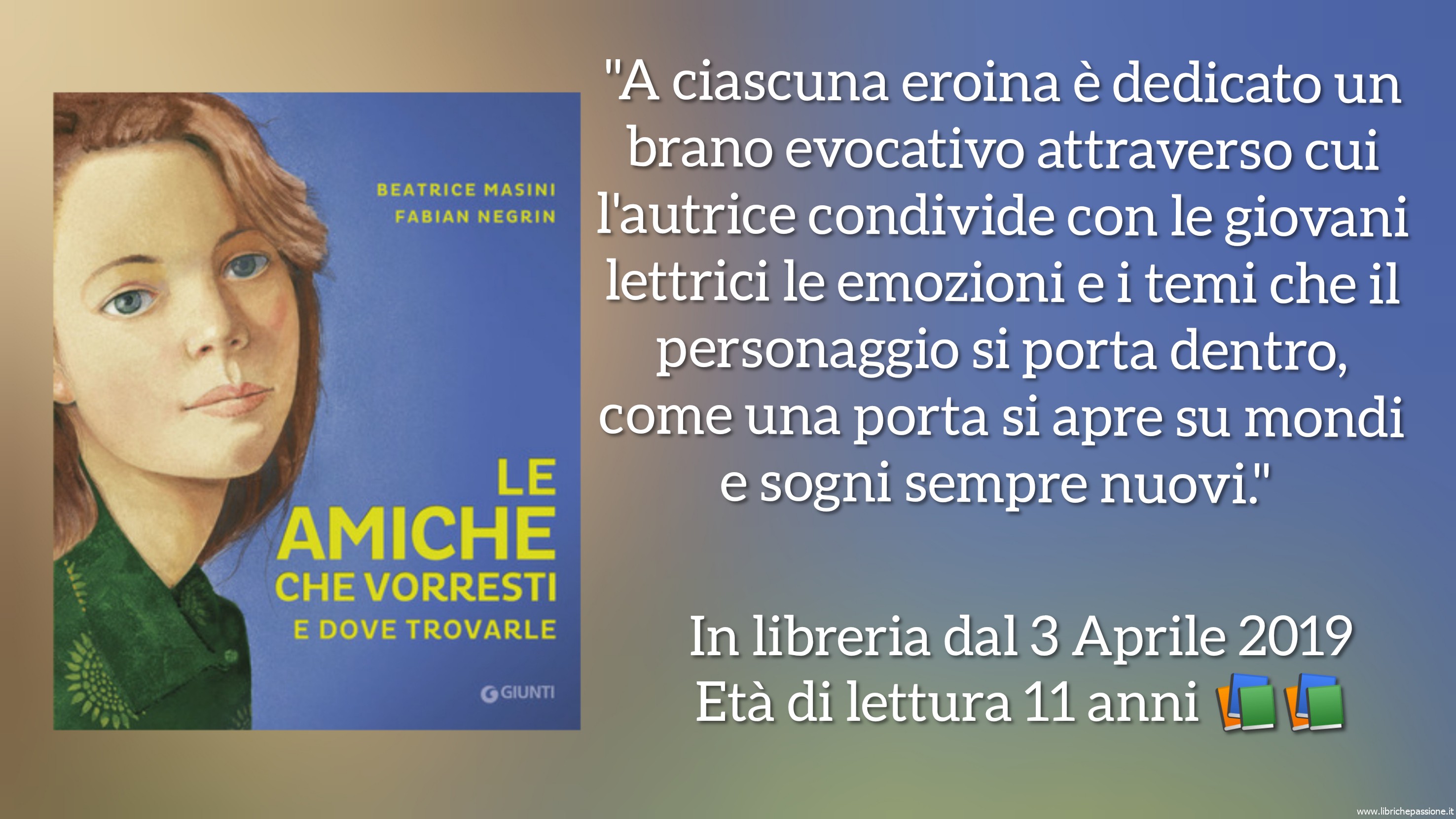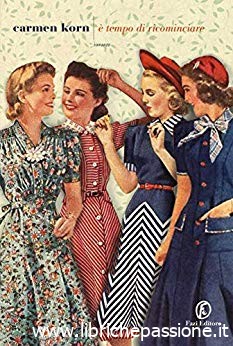Trama
Attorno alla figura di P.I. Čajkovskij permane, sebbene su di lui sia stato scritto molto, un alone di mistero. Vari gli aspetti della sua vita che si prestano alla costruzione di un personaggio quasi romanzesco: il rapporto con la madre e la tragica fine di questa, l’omosessualità, il disastroso matrimonio, la relazione con la signora von Meck, sua ricchissima mecenate, durata quattordici anni senza che i due si incontrassero neppure una volta, la morte, con l’enigma del presunto suicidio. E la musica: finora quella di Čajkovskij è stata la musica romantica per eccellenza. Nina Berberova, affidandosi ai documenti d’epoca ma soprattutto ai suoi preziosi colloqui con le persone che avevano conosciuto Čajkovskij, e ricomponendo il tutto con sensibilità e intelligenza, ci regala un ritratto del grande musicista per molti aspetti inedito. Il bambino dalla morbosa sensibilità, il «ragazzo di vetro», come lo definì la governante francese Fanny, e l’uomo di mondo che indossa sempre una maschera; la persona desiderosa di quiete e delle gioie semplici della vita familiare e il grande musicista, riverito e applaudito nelle capitali d’Europa. La Berberova ricostruisce, senza remore o falsi pudori e con grande freschezza, la figura di un uomo tormentato ed estremamente consapevole, colto e aperto alle suggestioni europee, ricco di contraddizioni ma anche capace di risolverle tutte nella sua musica. Una biografia impeccabilmente documentata, cui il talento di scrittrice di Nina Berberova dà una straordinaria qualità narrativa.
Estratto
PREFAZIONE
La moda delle grandi biografie, in Francia e in Inghilterra, risale agli anni Venti e Trenta. In quell’epoca gli autori adottarono leggi precise e rigorose da applicarsi a un genere letterario per il quale fino a quel momento la sola guida era stata l’immaginazione: dialoghi immaginari, incontri plausibili e tuttavia inventati, parole d’amore sussurrate nell’intimità, segreti sentimenti pudicamente svelati… In queste opere romanzesche i documenti avevano un’importanza minima, venivano reputati troppo seri. Era ovvio che un lieto incontro dovesse verificarsi in una giornata di sole, e che per contro lo sfondo della rottura con la beneamata fosse un cielo carico di pioggia, come nei film degli anni Dieci. L’improvviso rinnovarsi del genere si è configurato come una rinascita. Personalmente, ho seguito questo movimento attratta dai problemi che così si ponevano.
Nello stesso periodo – erano gli inizi degli anni Trenta – nell’Unione Sovietica la casa editrice di Stato Academia (fondata a Leningrado, poi trasferita a Mosca e alla fine liquidata da Stalin) aveva pubblicato una ricca documentazione su P.I. Čajkovskij e il suo tempo: memoriali, corrispondenze, diari intimi – il tutto corredato da cospicui commenti che, all’occorrenza, avrebbero costituito la base di un racconto affascinante. Nel leggere quei documenti di emozionante interesse, intuii che forse avrei potuto avvalermene per la stesura di un libro. Subito, nondimeno, presi coscienza dei miei limiti. Non era certo il caso ch’io mi addentrassi nell’analisi della musica del compositore: ciò a mio giudizio era compito del musicologo. Quanto mi competeva era la vita di Čajkovskij; le teorie musicali dell’epoca non mi riguardavano, e non erano neppure in gioco i miei gusti musicali.
Ma il mio interesse era sollecitato anche da un altro motivo, e non dei più trascurabili. A quel tempo io collaboravo al quotidiano russo di Parigi, sul quale regolarmente pubblicavo racconti, poesie, considerazioni critiche sulla letteratura e il cinema sovietici. Ma a volte venivo incaricata anche di cronache a sfondo giudiziario, senza dimenticare che durante le sue ferie sostituivo la dattilografa. Pensavo dunque che una biografia di Čajkovskij da pubblicare a puntate nell’edizione domenicale del giornale sarebbe forse valsa a evitare una falla nel mio bilancio personale.
A Parigi vivevano persone che in gioventù erano state legate al musicista, e io sapevo che senza dubbio avrebbero accondisceso a rispondere alle mie domande. Giacché gli interrogativi erano innumerevoli! Qua e là, nella parte pubblicata delle lettere con i suoi intimi, negli echi ovattati della sua rottura con la signora von Meck, nella documentazione relativa al suo disastroso matrimonio con Antonina, dominava un segreto, affiorava un mistero che per gli intellettuali russi (me compresa) da gran tempo non era più tale, ma che peraltro non poteva essere affrontato alla leggera. Dovevo trovare innanzitutto dei superstiti disposti a parlare.
Decisi dunque di scrivere e pubblicare subito due o tre capitoli sull’infanzia di Pëtr Il’ič, per dimostrare a Rachmaninov, a Glazunov, alla cognata di Čajkovskij, ai nipoti della signora von Meck e ai giovani (ormai vecchi) amici ch’erano stati accanto al compositore nell’ultima settimana di vita e lo avevano deposto nella bara, che avevo realmente iniziato il mio libro, che intendevo portarlo a termine e che avrei chiesto loro di dedicarmi un po’ del loro tempo per interrogarli.
Sergej Rachmaninov era appunto a Parigi per l’abituale concerto alla Salle Pleyel. Alloggiava al Majestic: non all’albergo vero e proprio, ma nell’elegante dépendance dell’avenue Kléber, dove affittava un appartamento. Alto, magro, un po’ curvo, le mani affusolate, il lungo viso imperturbabile, la voce monotona senza vibrazioni, lasciava errare lo sguardo sopra la mia testa. Parlava e io prendevo appunti (gliene avevo domandato il permesso). Mi riferiva della maschera che Čajkovskij non abbandonava mai e che aveva portato, a quanto pareva, dalla giovinezza. Quella maschera era scomparsa al momento della sua morte. Per tutta la vita, diceva Rachmaninov, Pëtr Il’ič aveva camminato senza far rumore, come in pantofole, senza alzare quasi mai la voce, conservando sul volto un’espressione costante di candore (ad uso dell’interlocutore), sempre garbato con tutti. Non voleva offendere, non voleva indignare. Era deciso a mostrarsi amabile, perfino seducente, affascinante in ogni circostanza. Sembrava ossessionato dal timore di suscitare antipatia, preoccupato di non irritare nessuno e di evitare qualsiasi argomento che potesse alimentare un pur minimo attrito. Ed era sempre estremamente compito, anche se sulle prime poteva apparire un po’ distante, soprattutto coi giovani e in particolare con le signorine! Indubbiamente sapeva mostrare le unghie al cospetto del Gruppo dei Cinque; ma si trattava di casi eccezionali, non della regola, giacché l’indomani appariva deliziato da Borodin, era zucchero e miele con Rimskij-Korsakov, dimostrava rispettosa concordanza di pensiero nei confronti di Balakirev… Un ragazzo di vetro, lo definiva Fanny, la sua governante alsaziana a Votkinsk. Di vetro… che fosse un travestimento?
Glazunov sedette al pianoforte e mi indicò una poltrona. Era un vero gigante, un uomo corpulento dall’espressione severa, le labbra strette intorno a un sigaro spento, la cui cenere continuava peraltro a cadere sul pianoforte. L’appartamento era tetro, ingombro di vecchi mobili. Fu Glazunov a venirmi ad aprire e a ricondurmi all’ingresso alla fine del colloquio. Non ebbe l’ombra di un sorriso. Due o tre volte cominciò a raccontare qualcosa esordendo con la stessa frase: «Noi due, io e Ljadov… Eravamo in tre sulla slitta, la notte, uscendo da un concerto… lo riaccompagnavamo a casa…», «Noi due, io e Ljadov, ci sedevamo l’uno in grembo all’altro sulla slitta perché lui fosse più comodo… i cocchieri di Pietroburgo avevano slitte così strette… avevamo paura di causargli disturbo…» Quel gigante di Glazunov doveva soffrirne, non vi è dubbio! Dalle slitte e da Ljadov passò ai difetti di Pëtr Il’ič per concludere… che non ne aveva affatto. Naturalmente aveva il suo problema intimo, ma si trattava di un problema personale che non aveva niente d’inquietante. «Chi non lo sa? Ciascuno di noi ha i suoi segreti.» (Anch’egli aveva il suo: come a Turgenev, a John Ruskin, a Humbert, gli piacevano le ragazzine, e aveva sposato la madre di un’incantevole lolita.) Sul vecchio pianoforte erano posati un bicchiere e una bottiglia di vino rosso comune. Di tanto in tanto Glazunov si alzava e ne beveva un sorso. Mi confessò che nel corso di quell’anno aveva dimenticato un bel po’ di cose. Era stata sua intenzione di prendere nota di tutto, ma non ne aveva avuto il tempo. Sul pianerottolo, si levò il sigaro di bocca e mi dette la mano.
Recandomi in visita da Praskov’ja Vladimirovna Čajkovskij, nata Konšina, moglie di uno dei gemelli, fratelli minori di Pëtr Il’ič – a suo tempo celebrata bellezza moscovita, ereditiera di una famiglia milionaria –, mi sentivo assai meno sicura di me che a tu per tu con i due compositori. Io diffido dei membri delle famiglie d’uomini illustri: vi danno false informazioni, vi chiedono di non rivelare i loro dati anagrafici, di non rivelare certe notizie che possono nuocere a loro più che ai grandi uomini in questione. Ma quella volta le cose andarono diversamente, o quasi…
Praskov’ja Vladimirovna abitava a Neuilly in un pensionato per vecchie signore sole, dove aveva ottenuto una camera grazie a un comitato di beneficenza presieduto dalla signora Ljubimov, il cui defunto marito era stato agli inizi del secolo governatore di Vilnius.
Figlia di ricchi borghesi, Praskov’ja Vladimirovna, vedova di Anatol Il’ič (1850-1915) – a suo tempo senatore, governatore di Saratov e negli anni antecedenti la Prima guerra mondiale membro del Consiglio di Stato –, era stata l’amante di Anton Rubinštejn, il famoso compositore e pianista. Quella sera Panja (come Čajkovskij era solito chiamarla) mi aspettava. Erano le nove, non c’era luce nelle scale. Bussai discretamente alla porta e mi fu aperto. Una vecchina dal viso truccato, i capelli candidi e arricciati, mi squadrò e disse in tono asciutto: «Non posso riceverla. Non ricevo nessuno. Aspetto la Berberova». Le risposi che ero io, la Berberova, e lei rimase di stucco perché si attendeva di vedere una donna della sua età, che aveva conosciuto Čajkovskij di persona. Come potevo scrivere la sua vita se non lo avevo conosciuto in carne ed ossa?
Per prima cosa mi disse in tono molto allegro che Anton Grigorevič era un grandissimo artista. Anche più grande di suo fratello Nikolaj, ch’era stato direttore del Conservatorio a Mosca e pianista di larga rinomanza. Come Liszt. «Però», aggiunse ridendo, «quello non è stato mio.» Era stato soggiogato dal fascino della signora Tret’jakova.
Ero preparata a non cedere su nulla e mi aspettavo il peggio. Lei tuttavia non ebbe difficoltà a parlarmi dell’amicizia tra Čajkovskij e il futuro poetastro Apuchtin alla Scuola di Diritto, quando avevano entrambi tredici anni. Ma affrontò di petto un problema che le stava a cuore. Temeva che nel mio libro io parlassi del bicchierino d’acquavite di champagne che il domestico, Alëša, portava ogni sera a Pet’ja, come Praskov’ja chiamava Pëtr Il’ič. Dovevo capire che, dopo aver lavorato fino a tarda notte, dopo aver fatto la spola per ore tra il suo pianoforte e lo scrittoio, senza quel piccolo viatico Pet’ja non riusciva a prender sonno. Nondimeno Praskov’ja Vladimirovna nutriva il timore che, se lo avessi scritto, i posteri avrebbero potuto scambiarlo per un alcolizzato. «Carissima, la prego, gli faccia bere quel cognac non più di una volta la settimana!»
«Parliamo d’altro», proposi, e lei fu subito d’accordo. «Gli ho rubato un amante», mi disse. «È stato a Tiflis.» «Era Verinovskij», ribattei. Praskov’ja confermò di slancio: «Non me lo ha perdonato mai più!»
Allora, incoraggiata, le posi la domanda. In quella società di cui lei era stata un astro di prima grandezza, che cosa si pensava della passione maschile per i giovanotti? «Nel nostro ambiente», mi rispose, «nessuno si stupiva di alcunché.» Mi spiegò che tutti, più o meno, passavano attraverso un’esperienza del genere. Nove granduchi – a quell’epoca ne contavo solamente otto – ne erano colpevoli. Nove membri della famiglia dello zar! Ma evitando lo scandalo, comportandosi con la dovuta discrezione, nessuno ti importunava. Per tutta la vita Apuchtin aveva dedicato i suoi versi a lei, anziché a lui, in un ansioso tentativo di dissimulazione. E tuttavia era stato lui a corrompere Pet’ja. Ed era l’amante dell’ispettore della Scuola di Diritto, Schilder-Schulder, che a sua volta – chi non lo sapeva? – era l’amante del granduca Konstantin, direttore della stessa scuola. Inutile precisare che Konstantin era sposato, che aveva avuto cinque figli e due figlie, e che dei maschi tre avevano ereditato i suoi gusti.
Praskov’ja Vladimirovna si fermò qui, poi mi annunciò che in un baule conservava il diario di Čajkovskij. Nessuno mai lo aveva visto. Di colpo avvertii un sudore alla schiena. Non feci domande. Mi dicevo: sarà il diario in cui parla del suo amore per Edouard? In un angolo della stanzetta, zeppa di cianfrusaglie, scorsi un baule simile a quelli che esistevano in Russia al tempo della mia infanzia. Ero come impietrita.
Ma ahimè, si trattava soltanto del diario edito nel 1923 dal fratello di Pëtr, Ippolit Il’ič. Lo avevo letto. Era stato tradotto e pubblicato in numerose lingue. Pan’ja aveva tutta l’aria di credere di possederne l’unico esemplare. «È stato realmente pubblicato?» domandò lei. «Non esiste una rilegatura?» fu la mia risposta. Praskov’ja comprese e non insistette più. Le chiesi se mi permetteva di prendere qualche appunto. Il permesso fu accordato. Nel métro continuai a scrivere; poi, rientrata a casa, mi precipitai alla scrivania.
I nostri rapporti proseguirono, dal 1936 al 1948. Invitai più volte Pan’ja a casa mia e lei mi scrisse sedici lettere. Conobbi anche suo nipote, che negli anni Trenta poteva essere sui venticinque anni. Mirok, come lo chiamava Pan’ja (era forse un diminutivo di Vladimir), era un ragazzo mansueto e malaticcio. Era il figlio di sua figlia Tat’jana, Venevitinova in prime nozze, baronessa Ungern-Sterberg in virtù di un secondo matrimonio che le aveva dato due figlie. Ora Tat’jana viveva a Londra con un terzo marito. Ricordo che un giorno la maggiore delle nipoti, una ragazza bella e giovanissima, arrivò da Londra per fare visita alla nonna. Stava per divorziare. «Ma come!» esclamò Praskov’ja, «un uomo così distinto, così intelligente, un erudito, professore a Oxford!» «Nonnina», rispose lei, «è un vecchio, è proprio noioso da morire!»
Ecco qualche frammento delle lettere che mi scrisse in quegli anni Praskov’ja Vladimirovna Čajkovskij.
«Neuilly-sur-Seine (inizi del 1936?)
«… Quando leggevo i suoi articoli su ’Les Dernières Nouvelles’ la immaginavo una vecchietta arcigna, segaligna, con la faccia tra il grigio e il giallognolo, un grosso naso adunco, due labbra smunte e taglienti, i capelli ormai grigi o press’a poco, vestita di una gonna e di una camicetta grigie. E invece, ecco apparire una donna giovane e bella, molto elegante, molto gentile, che mi porta un mazzo di rose! L’immagine stessa della primavera. E io ho dimenticato tutto il rancore che avevo provato per la vecchia. È la verità, non un complimento. Non mi dimentichi. Anzi, mi scriva dandomi sue notizie.»
«61, Goldhurst Terrace. London NW6. 11 maggio 1936.
«Carissima Nina Nikolaevna,
«non può immaginare la gioia che mi ha procurato. Per me è un piacere immenso leggere L’infanzia di P.I., da lei così brillantemente raccontata. Purtroppo non sono in grado di leggere senza interruzione. Mi ha detto che il libro sarebbe stato tradotto dalla signorina Izvolskij, ma in quale lingua? In francese o in inglese. Se non avesse già preso altri accordi, mia figlia sarebbe lieta di tradurlo. Ha appena ricevuto il Diario di P.I. e le è stato chiesto di curarne la versione. Lei tuttavia ritiene che il pubblico troverebbe il suo libro molto più interessante e io condivido il suo parere. Una metà del Diario può riuscire interessante solo per le persone che gli sono state accanto: come me, per esempio, perché sono stata una presenza nella sua vita. So che P.I. lo scriveva per sé e che non ne auspicava la pubblicazione.
«Non sapevo che, alle sue domande su P.I., lei avesse ricevuto risposte da Glazunov, Rachmaninov, Volodja Argutinskij, e anche da Volkonskij… Lui aveva simpatia per Glazunov… Volkonskij invece non gli piaceva affatto. Quanto a Volodja Argutinskij, fin dagli inizi è stato un ragazzo incantevole, e più tardi un giovanotto veramente amabile. Quando ha saputo che P.I. aveva il colera, ha lasciato la casa a precipizio ed è tornato solamente per il funerale.
«Il suo articolo su Glazunov mi è piaciuto molto. Lei tuttavia ha idealizzato il suo aspetto, il suo dono della parola. A Pietroburgo mi annoiava mortalmente. Di tanto in tanto taceva e posava lo sguardo lontano con espressione ebete, sempre velata dall’alcol. Non sapevo che fosse sposato. Ma da quando e con chi? Lei lo ha incontrato di persona?»
«47, rue de Plaisance. La Garenne (Seine). 9 maggio 1947.
«Carissima Nina Nikolaevna,
«ho letto il suo articolo su ’La Pensée russe’. L’ho trovato stupendo, mi ha fatto piangere. Sapesse quanto desidero vederla! È raro che desideri vedere qualcuno.
«Da quando l’ho conosciuta, sono passata attraverso momenti difficili e ho avuto parecchie sventure. Ora la mia vita è diventata una continua sofferenza e vedere gli amici è la sola gioia che mi resti. Non esco mai. Venga a trovarmi, carissima, la prego… Ogni tanto vado dal medico a Parigi, dove pernotto in casa di mia nipote. Gradirei vederla a tu per tu, per non essere disturbate da nessuno. Non abbia paura, per lei arrivare qui non sarà difficile. Abito nella casa di riposo che la signora Ljubimov ha riorganizzato.
«L’abbraccio forte e la saluto di gran cuore.»
Vladimir Nikolaevič Argutinskij (1874-1941), che tutti chiamavano Argo, a Parigi come a Pietroburgo, abitava in una casa del faubourg Saint-Honoré. Era un appartamento affittato prima della guerra del ’14. È stato Aleksandr Benois, il pittore e storico dell’arte che lavorò anche per Djagilev, a insistere affinché lo incontrassi. Nella risposta alla mia lettera, Argo aveva promesso di parlarmi di Bob. «Sarò ben lieto d’incontrarla», scriveva l’8 maggio 1936, «e di raccontarle quel poco ch’io ricordo di Bob Davydov.»
Vladimir Davydov, detto Bob, nato intorno al 1870 e morto suicida nel 1915, era uno dei figli della sorella di Čajkovskij, Saša, ed era pertanto nipote, nonché grande amore, del compositore, che gli dedicò la Sesta sinfonia.
Il quartiere ove abitava Argo era, anche allora, una delle aree predilette dagli antiquari e dai mercanti di quadri di Parigi. L’appartamento però aveva qualcosa di lugubre, zeppo com’era di vecchie tele, di cornici rotte, di cartelle decrepite, di stampe mezzo strappate, di quadri dalle tinte tenebrose, rose dal sudiciume e dall’umidità. Mi spiegò che da collezionista si era trasformato in rigattiere, e si scusò di ricevermi in un simile immondezzaio.
Nel 1893 aveva preso in affitto una stanza nell’appartamento di Modest Il’ič, il fratello gemello di Anatol; lì alloggiava Čajkovskij quando si recava a Pietroburgo. Era uno dei quattro uomini (gli altri erano Modest, il domestico Nikifor e Alëša, arrivato il giorno prima da Klin, ora sposato e padre di famiglia) che, servendosi di un lenzuolo sorretto ai quattro angoli, con ogni precauzione avevano immerso Pëtr Il’ič in un bagno a temperatura ambiente. Non avevano alcuna speranza di salvargli la vita, ma era l’unico modo di alleviare le sue sofferenze.
Incontrai due volte Argo. «Lui è il solo a sapere chi fosse Edouard», mi aveva detto Benois. «Glielo domandi apertamente.» Alla seconda visita, glielo domandai, ma Argo non mi rispose. Parlò soltanto di Bob e del colera.
L’ultima volta, al momento di accomiatarmi, mi disse qualche parola gentile sui capitoli già pubblicati del mio libro. Ma non volendo privarsi del piacere di un piccolo pettegolezzo, aggiunse che il principe Volkonskij, uno dei suoi vecchi amici che prima della Rivoluzione era stato per qualche tempo direttore dei teatri imperiali ed ora scriveva con regolarità le cronache teatrali per le «Dernières Nouvelles» (dunque, era un mio collega), aveva deplorato che non «uno di noi», ma una donna, scrivesse la storia del caro Pëtr Il’ič. Risposi che non era il solo a lamentarsene. Fu allora che, coraggiosamente, gli posi la domanda. Come mai, gli chiesi, i discendenti di Rimskij-Korsakov, ch’erano scampati alla Rivoluzione ed ora vivevano a Parigi da émigrés, continuavano a diffondere la versione del suicidio, come se il colera non ci fosse mai stato? La risposta fu categorica. A suo tempo, le signorine Pourgold avevano deciso che l’una avrebbe sposato Musorgskij, l’altra Čajkovskij. Di fatto, però, l’una era diventata moglie di Rimskij-Korsakov, l’altra di un certo Mollas. Maligne e gelose com’erano, note per le loro iniziative odiose e per il loro pessimo carattere, avevano diffuso quella ridicola fandonia.
Argo insistette sul fatto che anche Musorgskij – come pure Balakirev e più tardi Skrjabin – aveva il suo mistero, i problemi posti da una sessualità complessa. La vita di quelle persone diventava un inferno, senza che riuscissero a capirne alcunché. Il loro contegno, le loro letture rivelavano gusti puerili. Che cosa leggeva Čajkovskij nella sua camera all’hôtel Meurice, dopo essersi sbarazzato del giovanotto nero che aveva rimorchiato al Café de la Paix? Un romanzo del vecchio Aleksej Tolstoj che alla fine del secolo scorso era, in tutta la Russia, la lettura dei minori di quattordici anni.
Poi Argo attirò la mia attenzione su due circostanze trascurate da quanti volevano avvalorare la tesi del suicidio. La prima era l’abolizione della censura preventiva, avvenuta dopo il 1905, quando era stata pubblicata una valanga di libri proibiti, come la Gabrieliade di Puškin e Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, seguito dalle opere complete dello scrittore inglese, ivi compreso il De Profundis. Ed era altresì l’affermazione del poeta postsimbolista Michail Kuzmin che, in versi e in prosa, glorificava l’omosessualità, mentre il vecchio Vasilij Rozanov pubblicava Uomini lunari, nel quale affrontava il problema dell’«amicizia passionale» tra uomini: amicizia che nondimeno, malgrado la sua indole tenera e duratura, si poteva supporre estranea a rapporti fisici.
La seconda circostanza ricordata da Argo era la totale abolizione della censura, fatta eccezione per quella militare, ad opera della Rivoluzione del 1917. Era dunque impossibile che nell’arco di quei tredici anni – dal 1905 al 1918 – qualcuno non pensasse a pubblicare una notizia clamorosa come il suicidio di un musicista di fama universale. Sarebbe stato errato credere che, in quell’inizio del ventesimo secolo, i giornalisti di Russia e d’Europa non fossero a caccia di simili notizie.
Gli argomenti degli assertori della tesi del suicidio erano i seguenti:
1. La legge imponeva che i malati di colera venissero trasportati d’urgenza all’ospedale, perché il morbo era oltremodo contagioso. Invece Pëtr Il’ič era morto nel suo letto, a casa sua.
2. La legge esigeva che la salma fosse deposta immediatamente nella bara e che il feretro venisse prontamente sigillato, perché il contagio era trasmissibile anche per contatto col cadavere. Invece, esiste una fotografia della spoglia di Čajkovskij nella bara aperta.
3. Il suicidio andava protetto dalla più assoluta segretezza, perché la Chiesa ortodossa rifiutava la sepoltura religiosa ai suicidi, che venivano gettati nella fossa comune.
È facile smontare i tre argomenti. In Russia, negli anni 1917-1918, venivano ricoverate in ospedale soltanto le persone di modesta condizione. Gli abbienti, l’intellighenzia, gli uomini famosi, in breve tutti coloro che vivevano al di sopra della media morivano a domicilio, come a domicilio venivano operati e partorivano. Se a questo si aggiunge che i preti ortodossi, in cambio di una piccola moneta da dieci rubli lasciata scivolare nel cavo della mano, accondiscendevano a ignorare il suicidio e a celebrare esequie cristiane, il rischio di vedere un membro della famiglia gettato nella fossa comune era virtualmente nullo. Senza mancia, le cose andavano altrimenti. Ma per il mugik. Per il potentato, mai.
D’altro canto, la scoperta del bacillo del colera negli anni Ottanta (si veda la nota al termine della prefazione) aveva rivelato che il contagio si propagava attraverso le feci, e che scarichi difettosi, mancanza di fognature, presenza di latrine in vicinanza di sorgenti o lavori inadeguati di bonifica erano cause più che sufficienti per scatenare un’epidemia.
Eppure, nonostante la scoperta, malgrado la testimonianza del dottor L. Bertenson (medico degli ultimi due zar), i testimoni e i dati di fatto, la versione del suicidio di Pëtr Il’ič ha continuato a dominare la mente dei disinformati, sulla scia di affermazioni da gran tempo respinte.
Anni fa, la Oxford University Press aveva progettato di pubblicare un libro basato su nuovi elementirelativi alla morte del compositore. Nel 1966, nell’Unione Sovietica, una certa signora avrebbe appreso dalla viva voce di un certo signore – il quale a sua volta aveva appreso la cosa da un’altra signora che aveva raccolto la notizia dalle labbra del marito moribondo nel 1902 – che cinque o sei ex condiscepoli di Čajkovskij alla Scuola di Diritto si erano investiti del ruolo di suoi giudici e gli avevano proposto di ingerire una pillola per porre fine ai suoi giorni, evitando così il disonore della Russia, della musica russa e di se stesso. In punto di morte, il marito avrebbe perfino confessato d’essere stato uno di quei giudici. Senonché i giudici in questione non avevano la pastiglia sotto mano. Avrebbero promesso di portarla la mattina dopo nella casa di via Morskaja ove abitava Modest. Pertanto Pëtr Il’ič avrebbe pernottato in quell’appartamento dove l’indomani avrebbe ricevuto e inghiottito la pastiglia. Dopo averci riflettuto qualche mese, la Oxford University Press aveva rinunciato a dare alle stampe questo libro. Ma ahimè, il Grove’s, il grande dizionario della musica, ha trovato il modo d’inserire questa frottola nella sua ultima edizione.
Ecco dunque chi trova modo di accreditare un’idiozia peggio che desolante: demenziale. Perché mai Čajkovskij non avrebbe deciso di andare alla stazione e salire su un treno per Berlino, dove abitava il suo editore, depositario di tutto il suo denaro? Perché non avrebbe scelto di recarsi a Mentone o a Clarens, inviando al tempo stesso un telegramma a Modest e alla sua banda (Argo, Bob, i due fratelli Lidke) per esortarli a raggiungerlo? O ancora, dal momento che davanti a sé aveva una mezza giornata e una nottata intera, non sarebbe partito tranquillamente per l’estero, in compagnia di uno dei membri della sua «Quarta Suite», come si diceva allora a Pietroburgo? Tutti più o meno vivevano alle sue spalle, e si compiacevano di assecondarlo.
E tutto questo perché «ultimamente, rientrando dall’estero, su un piroscafo vicino a Odessa aveva conosciuto un giovinetto di quattordici anni, e […] il precettore di quest’ultimo si era affrettato a informarne il padre, il barone Steinbock-Fermor» (anzi, «Stenbok-Fermor», secondo gli autori di questa versione dei fatti). In effetti, tre anni prima, in navigazione sul Mar Nero, Čajkovskij aveva conosciuto il figlio del dottor Sklifosovskij, celebre luminare della medicina. Pëtr Il’ič ne conosceva il padre, e di quel ragazzo di diciassette anni aveva parlato a Mosca, a Pietroburgo, a Tiflis, fornendone una descrizione ad Anatol e a Praskov’ja Vladimirovna. (Sarebbe interessante stabilire se Thomas Mann avesse sentito questa storia prima di scrivere La morte a Venezia.)
Poiché l’articolo 995 del Codice penale inseriva gli omosessuali nella stessa categoria dei condannati per atti bestiali (carcere, Siberia, interdizione dal ritorno nelle città russo-europee), è facile constatare in virtù di molteplici esempi che mai in seno all’aristocrazia, nelle sfere più elevate della classe intellettuale e dell’alta borghesia delle due capitali, qualcuno sia stato costretto a subire la sorte imposta al tempo degli zar ai delinquenti del ceto medio, del proletariato operaio o contadino. Mi sono imbattuta in un’unica eccezione: quella di un uomo, docente di latino e greco in un liceo di Mosca, che negli anni Novanta era l’amante del granduca Sergej, a quel tempo governatore di quella città. Per aver avuto una relazione con un ragazzo di tredici anni, il professore era stato sottoposto a processo e condannato a tre anni di confino a Saratov. Dopo di che, peraltro, era stato reintegrato nel suo incarico. Tutti sapevano che le persone famose, se si comportavano bene, non venivano importunate, e che quanti rasentavano troppo lo scandalo venivano esortati a distrarsi e a riposarsi a Parigi: invito al quale non mancavano di ottemperare.
Gli otto o nove granduchi furono lasciati in pace. Nell’ottobre del 1917 una parte di loro si trasferì a Parigi, lasciando per sempre la Russia di Lenin. Gli altri nel 1919 furono fucilati all’interno della celebre fortezza Pietro e Paolo. Come avviene in gran parte dei paesi a regime totalitario o autoritario, esistevano due tipi di pena, l’uno per i ricchi e l’altro per i poveri. Perché la Russia avrebbe dovuto costituire un’eccezione?
Ecco, per esempio, un elenco di membri della famiglia dello zar Nicola II che non incapparono mai nell’apparato giudiziario e in quanto disposto dall’articolo 995:
Granduca Sergej Aleksandrovič, zio dello zar.
Granduca Nikolaj Michajlovič, cugino di Alessandro III. Granduca Konstantin, abbiatico di Nicola I.
Granduca Oleg, figlio di Konstantin.
Altri due figli di Konstantin.
Dmitrij, fratello di Konstantin.
Dmitrij Pavlovič, cugino germano dello zar.
Principe Jusupov, marito di una nipote dello zar.
Inoltre vari personaggi altolocati:
nella direzione dei teatri imperiali: 2;
nella direzione dell’Ermitage: 3;
attori famosi dei teatri imperiali: 4;
gruppo «Il mondo delle arti»: 4;
e per finire:
il capo redattore di una grande rivista di destra, amante del granduca Sergej e negli anni giovanili devoto ammiratore di Dostoevskij, ovverosia il principe Vladimir Mestcerskij (1839-1914).
Nel rievocare quel lontano passato, non posso non esprimere la mia riconoscenza a quanti allora mi hanno aiutato a scrivere questo libro, e che, compresi dei miei problemi, non hanno esitato a rispondere alle mie domande.
Mi riferisco agli abiatici della signora von Meck, e innanzitutto ad Adam Karlovic Benningsen, figlio di sua figlia, che mi ha invitato ripetutamente nella sua casa di Parigi come una vera amica, parlandomi non di Čajkovskij, che non aveva avuto modo di conoscere, ma della famiglia di sua nonna, di suo zio von Meck che aveva sperperato l’enorme patrimonio dei suoi genitori, e di un altro che aveva sposato una nipote di Pëtr Il’ič, sorella di quella Tanja tanto amata dal compositore. All’insaputa di tutti (ma non dello zio Pet’ja), Tanja aveva dato alla luce un maschietto ch’era stato messo a balia a Kremlin-Bicêtre per l’intervento di Čajkovskij, e che più tardi era stato adottato da Ippolit Il’ič. Poco dopo, tuttavia, Tanja si era uccisa, mentre suo padre, il famoso pianista Felix Blumenfeldt, continuava la sua brillante carriera in Russia e in tutta Europa. E ancora Mar’ja Nikolaevna Klimentova, il soprano che all’esame del conservatorio moscovita aveva cantato per la prima volta il ruolo di Tat’jana in Eugenio Onegin. Più tardi, nel 1906, avrebbe sposato Sergej Muromcev, presidente della prima Duma, brillando tra le bellezze dell’alta società di Mosca, le Konšin, le Morozov, le Ščukin, le Tret’jakov e altre. Mar’ja Nikolaevna voleva ad ogni costo che specificassi nel mio libro come lei avesse nove anni meno di Praskov’ja, ma era una bugia.
Nina Berberova, 1987
Ringrazio l’amico professor Simon Karlinski, che per primo mi ha parlato della scoperta del bacillo del colera e delle conferenze internazionali tenutesi negli anni Trenta.
IL RAGAZZO DI VETRO
ČAJKOVSKIJ
I
Si diceva che il nonno, Andrej Assier, fosse epilettico. Si diceva che il maggiore dei suoi figli, morto in giovane età, avesse ereditato la malattia paterna. Si diceva altresì che fosse un uomo istruito, capace, con preziose relazioni, che lavorava negli uffici doganali e che aveva fatto una discreta carriera. Discendente da una famiglia di emigrati francesi, era morto nel 1830, lasciando figli di due matrimoni.
La seconda delle sue figlie, Aleksandra, era una ragazza istruita e avvenente, con grandi occhi e una voce incantevole. Poco tempo dopo la scomparsa del padre aveva concluso gli studi alla Scuola delle Orfane, ove s’insegnavano la retorica, l’aritmetica, la geografia, la letteratura e le lingue straniere. Pletnëv, al quale Puškin dedicò il suo Eugenio Onegin, era stato suo insegnante di russo. Quando lasciò la scuola, tutti piansero, professori e allievi. Fu una giornata di lacrime, di sogni, di speranze. Le arpe suonarono, qualche preghiera e un Adieu vennero intonati in coro, ci fu uno scambio di ricordi…
Il’ja Petrovič Čajkovskij aveva quarant’anni, quando chiese la mano della signorina Assier. Ultimogenito dei venti figli di un borgomastro del dipartimento di Vjatka, insignito d’un titolo nobiliare nei primi anni del secolo, aveva concluso gli studi alla scuola dei Cadetti ed era funzionario. Privo di qualità brillanti, non era stato in grado di far carriera. Tuttavia l’onestà e l’indole bonaria sostituivano in lui l’intelligenza e la vivacità d’ingegno. Nel 1833 era rimasto vedovo con una figlia, Zinaida.
Non fu peraltro la dote di Aleksandra a sedurlo, e nemmeno il suo rango sociale. La sposò perché se n’era innamorato. Più giovane di vent’anni, snella, belle mani, cantava le romanze alla moda con espressiva intensità. Ma Il’ja Petrovič non aveva una spiccata inclinazione per la musica, e d’altronde nemmeno per le scienze. In gioventù qualche volta aveva suonato il flauto, ma si trattava di ricordi ormai lontani…
Nacquero dei bambini. Una bimbetta morì a Pietroburgo. Nel 1837 fu proposto a Il’ja Petrovič di assumere la direzione dei grandi stabilimenti metallurgici di Votkinsk, nella regione degli Urali. La coppia partì, lasciando Zinaida a pensione in un convento. Ed ecco Il’ja Petrovič diventare di punto in bianco il sovrano assoluto di possedimenti immensi: grandi fabbriche, una dimora vasta e confortevole, una tribù di persone di servizio, un piccolo esercito composto da un centinaio di cosacchi al suo servizio. La piccola nobiltà locale formava attorno a lui una «corte» in miniatura. La vita scorreva, calma, ospitale, semplice. Ospiti abituali erano i giovani praticanti che arrivavano da Pietroburgo, gli ingegneri inglesi che da qualche tempo avevano cominciato a installarsi in quel territorio, quasi fossero stati dei coloni.
La famiglia non tardò a ingrandirsi. Nel 1838 nacque Nikolaj; due anni dopo, il 25 aprile 1840, vide la luce Pëtr. Seguirono Aleksandra e Ippolit. Giunsero da Pietroburgo una vecchia zia e una parente nubile per dare una mano alla madre nelle sue molteplici incombenze. La casa, calda, dai soffitti bassi, odorosa di legna da ardere e di pan pepato, sorgeva in riva a un lago, circondata da grandi edifici. Nelle officine, la fusione dell’acciaio continuava giorno e notte. Ne uscivano navi, macchinari agricoli e anche, a partire dagli anni più recenti, locomotive, vagoni-cisterna, binari ferroviari. A una dozzina di chilometri scorreva la Kama, il grande fiume.
Piena di bambini, di visitatori, di personale di servizio, la casa echeggiava di mille voci diverse. La signora Čajkovskij aveva rinunciato al canto, né copiava più sul suo album le poesie sull’amore e il plenilunio. Partoriva, accudiva ai suoi piccoli, riceveva, preparava marmellate e conserve di cetrioli, si occupava dell’andamento della casa. Era lei a portare i pantaloni.
Sei mesi l’anno, la casa era sepolta dalla neve. Le camere dei bambini erano nello scantinato. Lì alloggiavano Nikolaj, il suo amico Venja e Lida, una nipotina orfana. A volte accettavano che Pëtr partecipasse ai loro giochi rumorosi. Di corsa attraversavano la casa in tutta la sua lunghezza, poi il cortile e il giardino, fino al grande cancello d’ingresso. La neve, il silenzio erano avvolti dal crepuscolo. La balia e la bambinaia si occupavano dei due piccini; Nikolaj e Venja misuravano le loro forze; Pëtr subiva i loro colpi e Lida li bombardava con una gragnola di palle di neve.
Ma dimentichiamo i giochi, basta con le attenzioni delle balie, con le corse a perdifiato attraverso la casa. Portando con sé Nikolaj, la signora Čajkovskij partì per Pietroburgo, in cerca di una governante. Occorsero tre settimane di viaggio, da Votkinsk alla capitale. Dopo due mesi d’assenza la madre ritornò. Ecco il tintinnio delle campanelle, lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli. La grande slitta si ferma davanti alla porta d’ingresso. Il’ja Petrovič, Pëtr, che ora ha quattro anni, la zia che odora di menta, i cani, il gatto, le persone di servizio, una piccola folla si fa avanti per dare il benvenuto alla signora Čajkovskij, a Nikolaj e a una sconosciuta, una donna fragile, minuta, dall’aria spaurita.
«Ecco Fanny», dice la signora Čajkovskij.
Allora Il’ja Petrovič, sempre portato ai gesti commoventi, con gli occhi umidi e la voce tremula bacia in fronte Fanny e pronuncia un discorsetto toccante per assicurarle che sente già di volerle bene come fosse una figlia, che in quel luogo sarà in casa sua, non in un paese abitato da orsi e da lupi. E Fanny lo ringrazia con grande calore, perché è giovane, è sola, è nata a Belfort, a migliaia di chilometri di distanza, e anche perché non riesce a dire Votkinsk, né tantomeno Čajkovskij.
Uno stesso corso riunisce Nikolaj, Venja e Lida. Ma non è su di loro che Fanny concentra la sua attenzione. Fin dal primo giorno lei si accorge di Pëtr – di Pierre –, di quel bimbo bizzarro, taciturno, non molto ordinato, troppo piccolo per seguire i corsi, ma che supplicava di ammetterlo nella classe e non era intenzionato a demordere. Pierre, come tutti i bambini, aveva paura del buio ed era ghiotto di dolci; ma era caparbio e ostinato. La signora Čajkovskij non sapeva se fosse il caso di accordargli quel permesso, ma Fanny la indusse a rompere gli indugi e Pëtr, come gli altri bambini, imparò il francese e le preghiere.
Era un bambino tranquillo, anche troppo, e spesso Fanny se ne preoccupava. Era peraltro dotato di viva intelligenza, e aveva molto fascino, anche se continuava a mostrarsi refrattario alla spugna e al sapone. Fanny nutriva per lui un particolare affetto, cosicché i genitori del piccolo ne furono contagiati. Un giorno la zia dichiarò ch’era straordinario e cominciò a viziarlo. Perfino la vecchia parente, la cui crescente idiozia era serio motivo d’inquietudine, faceva eccezioni a suo favore.
Le lezioni si svolgevano al mattino, e in breve tempo Fanny insegnò il francese ai bambini. Durante la ricreazione, organizzava i giochi. La vigilia dei giorni festivi, raccoglieva intorno a sé i suoi allievi, seduti sul grande divano, e si metteva a leggere, oppure li invitava a raccontare a turno delle storie. Pëtr dava prova di volontà e di immaginazione. Ricamava in versi e in prosa attorno a motivi patriottici, oppure religiosi. Nel suo cuore si affollavano sentimenti molteplici e violenti: estasi, compassione, adorazione. Un giorno, in lacrime, dichiarava il suo amore a suo padre; un altro giorno era la volta di Fanny. Adorava sua madre. L’oggetto della sua passione era talvolta Venja, talaltra Giovanna d’Arco, il gatto o anche Luigi XVII, di cui gli era stata raccontata la storia. Si esprimeva con enfasi, e nel suo quaderno abbondavano i punti esclamativi.
Gli piaceva studiare la carta geografica d’Europa: baciava con foga la grande macchia verde che si estendeva tra Varsavia e Votkinsk, e sputava sul resto. Un giorno Fanny gli disse: «Credi forse che là dove sputi la gente non creda in Dio come ci credi tu? Sputi sull’Europa, sputi sulla Francia…»
Lui sollevò il viso pallido, dal piccolo naso all’insù: «Non arrabbiarti, Fanny, ho coperto la Francia con la mano».
Le sue poesie, in russo e in francese, erano mediocri. Decisamente, non sarebbe stato un nuovo Puškin!
O Padre Immortale,
Tu mi salverai…
E in francese:
Eternel, Notre Dieu,
c’est toi qui as fait tout cela!
Erano solamente tentativi di esprimere la sua meraviglia al cospetto del mondo e del Creatore, ma soprattutto i suoi sentimenti personali. A volte sentiva il cuore traboccare d’amore e, di notte, si scioglieva in lacrime. E tuttavia quel pianto, quel desiderio di esprimersi, quell’adorazione per il mondo elargivano al bimbo un singolare sentimento di felicità. Ma anche la vita quotidiana a Votkinsk, l’atmosfera placida e serena di quella casa ove tutti lo amavano ed egli amava tutti contribuivano a nutrire la sua gioia. Nello scantinato, in quelle stanze dal soffitto basso, Fanny e i bambini conducevano una loro esistenza personale, fatta di svaghi e di lavoro. D’estate, dopo la cena che veniva servita assai presto, Fanny portava Nikolaj e Pëtr a fare una passeggiata col calesse. D’inverno, le lezioni cominciavano alle sei della mattina. All’imbrunire, ci si lasciava scivolare in slitta giù dal pendio delle montagne, fino allo specchio gelato del lago. Secondo i nuovi metodi pedagogici, Fanny esigeva che ogni mattina i bambini facessero ginnastica. Ma a Pëtr la cosa non piaceva e Nikolaj era troppo pigro. A quell’epoca era già bello, dotato di una figura agile e snella: davanti allo specchio si aggiustava i boccoli, sognando di apprendere la danza.
Quando Zinaida, lasciato il convento, arrivò a Votkinsk, Fanny, molto fiera, le presentò i fratellastri che la ragazza non conosceva ancora. Nikolaj aveva otto anni e prometteva di diventare un bel giovanotto. Pëtr, al suo fianco, abbarbicato alla gonna di sua madre, passava inosservato. Era la vigilia di Natale. Zinaida arrivava da Pietroburgo, e con lei entrò nella casa un soffio di freddo e di gelo nel quale rimase avvolta. Leggiadra, il passo lieve, recava notizie dalla capitale, segreti, gridolini di stupore, gonne alla moda, giochi per adulti molto apprezzati dai giovani che giungevano in visita. Tutto questo era meraviglioso, non meno delle amiche di Zinaida, le avvenenti fanciulle uscite da un racconto di fate.
Ma Pëtr non pensava che a una cosa: scrivere, inventare, comporre versi, per far conoscere a tutti i propri sentimenti, quei sentimenti che lo soffocavano e ai quali cercava uno sbocco.
Tes ailes dorées ont volé chez moi,
Ta voix m’a parlé…
e, in russo:
Mio Dio, concedimi d’essere buono, saggio,
E di non peccare…
Fanny guardava la sua piccola mano scorrere sulla carta, e si domandava se occorresse correggerne gli errori o lasciarlo fare, giacché avvertiva in lui la presenza di qualcosa che facilmente avrebbe potuto dissolversi, spezzarsi, se non lo si fosse maneggiato con la dovuta precauzione. Per questo prese a chiamarlo il «ragazzino di vetro». Leggendo quelle righe vergate di traverso, si sentiva ricolma di tenerezza e d’interesse, ma anche d’inquietudine. Non sapeva decidersi a confidare alla signora Čajkovskij i presagi che tanto la turbavano, e di cui peraltro ignorava la causa.
E c’era anche la pianola che Il’ja Petrovič aveva portato con sé da Pietroburgo. Pëtr l’ascoltava, la mano premuta sul cuore come a volerne reprimere il battito troppo irruente. Era la sola musica che risuonasse nella casa, e Pëtr l’aveva udita.
II
La pianola, ultimo grido in fatto di tecnica musicale, echeggiava delle sue note fantastiche. Il flauto giovanile d’Il’ja Petrovič, la gradevole voce della signora Čajkovskij non erano ormai che ricordi. Fanny dal canto suo ignorava tutto della musica; lei si occupava soltanto della salute fisica e morale dei bambini. Come in tutte le case, anche a Votkinsk esisteva un piano a coda, e a volte qualche visitatore ben disposto vi suonava una polka o un’altra danza dal ritmo vorticoso. Mai, tuttavia, un suono prodotto da mano umana aveva turbato Pëtr come quella musica meccanica. Ascoltava con una compunzione che si faceva sempre più consapevole. Fino a che, un giorno, udì l’aria di Zerlina, dal Don Giovanni, e per tutta la vita si sarebbe ricordato di quell’impressione, di quelle lacrime, della sua felicità, della sua angoscia. Non aveva ancora cinque anni.
I rulli erano svariati e numerosi: estratti d’opere di Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti. Il semplice suono valeva a commuoverlo, ma quando si arrivava a «Vedrai, carino», la «sacra estasi» s’impossessava di lui: la stessa estasi che vent’anni dopo avrebbe conosciuto, all’epoca dei primi saggi di composizione. La sua emozione si manifestava in modo così violento, che Fanny si vedeva costretta a prenderselo in collo e a portarlo nello scantinato. Ma laggiù ascoltava ancora quella musica che non era più in grado di udire. Le sue dita eseguivano nell’aria musiche immaginarie e non vedeva più nulla intorno a sé.
Spettò alla madre accostare per prima le sue mani alla tastiera e fargli eseguire le scale. Ritrovò l’aria di Zerlina e tutti vennero per ascoltarlo. Fu un misto di risate e di stupore. Dunque, Pëtr aveva orecchio musicale. La più turbata era Fanny. Ora era lei, non la madre, a domandarsi: «Non sarà troppo presto?»
Ma era impossibile allontanare il bambino dal piano, e se qualcuno lo distoglieva da esso lui continuava a tamburellare dove gli capitava, sui tavoli, sui divani, sui vetri delle finestre. Un giorno, mentre suonava un forte, ruppe il vetro, si ferì e fu punito.
Ma un’idea germinò nella mente d’Il’ja Petrovič. Fu deciso così d’invitare una certa Mar’ja Markovna, professoressa di pianoforte a Votkinsk, a dare lezioni a Pëtr. Era trascorso un anno dall’arrivo di Fanny.
Figlia di un servo della gleba, priva d’istruzione, Mar’ja Markovna aveva imparato a suonare il piano alla meno peggio. Ma suonare in pubblico non le piaceva, e in società perdeva ogni risorsa. Per tre anni diede lezioni a Pëtr, che ben presto fu in grado di leggere la musica meglio dell’insegnante. Diventarono amici. Non si sa con certezza ciò che lei gli suonava. Fanny sorvegliava quelle lezioni da vicino, e a volte si lasciava vincere dalla disperazione. Era pensabile che quel bimbetto, il suo preferito, diventasse un giorno musicista, anziché ministro o maresciallo? Lei lo supplicava di pensare un po’ meno alla musica. Passino le lezioni, dal momento che Mar’ja Markovna veniva appositamente, ma c’erano altre distrazioni per colmare le ore di svago! Fanny ne conosceva, ne inventava, dai travestimenti ai fuochi d’artificio! Se voleva proprio dedicarsi all’arte, facesse almeno il poeta. Chissà che, dopotutto, non diventasse davvero un nuovo Puškin!
Tali erano le riflessioni di Fanny; e non soltanto perché la musica la lasciava indifferente, ma soprattutto perché Pëtr ne subiva troppo l’ascendente, specie dopo le sue «improvvisazioni». Di notte tornarono le crisi di pianto, sempre più frequenti. «Ah, la musica, quella benedetta musica!» esclamava lui, nella sua insonnia.
«Macché musica, non si sente nulla», ribatteva Fanny stringendoselo al cuore. Ma il bimbo non era più in grado di sopportare quei suoni, che giungevano solamente al suo orecchio.
«Eccola, c’è, la sento!» singhiozzava, stringendosi la testa fra le mani. «Non vuol lasciarmi in pace.»
Ma durante le insonnie, le lezioni giornaliere, le passeggiate, i giochi, affiorava sempre più netta la gioia pervasa d’orgoglio di aver trovato qualcosa che da gran tempo cercava, da prima del ricordo di se stesso. La sua memoria di bimbo di sei anni scavava nelle tenebre di un passato ignoto. Ed ecco emergere, rischiararsi un quid misterioso. Poteva esprimersi in quell’insolito linguaggio sonoro. Non era più necessario darsi pensiero per una rima, preoccuparsi di un errore d’ortografia. Sentiva che quel linguaggio era accessibile a tutti, a suo padre, a Fanny. Ma ancora più importante era il fatto che, attraverso la musica, egli potesse svelarsi per intero.
Insieme con Lida e Nikolaj, Pëtr assistette al veglione. Era presente tutta Votkinsk. Le signore, per lo più giovani e belle, indossavano toilettes espressamente ordinate a Parigi. Dopo i giochi e le danze, un ufficiale polacco di passaggio a Votkinsk, giovane, brillante, buon dilettante di musica, sedette al pianoforte e suonò le mazurke di Chopin. Pëtr si sentì percorso da un fremito, lo stesso che si ripeterà per tutta la sua vita ogni qual volta sentirà la musica di Mozart. Non avrebbe mai potuto immaginarsi una delizia simile. Sperimentava una felicità, una gioia misteriosa ch’era il suo tesoro personale e di cui non doveva parlare con nessuno.
Sei mesi dopo, l’ufficiale polacco tornò. Di nuovo lo si vide sorridere alle signore, si udirono i suoi speroni risuonare per tutta la casa. Pëtr, che portava ancora le vestine di lana scozzese, con il gonnellino pieghettato e il colletto bianco, sedette sullo sgabello e gli suonò le sue due mazurke. L’ufficiale lo prese in collo, lo sollevò alto sulle braccia e lo baciò sulla testolina che conservava un profumo infantile.
Da quel giorno, Fanny decise di custodire gelosamente i vecchi quaderni di Pëtr, …