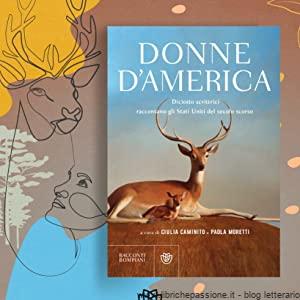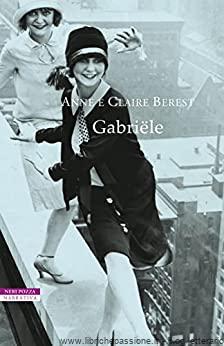Una donna si confronta con la sua infanzia segnata da un problema alla nascita: un neo bianco sulla cornea che l’ha costretta a portare per anni un grosso cerotto sull’occhio sinistro. La bambina, immersa in un universo fatto di suoni nitidi e di immagini sbiadite, sviluppa fin da piccolissima un profondo senso di estraneità nei confronti del mondo che la circonda.Sullo sfondo, il Messico degli anni Settanta, la scuola Montessori, i figli degli esuli politici e i suoi genitori in una relazione aperta. Ma poi, con gli anni Ottanta, tutto viene spazzato via: la famiglia si disgrega, il padre sparisce e la madre vola in Francia per proseguire gli studi lasciando la giovane protagonista, e il fratello, a casa di una nonna un po’ bigotta.Il corpo in cui sono nata è un commovente romanzo di iniziazione alla vita e alla letteratura, un viaggio a ritroso verso l’accettazione di sé, un Bildungsroman ambientato tra l’America Latina e l’Europa.

A Lorenzo e Mateo
Yes, yes / that’s what / I wanted, / I always wanted, / I always wanted, / to return / to the body / where I was born.
allen ginsberg, Song
1
Sono nata con un neo bianco, che altri chiamano voglia, sulla cornea dell’occhio destro. Sarebbe stata una cosa del tutto irrilevante se la macchia in questione non si fosse trovata nel bel mezzo dell’iride, cioè proprio sulla pupilla, da dove la luce penetra fino al fondo del cervello. All’epoca i trapianti di cornea sui bambini appena nati non si eseguivano ancora: il neo era condannato a rimanere lì per diversi anni. L’ostruzione della pupilla favorì lo sviluppo graduale di una cataratta, così come un tunnel privo di ventilazione si riempie di muffa. L’unica consolazione che in quel momento i medici poterono dare ai miei genitori fu l’attesa. Di sicuro, quando la loro figlia avesse terminato la fase di crescita, la medicina sarebbe progredita abbastanza da poter offrire la soluzione che allora mancava. Nel frattempo consigliarono di sottopormi a una serie di fastidiosi esercizi per sviluppare, nei limiti del possibile, l’occhio pigro. Ciò avveniva con movimenti oculari simili a quelli proposti da Aldous Huxley ne L’arte di vedere ma anche – ed è la cosa che ricordo meglio – con un cerotto che mi tappava l’occhio sinistro per mezza giornata. Era un pezzo di tela con i bordi da incollare come un adesivo. Il cerotto era color carne e mi copriva il viso dalla parte superiore della palpebra all’inizio dello zigomo. A prima vista sembrava che al posto del bulbo oculare avessi soltanto una superficie liscia. Portare quel cerotto provocava in me una sensazione di oppressione e d’ingiustizia; era difficile accettare di farmelo mettere ogni mattina e che nessun nascondiglio o pianto potesse sottrarmi a quel supplizio. Credo di aver opposto resistenza ogni giorno. Sarebbe stato così facile aspettare di essere lasciata davanti alla scuola per strapparmelo, con la stessa noncuranza di quando mi staccavo le croste dalle ginocchia. Eppure, per ragioni che ancora non capisco, non ho mai tentato di levarmelo.
Con quel cerotto dovevo andare a scuola, riconoscere la maestra e i contorni del materiale scolastico, tornare a casa, mangiare e giocare per una parte del pomeriggio. Intorno alle cinque qualcuno si avvicinava per avvisarmi che era ora di toglierlo e, con quelle parole, mi restituiva al mondo della limpidezza e delle sagome nitide. Gli oggetti e le persone con cui avevo interagito fino a quel momento mi apparivano in modo diverso. Potevo vedere da lontano e farmi sorprendere dalla chioma degli alberi e dall’infinità di foglie che la componevano, dai contorni delle nuvole nel cielo, dalle sfumature dei fiori, dal tracciato precisissimo delle mie impronte digitali. La mia vita si divideva in due universi: quello mattutino, costituito soprattutto da suoni e da stimoli olfattivi, ma anche da colori nebulosi, e quello pomeridiano, sempre liberatorio ma anche di una precisione stupefacente.
La scuola, date le circostanze, era un luogo ancora più inospitale di quanto tendano a essere le istituzioni di questo genere. Vedevo poco, ma abbastanza da sapermi destreggiare in quel labirinto di corridoi, muri di cinta e giardini. Mi piaceva arrampicarmi sugli alberi. Il mio tatto ipersviluppato mi permetteva di distinguere facilmente i rami solidi da quelli fragili, e di sapere in quali fessure del tronco potevo infilare meglio la scarpa. Il problema non era lo spazio, ma gli altri bambini. Sia io che loro sapevamo di essere diversi in molte cose e ci evitavamo a vicenda. I miei compagni di classe si chiedevano con sospetto che cosa nascondessi dietro il cerotto – doveva essere qualcosa di terribile, se bisognava coprirlo – e, non appena mi distraevo, allungavano le manine sporche di terra per cercare di toccarlo. L’occhio destro, che invece era visibile, risvegliava curiosità e sconcerto. A volte, ora che sono adulta, nello studio dell’oculista o sulle panchine di un parco mi capita ancora di incontrare uno di quei bambini incerottati e di riconoscere l’ansia caratteristica della mia infanzia, che impedisce loro di stare fermi. Per me è la prova che non si rassegnano di fronte al pericolo, e che hanno un grande istinto di sopravvivenza. Sono irrequieti perché non sopportano l’idea di vedersi sfuggire quel mondo nebuloso dalle mani. Devono esplorarlo, trovare il modo di appropriarsene. Nella mia scuola non c’erano bambini come me, ma avevo compagni con altri tipi di anomalie. Ricordo una ragazzina dolcissima che era paralitica, un nano, una bionda con il labbro leporino, un bambino con la leucemia che ci lasciò prima di finire le elementari. Condividevamo tutti la certezza di non essere uguali agli altri e di conoscere meglio la vita rispetto a quell’orda di ingenui che, nella loro breve esistenza, non avevano ancora affrontato nessuna disgrazia.
Io e i miei genitori consultammo diversi oculisti a New York, a Los Angeles e a Boston, ma anche a Barcellona e a Bogotá, dove esercitavano i famosi fratelli Barraquer. In ognuno di quei posti si ripeteva la stessa diagnosi, che risuonava come un’eco macabra, rinviando la soluzione a un ipotetico futuro. Il medico che frequentavamo più spesso esercitava presso l’ospedale oftalmico di San Diego, subito al di là del confine, dove abitava la sorella di mio padre. Si chiamava John Penteley e aveva l’aspetto di un vecchietto buono che prepara pozioni e prescrive gocce per la felicità. Forniva ai miei genitori una pomata densa che loro mi applicavano ogni mattina dentro l’occhio. Mi mettevano anche qualche goccia di atropina, una sostanza che fa dilatare al massimo la pupilla e che mi faceva vedere il mondo in modo abbagliato, come se la realtà fosse diventata la sala di un interrogatorio cosmico. Quello stesso medico consigliava anche di esporre i miei occhi alla luce nera. Per farlo, i miei genitori costruirono una scatola di legno in cui si inseriva perfettamente la mia piccola testa, illuminata da una lampadina con quelle caratteristiche. In fondo alla scatola, come in una specie di cinemascope rudimentale, si muovevano degli animali disegnati: un cervo, una tartaruga, un uccello, un pavone. L’operazione avveniva nel pomeriggio. Subito dopo mi toglievano il cerotto. Forse, detto così, può sembrare divertente, ma io la vivevo come una vera e propria tortura. Ci sono persone che durante l’infanzia sono costrette a studiare uno strumento musicale o ad allenarsi per le gare di ginnastica, io venivo allenata a vedere con la medesima disciplina che prepara altri a un futuro sportivo.
Peraltro la vista non era l’unica ossessione della mia famiglia. Sembrava che i miei genitori considerassero l’infanzia come una tappa preparatoria durante la quale si devono correggere tutti i difetti di fabbrica con cui si è venuti al mondo, e prendevano l’impresa molto sul serio. Ricordo che un pomeriggio, durante una visita, un ortopedico – che evidentemente ignorava del tutto la psicologia infantile – pensò bene di affermare che i miei muscoli ischio-tibiali erano troppo corti e che questo spiegava la mia tendenza a incurvare la schiena come se tentassi di proteggermi da qualcosa. Quando guardo le fotografie di quel periodo, mi sembra che l’incurvamento in questione sia appena percettibile nelle pose di profilo. È molto più evidente la mia faccia tesa ma sorridente, come i volti che si vedono in alcune immagini scattate da Diane Arbus ai bambini delle periferie newyorkesi. Tuttavia mia madre affrontò come una sfida personale la correzione della mia postura, alla quale si riferiva spesso con metafore animali. Quindi, a partire da allora, oltre agli esercizi per rinforzare l’occhio destro, alle mie attività quotidiane furono aggiunti gli esercizi di stretching per le gambe. Mia madre sembrava così ossessionata da quella mia tendenza a incassare la testa nelle spalle da arrivare a trovarle un soprannome o “nomignolo affettuoso” che, secondo lei, si adattava perfettamente al mio modo di camminare.
«Scarafaggio!» gridava ogni due o tre ore, «Raddrizza le spalle!» «Scarafaggino, è ora di mettere l’atropina.»
Voglio che mi dica senza troppi giri di parole, dottoressa Sazlavski, se un essere umano può uscire indenne da un simile trattamento. E se è possibile, perché non è stato così per me? A pensarci bene, non è poi così strano. Sono molte le persone che durante l’infanzia vengono sottoposte a un regime correttivo che non risponde ad altro se non alle ossessioni, più o meno arbitrarie, dei genitori:
“Non si parla così, ma in quest’altro modo.” “Non si mangia così ma in quest’altra maniera. “Non si fanno quelle cose ma queste altre.” “Non si pensa quello ma quest’altro.” Forse la conservazione della specie consiste proprio in questo, nel perpetuare, sino all’ultima generazione di esseri umani, le nevrosi degli antenati, le ferite che ereditiamo come un secondo corredo genetico.


Guadalupe Nettel è nata a Città del Messico nel 1973. Considerata una delle più importanti scrittrici latinoamericane dei nostri giorni, è autrice di due fortunate raccolte di racconti, Bestiario sentimentale (2018) e Petali e altri racconti scomodi (2019) e del romanzo best seller La figlia unica (2020) tutti pubblicati in Italia da La Nuova Frontiera. La sua carriera è costellata di importanti riconoscimenti come il premio Antonin Artaud (2008), Anna Seghers (2009), Narrativa breve Ribera del Duero (2013), Herralde de Novela (2014) e Cálamo – Otra mirada (2020).
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso