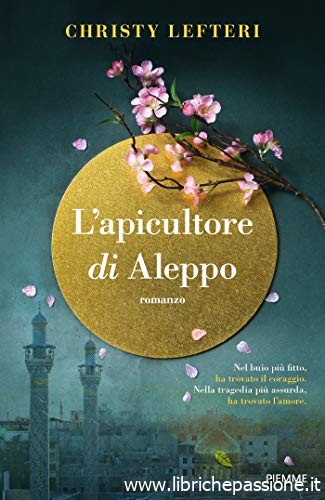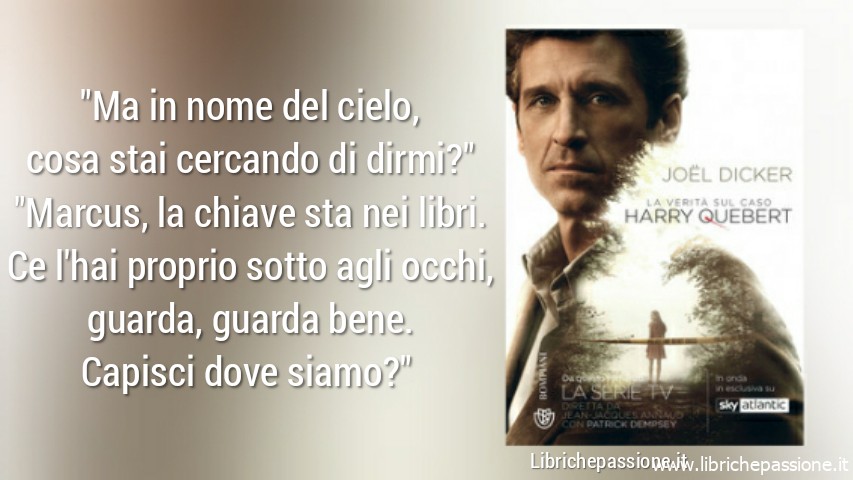Germania, 1942. Appena fuori Monaco, i prati in primavera si riempiono di fiori di campo che ondeggiano dolcemente al soffio pigro del vento. Gli occhi di Ilse si riempiono di lacrime davanti a un paesaggio che sembra non essere cambiato da quando, ancora bambina, passava lì le estati. Eppure, è convinta di aver preso la decisione giusta abbandonando la città per rifugiarsi nella casa di famiglia, insieme ai sei figli. In un luogo dove l’ombra della guerra e delle divise brune sembra non essere arrivata. Pensa di essere al sicuro, fino a quando al villaggio si presenta un bambino sporco e denutrito. Ilse si accorge subito della stella sulla camicia. Sa che offrirgli un rifugio la metterebbe contro il regime. Eppure non esita un istante a prenderlo con sé e a proteggerlo come un figlio. Lei, che ha avuto una vita difficile, riconosce chi porta le sue stesse ferite. Il fragore degli spari e delle esplosioni si avvicina ogni giorno di più. A farne le spese sono soprattutto le figlie, i suoi piccoli boccioli: Margot, la figlia maggiore, rinuncia a suonare il pianoforte per occuparsi dei fratelli e dell’orfanotrofio; Betina deve ritirarsi in convento; Violetta fantastica di avventure esotiche, ma viene derisa dai fratelli. Tutte hanno dei sogni. E sono decise a non arrendersi, nonostante a pochi passi da loro infuri una battaglia che sembra senza fine. Perché anche nei luoghi più angusti i fiori possono sbocciare. Carolina Pobla torna in libreria con una nuova saga familiare in cui le protagoniste sono donne forti, pronte a tutto per proteggere ciò che hanno a cuore. La storia di una famiglia che deve rimanere unita contro ogni avversità, affrontando le tempeste a testa alta. Perché il vento può spezzare solo chi non si sa piegare come i fiori.

Per Jutta,
una delle stelle più luminose del mio universo.
PROLOGO
La prima volta in cui mia madre accennò al fatto che lo zio Victor non apparteneva alla famiglia per nascita fu il giorno in cui ci venne comunicata la sua morte.
Era un sabato, uno di quei roventi pomeriggi tipici dell’agosto afoso di Barcellona, in cui di solito ci ritrovavamo tutti intorno al suo tavolo. Io e mia sorella andavamo sempre un po’ in anticipo per darle una mano prima che arrivasse il resto della famiglia.
La trovammo assorta davanti al computer, con lo sguardo assente e gli occhi velati. Lo zio Victor, da quanto potemmo capire, aveva avuto un infarto che se l’era portato via a settantacinque anni non ancora compiuti. Era il primo ad andarsene tra i fratelli, e la notizia sembrava aver risvegliato antichi fantasmi in mia madre.
Come se insieme a lui fossero deceduti anche i suoi segreti, di punto in bianco li rivelò tutti, senza una valida motivazione logica per farlo.
«Ho conosciuto lo zio Victor che avevo sette anni.»
«Ma che dici, mamma? Se era più grande di te. Casomai sarà stato il contrario.»
«No, piccole mie. Lo zio Victor è arrivato a casa nostra quando io avevo sette anni.»
«Era adottato?»
«Non che io sappia. Non è stato necessario. Era uno in più in famiglia, tutto qui. E non si chiamava Victor.»
Rimase per qualche secondo in silenzio con lo sguardo perso nel vuoto.
«Prima che arrivasse lui eravamo sei, poi siamo diventati sette, e dopo ancora otto. Anche se alla fine siamo tornati a essere in sette.»
«Non ha nessun senso», mormorai sorpresa. Mi alzai e andai in cucina a preparare il caffè.
Mia sorella mi raggiunse con la scusa di prendere un bicchiere d’acqua.
«Hai capito qualcosa di quello che ha detto?»
«Assolutamente no.»
«E questa storia dello zio Victor?»
«È la prima volta che la sento.»
«Credo che il dolore le abbia fatto perdere la testa.»
Ci guardammo esterrefatte. Pur non avendo mai avuto grandi contatti con lo zio Victor, gli eravamo affezionate come spesso capita con i parenti. Viveva lontano, nella sua Germania, il paese dove era nato, la patria che lo accomunava al resto dei suoi fratelli e delle sue sorelle, compresa mia madre che aveva poi deciso di venire in Spagna. Lo conoscevamo appena, ci eravamo visti di sfuggita alle sporadiche riunioni di famiglia che tenevano là e, un po’ per la distanza e un po’ per la lingua che parlavamo poco e male, ci sentivamo sempre straniere. Effettivamente, lo zio Victor aveva una fisionomia molto diversa dal resto dei fratelli, ma capita anche nelle migliori famiglie: la genetica è bizzarra. Non avremmo mai potuto immaginare che la nonna non fosse sua madre.
La morte porta sempre dolore. Soprattutto quando le conseguenze stravolgono una persona amata. E mia madre sembrava persa in un mare di ricordi che la allontanava da noi.
«Quello che non capisco è perché ci abbia tenuta nascosta una cosa del genere fino a oggi. È assurdo! In un’adozione non c’è mica niente di cui vergognarsi. Ammesso e non concesso che ci sia stata, un’adozione, ma a quanto pare no.»
«Magari all’epoca la cosa poteva avere molta più importanza di quanto ci immaginiamo.»
«È solo che mi sorprende», proseguii. «La mamma ci ha sempre parlato apertamente della sua adolescenza a Tunisi, dei viaggi fatti in gioventù, della scoperta dell’amore libero, di come è arrivata in Spagna. E su certe cose sì che, invece, avrebbe dovuto tenere la bocca chiusa!»
Ci scambiammo un sorriso complice. Se la situazione non fosse stata tragica, ci sarebbe stato da ridere.
«Adesso che ci penso… in realtà, non ci ha mai raccontato granché sulla sua infanzia.»
«Ma nemmeno noi abbiamo mai chiesto più di tanto», fui costretta ad ammettere. «Mi ricordo che le cose più entusiasmanti che ci raccontava avevano a che fare con mucche, coroncine di fiori e voli di coccinelle. Probabilmente, alla fine abbiamo perso interesse e abbiamo smesso di farle domande.»
«L’unica cosa certa è che, adesso più che mai, ha voglia di parlarne.»
«Chissà quali altri segreti ha, questa famiglia.»
Ci guardammo di nuovo. Forse era il momento di farle quelle domande.
Violetta Vila, da nubile Mahler, era nata a Monaco nell’autunno del 1936. In Spagna era in corso una guerra civile e in Germania aveva sempre più seguito un nazionalsocialismo che li avrebbe condotti alla rovina.
Mia madre aveva sempre avuto uno spirito indomito che l’aveva portata a commettere quelle che mia nonna, pentita di averle lasciato tanta libertà, chiamava «un sacco di stupidaggini» e aveva deciso di partire insieme ai suoi fratelli per l’Australia, un viaggio promosso dal governo per ripopolare il paese grazie a giovani qualificati. Aveva cambiato idea quando aveva conosciuto Santiago, mio padre, appena una settimana prima di prendere l’aereo che l’avrebbe portata dall’altra parte del mondo.
Mio padre era arrivato a Monaco con la banda della facoltà di Architettura di Barcellona, era una delle tappe programmate della loro tournée in giro per l’Europa. In quel periodo mia madre era la rappresentante degli studenti dell’Università di Monaco, dove frequentava l’ultimo anno di Odontoiatria e aveva ricevuto l’incarico di accogliere gli studenti stranieri. L’incontro era stato folgorante e decisivo.
A dispetto di quanto potesse pensare mia nonna, che se già considerava il viaggio in Australia una stupidaggine era convinta che trasferirsi in Spagna fosse pura follia, mia madre aveva terminato gli studi, fatto armi e bagagli e, pazza d’amore, era venuta a Barcellona dove le erano state promesse nozze sontuose, un matrimonio felice, una vita agiata da moglie di un architetto e una promettente carriera da dentista in un paese che lei credeva ricco di opportunità per tutti gli stranieri che volevano farlo prosperare.
Era stata una cerimonia sobria, mio padre non aveva più completato gli studi e lei non aveva mai esercitato in un paese in cui per lavorare e per avere un conto corrente o un passaporto serviva il permesso del marito, e quando aveva preso coscienza di essere l’unica in quella relazione a fare sforzi e a offrire tenerezza e rispetto erano ormai passati tredici anni e aveva già cinque figli e si sentiva molto più latina che teutonica.
Le pressioni da parte della sua famiglia non erano bastate a farla tornare in Germania.
La mamma era più tranquilla. Una bella tazza di caffè era sempre il rimedio giusto.
Avevamo deciso che i bambini non sarebbero venuti; adoravano stare a casa della nonna, ma non era il momento più adatto.
«Non lo so… Portali al cinema, o a mangiare una pizza… No, non serve dargli altre spiegazioni… Sì, che oggi la nonna non sta troppo bene, e basta…»
«Tuo marito?» sussurrò mia sorella. Annuii.
«Non credo che riuscirà a dormire, stanotte; ora come ora non ci conterei troppo», continuai. «Non lo so… La cosa l’ha colpita più di quanto potessimo immaginare… Temo che si prospetti una lunga nottata… Va bene, glielo riferirò. Dai un bacio ai bambini. E uno per te. Grazie, amore mio.»
Ci sedemmo tutte e due di fronte a lei, con l’unico intento di farle compagnia. Ci fissò immobile e ci prese la mano.
«Voi e i vostri fratelli avete avuto una gran fortuna a non dover vivere una guerra.»
Non proferimmo verbo per non interrompere i suoi pensieri.
«Io ero piccola. Per me è stato come un gioco…» rimase in silenzio e abbozzò un lieve sorriso. «Quasi sempre un gioco.»
Chiuse gli occhi come se avesse avuto bisogno di un attimo di tempo per riordinare i ricordi prima di proseguire.
«Ma i miei fratelli maggiori l’hanno vissuta in maniera diversa. Vostra nonna è stata una donna coraggiosa, che ha fatto molti sacrifici per cercare di mitigare le conseguenze di tutto quello che ci è capitato. Nonostante l’orrore della cosa, secondo me siamo stati più felici di molti altri.»
Aveva stuzzicato la nostra curiosità. Io e mia sorella dovevamo saperne di più. Eravamo a un passo, lo sentivamo, dal fascino delle grandi verità finalmente rivelate: un attimo ancora e avremmo compreso molti dei bizzarri comportamenti della nostra famiglia, quel genere di comportamenti che risalgono a un tempo remoto e si trasformano in tradizioni senza una spiegazione, come il fatto di tapparci le orecchie ogni volta che sentivamo suonare le campane, cantare a tre voci durante ogni viaggio in macchina, risolvere i litigi sedendoci uno di fronte all’altro ai due lati della porta di vetro della lavanderia, che ci permetteva di vederci ma non di sentirci, e finire immancabilmente per farci le smorfie e ridere, o goderci un temporale stando seduti in fila di fronte alla finestra di casa, contando i secondi che passavano tra il lampo di luce e il rombo del tuono per poter calcolare la distanza a cui era caduto.
«Perché non ci hai mai raccontato storie di quell’epoca?»
«Sono molte le cose di cui adesso ci vergogneremmo. Era una questione di sopravvivenza. La nostra è stata una vita meravigliosa, ma abbiamo anche perso molto per strada. Eravamo giovanissimi e ce ne siamo a malapena resi conto, ma ci è stato insegnato a calibrare le parole e a tener nascosti i pensieri. Abbiamo imparato a mantenere più di un segreto…»
Io e mia sorella ci guardammo. Poi guardammo lei, frementi.
Negli occhi di mia madre vedemmo sorridere la piccola Letta.
Sì, sarebbe stata una notte decisamente lunga.
1942
1.
Le ci era voluto molto tempo per convincersi di aver preso la decisione più saggia. Le circostanze e l’enorme responsabilità che gravava sulle sue spalle l’avevano quasi obbligata. Ma adesso, con tutti i figli e una quantità esagerata di valigie e bauli ammassati lungo la banchina deserta, iniziava ad avere dei dubbi.
Non erano passati a prenderli. C’era un solo treno che si fermava lì, ogni giorno sempre alla stessa ora. Che non ci fosse nessuno ad aspettarli non aveva alcuna logica.
«Non muovetevi di qui, torno subito. Margot, prendi il piccolo e controlla i tuoi fratelli.»
Ilse passò il neonato alla figlia maggiore ed entrò nell’edificio della stazione sperando di trovare la persona che avrebbe dovuto riceverli e portarli in quella che per i mesi successivi sarebbe stata la loro casa. Non si voltò per non dover affrontare gli sguardi timorosi, carichi di aspettative, dispiaciuti e sorpresi dei bambini. All’interno non c’era nessuno; dovette fermarsi e fare un respiro profondo per rinvigorire il coraggio declinante che minacciava di farla crollare da un momento all’altro, demoralizzata. Voleva apparire sicura, mostrare a tutti che sapeva quel che faceva e che lo faceva con convinzione, ma era una forza fittizia e in cuor suo aveva più paura dei sei figli messi insieme.
Uscì dalla stazione senza osare alzare lo sguardo per non dover fare i conti con l’eventualità che nemmeno lì fuori ci fosse qualcuno. Guardò alla sua destra e vide, in lontananza, un gruppo di case che le sembravano familiari. Era passato molto tempo dall’ultima volta che era stata da quelle parti e una gran quantità di ricordi d’infanzia le tornò improvvisamente alla memoria, ricordi felici delle piacevoli estati che aveva passato lì con la famiglia, una vita da campagnoli per gioco nell’enorme edificio che presidiava la strada principale del villaggio. Ma in quella direzione non c’era nessuno.
Guardò alla sua sinistra e no, neanche quel sentiero sterrato che risaliva la montagna serpeggiando, delimitato su entrambi i lati da muretti a secco coperti da more selvatiche in fiore, da prugnoli spinosi e cespugli di ortiche, era cambiato minimamente. Non si vedeva nessuno nemmeno da quella parte.
Guardò di fronte e tutto era verde. Verde come sempre a inizio estate. Verde come la speranza con cui era arrivata fin lì, l’unico scudo che le rimaneva e che si stava sgretolando con il passare dei minuti.
Una sensazione di calore pesante e quasi doloroso la colpì agli occhi, sensazione dovuta in parte allo sforzo di non scoppiare a piangere, e il cervello iniziò a ruminare talmente in fretta da impedirle di comprendere quell’accozzaglia di ordini contraddittori, consigli inutili ed eventuali parole di incoraggiamento e consolazione che stava offrendo a sé stessa.
«Bene, sarai contenta. Ci hai portato fin qui. E adesso?»
Una voce alle sue spalle la rimbrottò, con un tono poco appropriato al rispetto che ci si sarebbe aspettati da una ragazza ben educata. Non si prese nemmeno la briga di voltarsi a guardare Margot che, con il piccolo Tom seduto sul fianco destro e la mano posata su quello sinistro, pretendeva una risposta. Il resto dei fratelli l’aveva seguita e si era nascosto dietro di lei.
Ilse inspirò tutta l’aria che riuscì a immagazzinare per gonfiare i polmoni e poi espirò lentamente, il tempo necessario a calmarsi, per evitare di girarsi a tirare un ceffone alla figlia maggiore e a dirgliene quattro.
Guardò di nuovo alla sua destra senza però riuscire a vedere oltre il primo albero che indicava il sentiero verso il paese, ma a un certo punto distinse in lontananza una nuvoletta di polvere che aveva chiaramente fretta di arrivare.
Le lasciò il tempo.


Carolina Pobla ha studiato pedagogia all’Università di Barcellona e per più di trent’anni ha lavorato nel mondo della danza come docente, coreografa e regista. Con Garzanti ha pubblicato anche I gerani di Barcellona (2020), suo romanzo d’esordio.
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso