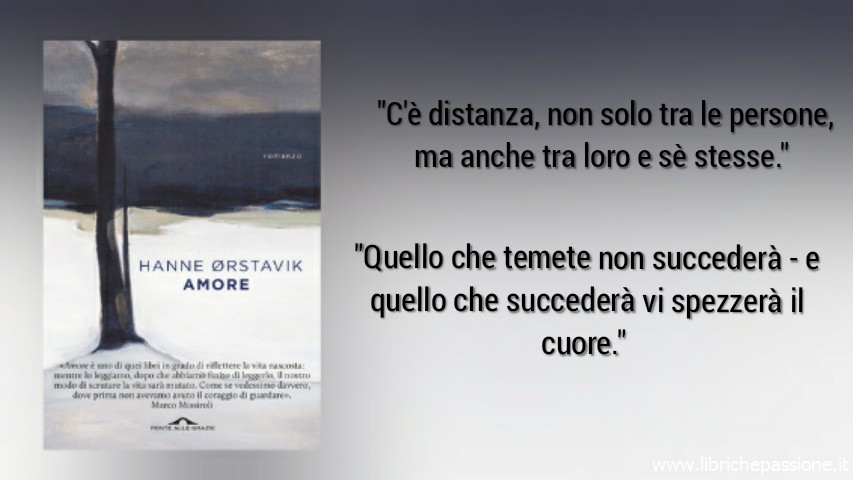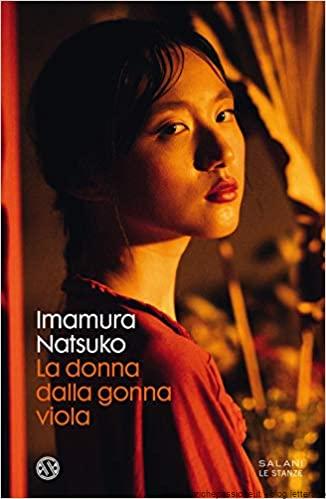Trama
Eugenia è cresciuta a Iaşi, centro culturale cosmopolita e raffinato, dove però, così come nel resto della Romania degli anni Trenta, gli ebrei iniziano a essere malvisti. Lo stesso accade nella famiglia di questa giovane studentessa di Lettere: sia i genitori che il fratello maggiore di Eugenia si lasciano contagiare dai pregiudizi razziali. Quando lo scrittore ebreo Mihail Sebastian, invitato per una conferenza all’università, viene violentemente aggredito da alcuni militanti di estrema destra, soltanto la ragazza si schiera in sua difesa; colpita da un’improvvisa presa di coscienza, che le apre gli occhi di fronte al pericoloso espandersi dell’odio razziale, si trasferisce a Bucarest, dove ritrova Mihail e finisce per innamorarsene. Mentre il malinconico scrittore, impegnato a confrontarsi con il suo ruolo di intellettuale nel contesto dell’antisemitismo crescente, è esposto a rischi sempre maggiori, Eugenia è determinata a opporsi alla barbarie e a difendere i suoi ideali di libertà: cercando di sopravvivere in un paese sconvolto dalla guerra arriverà a comprendere che l’unico modo per combattere il male è ricercarne l’origine.
Sullo sfondo di una nazione contraddittoria e affascinante, questo romanzo vede intrecciarsi magistralmente la grande storia del secondo conflitto mondiale e le vicende intime dei suoi personaggi. Traendo ispirazione dalle voci degli intellettuali che animarono la scena culturale dell’epoca, in particolare quella del brillante scrittore romeno Mihail Sebastian, Lionel Duroy firma un libro appassionante e profondo: accuratissimo nella ricostruzione storica, al tempo stesso Eugenia invita il lettore a porsi gli stessi interrogativi che qui animano la riflessione sull’origine del male portata avanti dalla protagonista, riflessione oggi più che mai necessaria.
«Il romanzo di Duroy è al tempo stesso storico, filosofico, tragico, rigoglioso, straziante, affascinante. Totale».
«L’Express»
«Il lettore di Lionel Duroy non dimenticherà facilmente Eugenia».
«Livres Hebdo»
«Lionel Duroy esplora la storia dimenticata della Romania durante la seconda guerra mondiale. Un romanzo vibrante di realtà».
«Elle»
Estratto
A Betty Mialet e Bernard Barraut,
che mi accompagnano da trent’anni
Mihail è morto ieri, il 29 maggio 1945, travolto da un camion.
È stato Andrei ad avvisarmi.
Ho alzato la cornetta pensando fosse Mihail, praticamente l’unico che mi chiamasse.
«Jana? Sono io… Temevo di non trovarti».
«C’è qualcosa che non va?».
Mio fratello cerca sempre di evitare qualsiasi scena, ma ho intuito che quella volta tratteneva a stento il pianto.
«Non hai ascoltato la radio?».
«No, stasera no. Perché?».
«Non accenderla, arrivo subito».
«No, prima mi dici cos’è successo. È Ştefan? Hanno trovato Ştefan sotto le macerie a Berlino?».
«Aspettami lì, arrivo tra dieci minuti… No, non è Ştefan».
«Allora sono mamma e papà. Dimmi subito cos’è successo, Andrei. Capito? Subito!».
«È Mihail, Jana. Mihail… Non parlerebbero dei nostri genitori alla radio. Ma non posso… Non posso dirtelo così».
L’ho sentito soffocare un singhiozzo.
«Mihail si è fatto aggredire, è questo?».
«Oh Jana… Dicono che è morto… Dicono… Aspettami, arrivo subito. Aspettami, mi raccomando».
Ho sentito sprigionarsi da me una specie di terribile latrato, lo stesso delle donne alla notizia che il marito o il figlio è stato ucciso, lo stesso della mamma quando ha saputo che Ştefan era dato per disperso, ed era qualcosa che non volevo, a nessun costo. Le donne che si piegano in due e singhiozzano, mentre gli uomini tacciono. La teatralità femminile portata ai suoi estremi. Allora d’istinto ho acceso la radio e mi sono seduta. Il mio corpo si è messo a tremare e ho incrociato le braccia per contenerlo. Una voce che ho subito riconosciuto come quella di Mircea Eliade parlava del ruolo che giocava l’incidente nell’opera di Mihail. «Il mio amico Mihail Sebastian», ripeteva, «il mio carissimo amico», con quel tono mellifluo di pentimento che ha adottato da quando la sua «carissima» Germania ha smesso di esistere. «Nell’opera di Sebastian», diceva, «si può ben notare il posto che occupa l’incontro fortuito, il caso, il felice incidente, nevvero, capace di liberare il suo personaggio dall’universo opprimente e chiuso nel quale si dibatte».
«Signor Eliade», ha ripreso il giornalista, anche lui con aria dispiaciuta, «come si può parlare di “felice incidente” in questo giorno funesto?».
«E chi vi dice che Sebastian non sperasse in questo momento! Chi vi dice che non lo aspettasse come una liberazione!».
All’improvviso fu di nuovo il Mircea sicuro di sé dei gloriosi anni della Guardia di ferro, il feroce sostenitore di Codreanu e di Hitler, la stessa persona che, una sera d’agosto del 1941, aveva sostenuto fosse «sano» che gli ebrei finalmente pagassero per tutto il male che avevano arrecato ai diversi popoli d’Europa che li avevano accolti.
«E dici una cosa simile a me, il tuo amico?», aveva replicato pacatamente Mihail.
«Dico questa cosa a Iosif Hechter, Mihail. Non sei forse Iosif Hechter, per il sangue che ti scorre nelle vene, prima di essere lo scrittore Mihail Sebastian?».
Alla fine Mihail non voleva più vederlo, e quando Eliade tornava qualche giorno a Bucarest da Lisbona, dov’era addetto culturale all’ambasciata romena, i due “amici” si evitavano.
E poi non l’ho più voluto ascoltare, e mi sono messa a girare per la mia piccola cucina. Non vedevo l’ora che Andrei arrivasse, che riempisse con la sua presenza e le sue parole il vuoto nel quale sentivo di cadere. Tuttavia le frasi di Eliade continuavano a ronzarmi in testa. Aveva ragione, ovviamente: per tutta la vita Mihail aveva sperato in un felice incontro, un felice incidente che lo tirasse fuori dalla sua malinconia. Ed è stato soltanto in quel momento, sciocca che non sono altro, che ho fatto il collegamento con il titolo del suo ultimo romanzo, ’incidente, uscito nel 1939, subito prima della guerra. Oh mio Dio! Mi sono precipitata sul libro. Era da stupidi, sapevo benissimo che Mihail non vi annunciava la sua morte, l’avevo letto e riletto, sperando al contrario di trovarci dentro ragioni per sperare in noi due. L’incidente che apre il romanzo è quello di una ragazza, Nora, che cade malamente dal predellino di un tram in una strada di Bucarest e che Paul, l’alter ego di Mihail, finisce per riaccompagnare a casa, non essendoci nessun altro disposto a farlo. Paul è terribilmente sgarbato con Nora (come Mihail lo era stato con me nei primi tempi), perché sta vivendo la fine di una tumultuosa storia d’amore con una pittrice, Ann, che lo tradisce quasi tutte le sere, lo prende in giro, ma non lo molla, come godesse nel torturarlo. Alla fine del romanzo, per quanto ancora innamorato di Ann (o almeno, questo è quel che penso io), Paul si abbandona alle braccia materne di Nora e giura che non tornerà più indietro – «mai, mai». È un epilogo penoso, un compromesso da cauto scommettitore, che non somiglia per niente all’uomo che era Mihail.
D’altronde avevamo discusso proprio di questo.
«Paul morirà di noia con Nora, e voi lo sapete bene, Mihail».
«Nora è fedele. Con lei, almeno, non soffrirà più».
«Mai, mai, lo so, l’ho letto. Ma è ad Ann che penserà facendo l’amore con lei».
«Questa cosa non c’è nel mio libro».
«No, ma c’è nella vostra testa. Non credo alla vostra morale da bravo bambino, altrimenti non vi avrei incontrato, due giorni fa, che stavate al braccio di Leny Caler, e non mi troverei di certo nel vostro letto in questo bel pomeriggio di gennaio».
Mi aveva pregato di andarmene, di rivestirmi e di lasciarlo lavorare. Era alle prese con le battute finali di La stella senza nome, la sua ultima commedia, per la quale pensava di affidare il ruolo principale, per l’appunto, a Leny Caler e voleva cercare di concluderla quella notte.
Mi sono ricordata la scena e, in uno stesso movimento di pensiero, che era morto. Non direi che me n’ero scordata, ma per un attimo ancora era stato vivo e nudo di fianco a me, con i capelli in disordine e intento a cercare le sigarette.
Stavo valutando di chiamare Leny, andare a rifugiarmi da lei a Bucarest – all’inizio mi aveva guardato dall’alto in basso, forse gelosa della mia giovinezza, o ferita di trovarmi da Mihail, per quanto lei andasse a letto con tutti gli uomini di teatro che la corteggiavano, ma alla fine ero diventata la sua «piccola Eugenia», il suo «trrrésor» (come diceva in francese) – quand’è finalmente comparso Andrei.
Mi sono avvicinata per dargli un bacio e lui, di solito così pudico, mi ha preso tra le braccia.
«Mi dispiace davvero tanto», l’ho sentito mormorare.
Poiché tremavo al punto di battere i denti, mi ha stretta più forte. Andrei è il mio fratellino, ma mi supera di una testa. Al contrario di Ştefan, il maggiore, che era basso e tarchiato come nostro padre (ecco che parlo di Ştefan al passato), Andrei è un ragazzo alto dai tratti delicati. Spesso mi dico che in lui non c’è neanche una briciola di cattiveria, nessuna volontà di fare del male, e allo stesso tempo penso che non può essere vero, tutti hanno le loro ombre, lo so bene. A meno che non sia un angelo, come lo erano Eminescu o Rilke, e che questa condizione gli risparmi le meschinerie che invece umiliano noialtri. Anche lui scrive poesie e ora che la guerra è finita spera di essere pubblicato; nel frattempo accetta volentieri gli inviti a salire su qualsiasi palco di Iaşi (in discrete condizioni dopo i bombardamenti tedeschi e l’arrivo delle truppe sovietiche) per leggere poemi di Eminescu, di Gulian o, come la scorsa settimana, le Elegie duinesi (che non conoscevo e a cui mi ha introdotto lui).
«Cosa pensi di fare, Jana?».
«Andrò a Bucarest».
«Vuoi che venga con te?».
«No, lì troverò Leny, e poi tu lo conoscevi così poco…».
“Così male”, stavo per dire.
Andrei l’aveva visto una volta sola, nel settembre del 1938 al Teatro Comœdia di Bucarest, dopo le prove generali del Gioco delle vacanze, la sua prima commedia. Allora Andrei aveva solo diciannove anni, e gli avevo proposto di accompagnarmi per farlo uscire un po’ da Iaşi, dove aveva appena passato l’estate a lavorare nel negozio dei nostri genitori. Era rimasto affascinato da Leny Caler che recitava nel ruolo principale (Mihail sosteneva di averlo scritto per lei), ma la commedia non gli era piaciuta granché, la trovava troppo “dimostrativa”.
E ovviamente non se l’era tenuto per sé.
Forse stava ripensando anche lui a quel momento, mentre mi abbracciava, perché d’un tratto l’ho sentito rianimarsi.
«Non avrei dovuto criticarlo quella sera», ha detto scostandosi leggermente, «non si fa, alla vigilia di una prima. Difatti ti ricordi che non ha detto niente? Se n’è andato verso i camerini e non mi ha più rivolto la parola per tutta la sera».
«Non ha detto niente perché pensava che avessi ragione».
«No, non credo».
«Sì, invece. Mihail non era mai soddisfatto del proprio lavoro. La commedia era magnifica e tu ti sbagliavi, ha avuto solo recensioni positive, ma lui, come te, pensava che mancasse di grazia, di poesia, che avrebbe potuto fare molto di meglio».
«Mi pento di averlo ferito».
«Era molto più severo lui con se stesso di quanto non sia stato tu, Andrei. Posso assicurarti che non lo hai ferito. La verità è che era arrivato al punto di non credere neanche più nella scrittura e questo lo lasciava senza risorse, sull’orlo del baratro. Per un periodo la scrittura l’ha salvato, pensava che fosse quella cosa tanto attesa, tanto sperata che lo avrebbe sostenuto, che gli avrebbe per sempre dato la voglia di vivere. E poi invece il miracolo non è durato. La scrittura l’ha entusiasmato quando scriveva i suoi primi romanzi, all’inizio degli anni Trenta, ben prima di dedicarsi al teatro, ma non gli ha portato nessuna tranquillità, e men che meno felicità».
«Almeno tu, però, l’hai reso felice, Jana».
«Mi piacerebbe crederlo. L’ho amato, questo sì. Lui, però, non saprei. L’unica donna che abbia davvero amato e desiderato con tutte le sue forze è stata Leny. Pensava che fosse lei il “felice incidente” che aspettava. Ma Leny non poteva essere la donna di un solo uomo, come non poteva esserlo la Ann del suo libro. Era una battaglia persa in partenza».
«Jana, nessuno è in grado di salvare qualcuno che non vuole vivere».
«Non lo so. Un tempo ho sperato di sì, ma lui mi ha scoraggiato molto presto. Era capace di dirmi delle cose orribili senza neanche rendersi conto del dolore che mi arrecava. “Vedete, Eugenia”, mi ha spiegato un giorno, “sostituendo una grande sofferenza alla mia impotenza, la guerra ha finito per allontanarmi da me stesso. Mi fornisce, proprio a me che non attendevo ormai più niente, una buona ragione per vivere: aspettare che finisca, sfuggire agli arresti, alla morte”. Quel giorno lì mi sono davvero domandata che cosa ci stessi a fare insieme a lui».
1
A distanza di tempo mi chiedo come la nostra insegnante di Letteratura, la professoressa Costinas, avesse potuto avere l’incoscienza di invitare uno scrittore ebreo all’Università di Iaşi nel 1935.
Ci aveva chiesto di leggere con attenzione il suo romanzo prima dell’incontro e io, sentendo pronunciare il suo nome – Mihail Sebastian –, non ero nemmeno stata sfiorata dall’idea che potesse essere ebreo.
Ero andata a comprare il libro ma ancora non l’avevo aperto quando mio fratello Ştefan l’aveva visto, posato sulla credenza della sala da pranzo. Io e la mamma stavamo apparecchiando la tavola. Papà era di sotto, occupato a finire i conti o a chiudere il negozio, di solito aspettava l’ultimo minuto per salire.
«Di’ un po’, mamma, adesso leggi gli scrittori ebrei?».
«Di cosa stai parlando, tesoro?».
«Di quel libro là, Da duemila anni…».
«È mio», dissi. «Ma non è uno scrittore ebreo, lo studieremo a lezione».
«Non è ebreo Sebastian? Ma vuoi scherzare?».
Girò il libro ridacchiando.
«Voglio proprio vedere… Voglio proprio vedere…», ripeté leggendo quanto era scritto sul dorso del libro.
Poi, siccome non trovava ciò che cercava, lo rimise sulla credenza senza smetterla di sghignazzare.
«Iosif Hechter! Non hanno neanche avuto il coraggio di mettere il suo vero nome, questi stronzi».
«Se fosse ebreo», mi difesi, «la professoressa Costinas ce l’avrebbe di certo detto».
«Cosa scommettiamo?».
«Tu vedi ebrei dappertutto», osservò la mamma, «ce ne sono già abbastanza così senza doverne inventare altri. Mi sorprenderebbe molto che all’università i professori raccomandassero degli scrittori ebrei».
«Iosif Hechter», ha ripetuto Ştefan.
E, alzando improvvisamente la voce:
«Vi sembra romeno, a voi, il nome Iosif Hechter?».
«Chi dice che si chiama così?», urlai a mia volta, esasperata dalla sua arroganza.
In quel mentre entrò papà, con un leggero fiatone e il sorriso sulle labbra.
«Allora, che succede in questa casa?».
«Niente di niente», tagliò corto la mamma. «Vatti a lavare le mani, la cena è pronta».
C’erano alcuni modi di mio padre che avevano il dono di irritarla, in particolare quando lui sembrava allegro, come quella sera, mentre a lei nulla dava maggior piacere che stordirlo con le sue angosce, sia sul futuro dei loro tre figli che sul negozio. Papà allora fingeva una certa gravità, le si sedeva accanto, avanzava delle soluzioni che lei si affrettava a bocciare, fino a quando non poteva che dichiararsi vinta dall’ottimismo del marito: «Alla fine, hai ragione tu», ammetteva alzandosi e ponendo fine alla discussione, «non capisco perché vedo sempre le cose così nere».
Senza lasciare a nostro padre il tempo di reagire, Ştefan era di nuovo montato su tutte le furie, gonfiando il petto e la voce:
«Succede che la professoressa Costinas, titolare della cattedra di Letteratura romena all’università – tieniti forte, papà –, adesso raccomanda ai suoi studenti la lettura di un ebreo!».
«Vorrei proprio vedere», ribatté tranquillo papà, dirigendosi verso l’antibagno.
Allora Ştefan andò a prendere il romanzo e lo sistemò con zelo alla destra del piatto di nostro padre. Mi ricordo che in quel preciso momento Andrei uscì dalla sua camera, un adolescente alto e un po’ perso, e chiese a Ştefan se fosse un regalo, senza che l’altro gli rispondesse.
Al suo ritorno, papà afferrò il libro mentre si sedeva e ci pregava di fare altrettanto (era la regola, dovevamo aspettare che i nostri genitori si sedessero prima di metterci a tavola anche noi).
«Sebastian… Sebastian…», disse, intanto che la mamma cominciava a riempirci i piatti, «ma questo è il libro che ha fatto scandalo a Bucarest! Sono mesi che i giornali parlano di questa storia. Non lo sapevi, ragazzo mio?».
«Un giudeo!».
«Assolutamente!».
«Cosa vi dicevo?».
Ştefan colpì con il palmo della mano sul tavolo, al massimo dell’eccitazione.
«Un giudeo», riprese papà, «che è stato così stupido da pubblicarlo con la prefazione del suo maestro, l’illustre Nae Ionescu, che a quanto pare fa a pezzi il libro. È quello che si dice in giro, badate, io non l’ho letto».
«Questa poi!», reagì nostra madre. «Ştefan ha ragione: non trovi assurdo che questa professoressa Costinas osi chiedere ai nostri figli di leggere un ebreo? Uno scrittore ebreo! Come se non ci fossero scrittori romeni…».
«Carmen», la riprese dolcemente papà, «ti faccio presente che dal 1919 gli ebrei residenti nella nostra terra hanno ottenuto la nazionalità romena. Su un piano strettamente giuridico, non si può più dire che…».
«Ebbene, posso assicurarvi che non la conserveranno ancora a lungo, la loro nazionalità romena!», lo interruppe Ştefan, ostentando indignazione.
«È molto probabile, ragazzo mio, è molto probabile, e penso anche che qui, a Iaşi, avremmo ogni interesse a prendere velocemente provvedimenti se non vogliamo ritrovarci sotto di loro. Leggevo l’altro giorno, su non ricordo più quale giornale, che all’ultimo censimento gli israeliti erano quasi cinquantamila, quindi già molto più numerosi di noi cristiani…».
Scrivo queste pagine a Bucarest, nell’appartamento di Leny Caler, all’indomani delle esequie di Mihail. Allora avevo solo diciott’anni, esattamente dieci in meno di oggi, ero al primo anno di Letteratura all’Università di Iaşi e sentivo per la prima volta pronunciare il nome di Mihail Sebastian – all’anagrafe Iosif Hechter (Ştefan non si sbagliava). Se allora mi avessero detto che mi sarei innamorata di un “giudeo” – così chiamavamo i pochi ebrei che frequentavano l’università sfidando il rischio di prendersi delle bastonate –, mi sarei sentita insultata. Ecco perché cerco di ricordarmi il modo in cui guardavamo agli ebrei in quel 1935. Avevamo introiettato il fatto che fossero profondamente diversi da noi: o immensamente ricchi, come i fratelli Braunstein che possedevano l’omonimo palazzo in centro città, o come la famiglia Neuschotz che teneva commerci con il mondo intero; oppure miserabili, come quelli che cercavano di sopravvivere nei sobborghi di Târgul Cucului, di Nicolina o di Păcurari. Non ci sarebbe mai venuto in mente, per esempio, di andare a passeggiare tra le stradine tortuose di Târgul Cucului dove stavano ammucchiate centinaia di famiglie ebree, alloggiate in minuscole casupole fatte di mattoni o di terra e dove genitori, bambini e bestie, per riscaldarsi, dormivano nella stessa stanza. Si diceva che quei sobborghi durante l’inverno fossero così melmosi che neanche i carretti s’arrischiavano più a entrarci, e d’estate così polverosi che l’aria era irrespirabile. Certo, tra questi due estremi si era fatta strada una classe media ebraica: medici, o commercianti come i nostri genitori. Gli ebrei possedevano in generale le orologerie, le farmacie, gli studi medici e dentistici, gli studi di fotografia, le insegne di grammofoni e di telegrafia senza fili, i negozi di strumenti musicali, le tipografie, insomma tutto ciò che aveva bisogno di solide conoscenze, mentre le calzolerie, i ferramenta, il mestiere del barbiere, o ancora le lavanderie, che richiedevano solo un breve apprendistato, erano dominio dei romeni.
Non è che gli ebrei fossero più intelligenti o raffinati dei romeni, no, questa era piuttosto la conseguenza di una legge che vietava loro di possedere della terra in un paese in cui l’economia era essenzialmente agricola, di modo che, se volevano sfuggire alla grande povertà dei sobborghi, l’unica soluzione possibile era volgersi agli studi. Il loro “successo” era in qualche modo il risultato inatteso di una misura discriminatoria. Ciò non impediva comunque di suscitare nei romeni un cupo risentimento, della gelosia, che ci si guardava però bene dall’esprimere a voce alta perché, in fondo, eravamo ben soddisfatti che il signor Finchelstein fosse stato capace di ripararci l’orologio, o che il signor Caufman, il farmacista, avesse il dono di alleviare i nostri mal di stomaco con i suoi sciroppi. I nostri genitori, che possedevano delle vigne sulla collina di Copou e gestivano un negozio di vini in strada Lăpuşneanu, una delle vie più eleganti di Iaşi, si trovavano nei confronti degli ebrei nello stesso imbarazzo. Reputavano che ce ne fossero ben troppi, che il successo di alcuni fosse offensivo, che la miseria e la sporcizia di altri fosse una minaccia per la nostra salute, che non fossimo più padroni a casa nostra, ma allo stesso tempo tacevano i loro sentimenti perché una buona fetta della loro clientela era ebrea, a cominciare dalla famiglia Neuschotz, o dal nostro vicino più prossimo, il farmacista, il signor Mayer, che salutavano ogni mattina: papà con un’esagerata bonarietà che irritava la mamma; lei in modo secco, cercando a malapena di nascondere la contrarietà che le causava la vista del signor Mayer con i suoi capelli crespi e i suoi spessi occhiali.
Certo, sapevamo bene che dal 1919 tutti questi ebrei erano ufficialmente romeni, come aveva ricordato papà, ma sapevamo anche che la Romania aveva dovuto prendere la decisione di naturalizzarli sotto le pressioni della Francia, sua grande amica, sua alleata nella vittoria del 1918 contro la Germania, e che in realtà non era il desiderio né dei nostri dirigenti né della maggior parte del popolo romeno. Per noi, quegli ebrei venuti dalla Galizia, dalla Russia, dall’Ungheria, dalla Polonia e da chissà dove ancora, che avevano invaso le nostre città senza vergogna e costruito le loro sinagoghe un po’ dappertutto, rimanevano degli ebrei, degli stranieri, e non sarebbero mai stati dei veri romeni.

Jenny