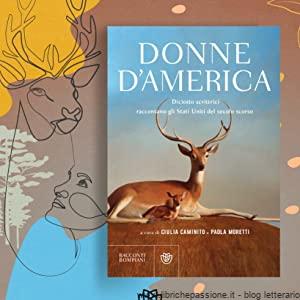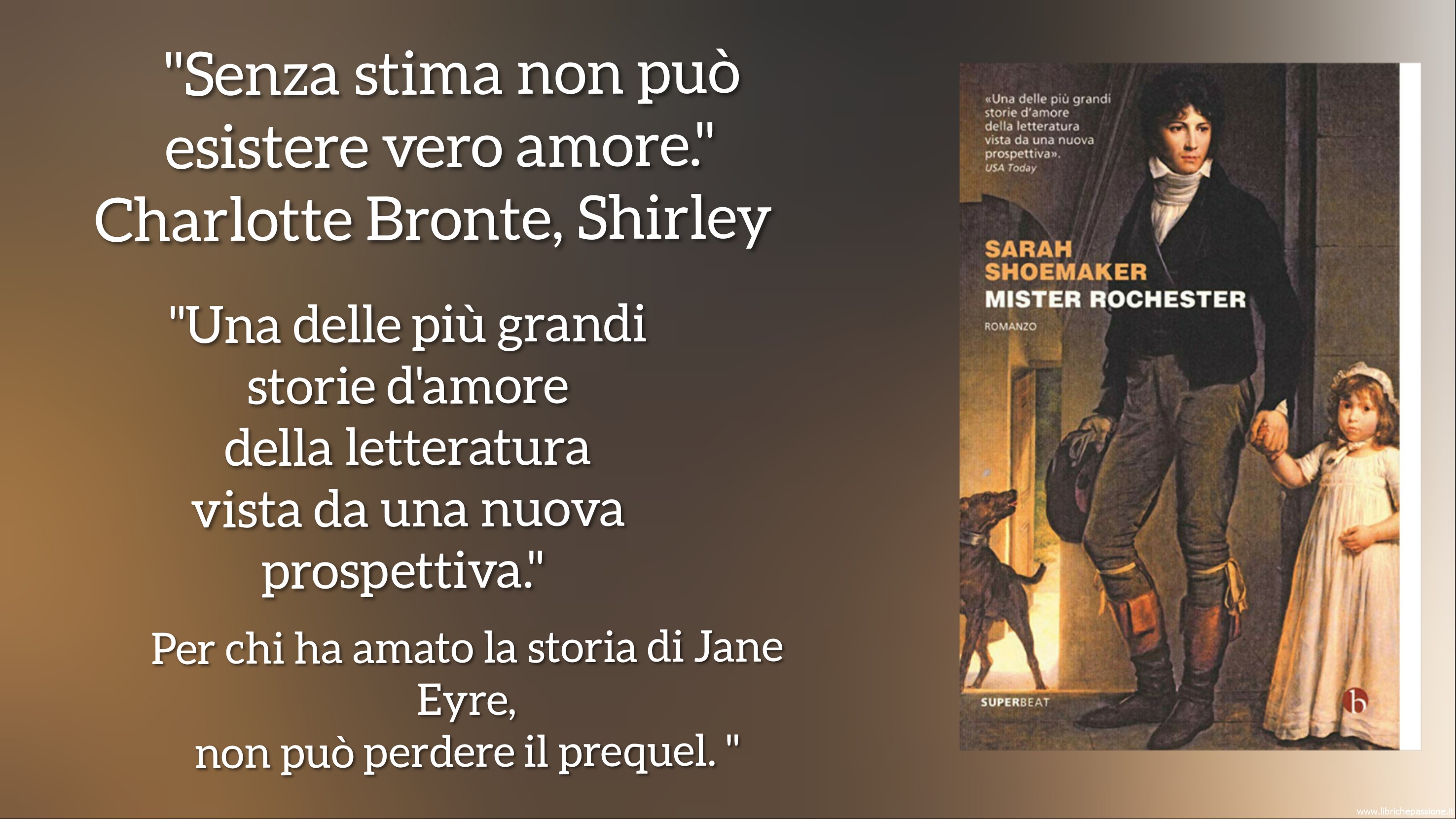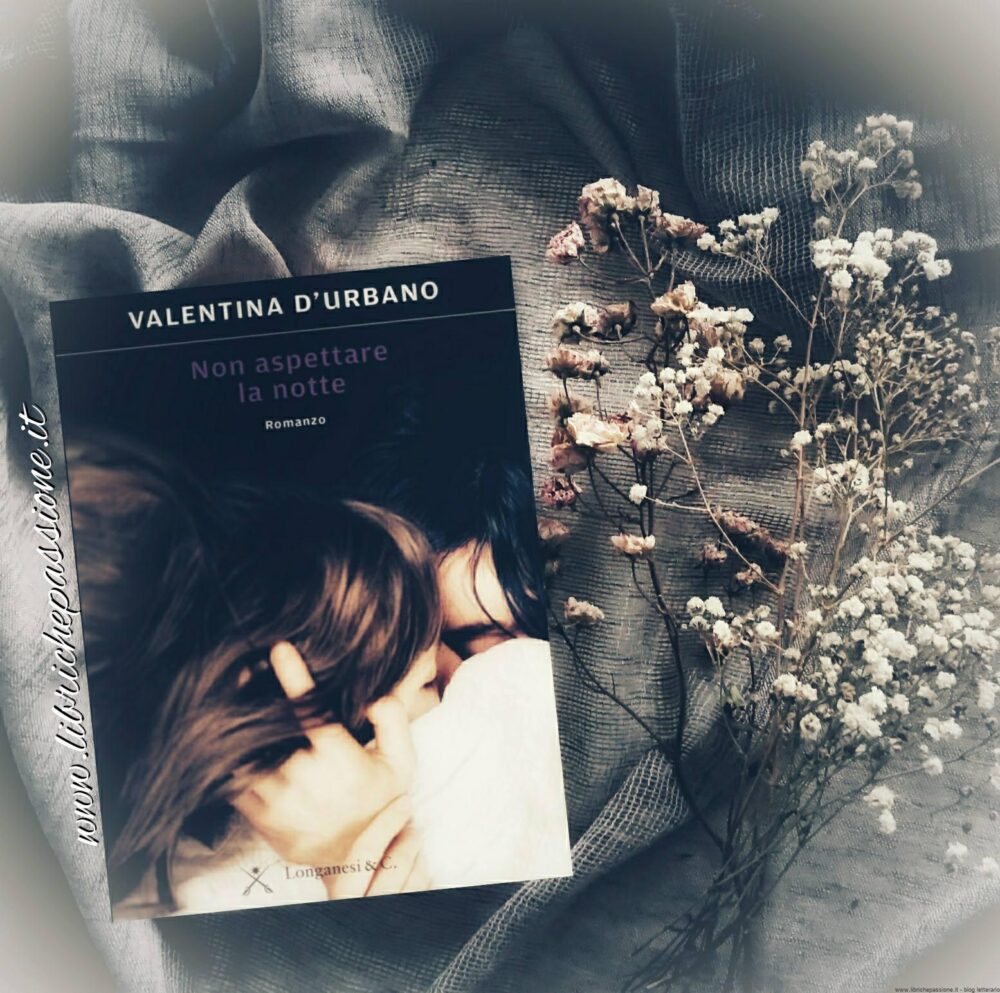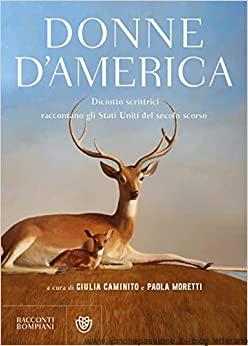

Le praterie del Sud e i quartieri neri di Harlem, le riserve degli indiani d’America e le periferie affollate da immigrati cinesi: un ritratto composito e sorprendente degli Stati Uniti al femminile del secolo scorso in una raccolta di diciotto racconti, per la gran parte inediti in Italia, per far scoprire – o riscoprire – alcune fra le più importanti scrittrici americane nate a cavallo tra ottocento e novecento. Storie di nevrosi, di maternità, di matrimoni; storie ironiche e spiritose, drammatiche e introspettive, romantiche e disilluse; storie di piccole cose e grandi sogni, di duro lavoro in fabbrica e ricerca di sé. La raccolta è accompagnata da un’introduzione alla lettura, dalle biografie delle autrici e da una cronologia.

INTANTO, LE DONNE.
UN’INTRODUZIONE
di Giulia Caminito e Paola Moretti
America la bella per i cieli spaziosi, per la maestà delle montagne viola. America la bella per i piedi dei pellegrini, terra di eroi, terra di libertà; così scrive e canta Katharine Lee Bates, ed è il 1895, mancano solo cinque anni al cambio del secolo, quel Novecento che sarà simile agli altri secoli per guerre, dolori, malattie, ma diverso per la richiesta sempre maggiore di attenzione da chi fino a poco prima non l’aveva avuta, per negligenza, per sopraffazione.
America la bella, America che è donna, per noi italiani che la guardiamo da lontano, con le bottigliette di Coca-Cola nella borsetta, la gonna spinta a mezz’aria come Marilyn Monroe, il ciuffo di capelli laccato.
America la bella, la bella donna che ci sembra sempre di conoscere, con le gambe accavallate, seduta all’angolo del bar, tutti entrano e la salutano, tutti possono dire di averne avuto un pezzo, di averne visto un seno, una coscia, un polso fino.
Eppure, a noi distanti, a noi critici, detrattori, sognatori, ammiratori, sfugge capirla fino in fondo, domandarle come mai il tacco s’è rotto per strada, in quale tombino era andato a incastrarsi; lei, quasi perdendo l’equilibrio, dov’è che stava guardando.
Tutte le chiese letterarie italiane hanno i ceri accesi presso gli altari di Jack London, di Herman Melville, di Mark Twain, di Francis Scott Fitzgerald (e molti altri); a loro si scrivono lettere d’amore, in forma di racconti e saggi, a loro si dedicano eserghi a inizio romanzo. Quanta letteratura italiana ha preso da questi uomini, dagli statunitensi, dalle loro vite morti e miracoli, per mangiarseli, farne carne della scrittura: tanta, tantissima.
E intanto le donne?
Anche questa raccolta infatti nasce da una domanda, la stessa domanda che in molte e molti ci stiamo facendo: e intanto le donne? Dove erano, cosa facevano, chi erano, cosa scrivevano, per chi scrivevano, di chi scrivevano, dove scrivevano?
È forse già una domanda ossessiva, un puntiglio, una posa, questo chiedersi delle donne del passato e chiederselo continuamente, per trovarle, andarle a stanare.
Questo fa Alice Walker nel 1973. Lei e Charlotte Hunt sono sulle tracce di una tomba, questa tomba non ha nome, si trova in un piccolo cimitero, un cimitero, pare, infestato dalle vipere, e allora le due studiose battono forte i piedi e cercano di non farsi mordere finché pensano proprio di averla trovata, la tomba. La scrittrice che vi è sepolta non aveva i soldi per il funerale e a dirla tutta neanche per quel pezzo di pietra o il cimitero. I suoi vicini di casa con una colletta le avevano almeno assicurato una fossa. La scrittrice era Zora Neale Hurston, era nera, era americana, aveva scritto tutta la vita, ma gli editori non le pagavano mai i diritti, la lasciarono presto senza niente.
Così funziona, spesso, con le donne scrittrici, che tu devi metterti degli stivali alti, al ginocchio, infilarti nell’erba, battere forte i piedi, scacciare i serpenti e avvicinarti alle lapidi, far pulizia, spostare le foglie, ripulire la pietra, riordinare il prato e segnalare il punto: è qui che la puoi trovare, io ti indico il luogo preciso, poi sta a te, lettore o lettrice, di scoprire davvero chi era.
Questo libro è un’antologia di scrittrici americane nate e vissute a cavallo di due secoli, due secoli che, se hanno stravolto l’Europa, hanno anche fondato gli Stati Uniti per come noi oggi pensiamo di conoscerli.
I cento anni che partono dal 1850 e arrivano al 1950 sono quelli in cui viene abolita la schiavitù e inizia la lotta delle donne e degli uomini neri per farsi riconoscere come cittadini americani; gli anni in cui le donne si uniscono, scioperano e fanno sit-in davanti alla Casa Bianca con tra le mani il cartello: “Signor presidente, cosa sta facendo per il voto alle donne?”; gli anni in cui il primo nativo americano diventa vicepresidente, in cui Edison inventa le lucine del Natale, in cui arrivano sempre più uragani e terremoti; gli anni della spagnola, ma anche quelli della guerra di secessione, degli scontri tra nordisti e sudisti; gli anni in cui Roosevelt viene eletto tre volte, la Statua della Libertà viene finalmente inaugurata e così l’Empire State Building; gli anni in cui nasce Martin Luther King, e quelli del Rinascimento di Harlem, quelli di Toro Seduto e della città di Chicago che va in fiamme; gli anni della Grande depressione e del proibizionismo; gli anni di Pearl Harbor; gli anni di tutto: tutto quello che ha fatto l’America.
E intanto, possiamo dirlo con certezza e senza remore, le donne c’erano e scrivevano, eccome se scrivevano.
In questo volume non sono raccolte tutte le scrittrici americane di quegli anni, ma una selezione di autrici eterogenee, con voci diversissime e sguardi a volte opposti: c’è Djuna Barnes che nacque in una casetta di tronchi vicino a Cornwall-on-Hudson, passò per il Greenwich Village di New York e approdò a Parigi; Rebecca Harding che fu tra le prime a raccontare la vita delle donne nelle ferriere; Madeline Yale Wynne che fu artista poliedrica e materica ma viene ricordata per un unico racconto, perfetto e onirico; Sarah Orne Jewett che per combattere la fatica dell’artrite reumatoide fin da bambina camminava e leggeva molto; Kate Chopin che fino agli anni sessanta del Novecento rischiò di venire del tutto dimenticata; Mary E. Wilkins Freeman che lavorava più di dieci ore al giorno alla scrittura ed è conosciuta in Italia per alcuni suoi racconti fantastici; Alice Brown che fondò un’associazione per dare informazioni a tutte quelle donne che desideravano viaggiare per il mondo da sole; Charlotte Perkins Gilman, nipote della scrittrice Harriet Beecher Stowe e autrice di uno dei racconti più memorabili della narrativa americana e non solo; Edith Wharton, nota in Italia per i suoi romanzi e come vincitrice del Premio Pulitzer, ma meno per i suoi meriti in tempo di guerra e le sue raccolte di racconti; Sui Sin Far che con intelligenza e più di un pizzico di ironia raccontò la difficoltà della comunità cinese nel riuscire ad ambientarsi nella società progressista americana; Willa Cather, donna della Virginia, cantrice eccezionale della vita del Sud, che nel suo testamento vietò la pubblicazione delle sue lettere e la riduzione teatrale delle sue opere; Virginia Tracy, attrice e sceneggiatrice di cui non si sa quasi nulla se non che suo padre era un grande attore shakespeariano, il quale venne ingiustamente fischiato dal pubblico quando dimenticò le proprie battute sul palco; Alice Dunbar Nelson che fu voce schietta della comunità nera di New Orleans, si sposò tre volte e continuò a battersi per il diritto delle donne al voto e al lavoro; Zitkála-Šá che nacque nella riserva nativa di Yankton e raccontò i primi, terrificanti, giorni dei bambini nativi nelle scuole per bianchi; Susan Glaspell, ricordata per il suo talento di drammaturga ma non per aver vissuto in una fattoria nelle zone rurali di Davenport; Jessie Redmon Fauset che sulla rivista The Crisis fece pubblicare scrittori emergenti della comunità afroamericana rendendoli poi autori noti e ripubblicati molto a lungo; Gwendolyn Bennett che venne tenuta d’occhio dall’FBI perché possibile spia comunista; e Zora Neale Hurston che finse di essere più giovane di quanto fosse per finire le scuole e che, da quando la sua tomba non è più senza nome, è tornata a essere letta ed è celebrata ogni anno a Eatonville, da un festival di letteratura e arte.
Tutte le scrittrici scelte per arricchire questo compendio di storie umanissime e senza tempo hanno trovato il proprio modo per rendere con schiettezza l’esperienza di vivere negli Stati Uniti in quegli anni. Ognuna, con una scrittura acuta e sapiente, è riuscita a rappresentare uno scorcio della multiforme realtà americana di allora.
È con una tecnica quasi cinematografica e particolarmente attenta alla psicologia dei personaggi che in Una giuria di sue pari si mette in scena un dramma poliziesco in cui sono le donne, derise e sbeffeggiate per le attenzioni che dedicano alle minuzie della vita domestica, a risolvere il caso che gli uomini di cui sono al seguito cercano invano di comprendere. In La missione di Jane viene scelta la voce di un marito sardonico e supponente, ma non insensibile all’ironia della sorte, per raccontare come l’arrivo di una figlia adottiva indesiderata sia servito a ravvivare il fuoco di un matrimonio ormai spento.
Mentre La storia di un’ora punta sull’effetto sorpresa quando, alla notizia della scomparsa del consorte, fa morire la protagonista di crepacuore, non per il dolore, quanto per la gioia di sapersi finalmente libera.
Alcune si sono affidate a un immaginario particolare, incastonando i racconti in ambientazioni che difficilmente lasceranno la memoria di chi legge, come le descrizioni cineree e plumbee dei proletari di Vita nelle ferriere, l’atmosfera decadente e bohémien di I mangiatori di loto, il fermento culturale di un’America multietnica e dinamica in La signora Spring Fragrance. Così come la poetica contrapposizione tra un mondo regolato da un codice di condotta e un mondo regolato dal rapporto con la natura raccontata in I giorni di scuola di una giovane nativa americana.
Altre hanno fatto leva sullo stile, come in Il profilo, che con la sua prosa raffinata e avvolgente mima i turbamenti interiori di un uomo particolarmente sensibile alla bellezza estetica e a quella d’animo, sposato con una donna crudele e deturpata. Madre Catherine, un racconto scritto a mo’ di appunti giornalistici, è la descrizione del luogo e dei riti sacri compiuti da un’affascinante santona di New Orleans. Mentre La donna, in un simil-pamphlet, ci elenca i motivi per cui una donna dovrebbe rimanere nubile e lavoratrice piuttosto che accasarsi.
C’è poi chi si è avvalsa della forza dei propri personaggi, e infatti non ci dimenticheremo tanto presto della moglie reclusa e spinta alla follia da un consorte manipolatore, che però nei suoi vaneggi riesce a non soccombere alla volontà altrui. O della madre che si ribella all’ennesimo tentativo del marito di anteporre i propri desideri a quelli degli altri membri della famiglia. Né del pugile nero che viveva tra i musicisti di Montmartre ed evitava i connazionali bianchi e ancor di più le donne, finché non ha incontrato quella che lo ha convinto a sposarla.
E c’è infine chi ha prediletto una struttura a cornice, dove, attraverso una voce narrante, svampita e insicura come in Mary Elizabeth o maliziosa e pettegola come in All’ospizio, vengono riportate le vicissitudini di una persona vicina e si finisce poi per parlare anche delle proprie, come in La stanzetta.
Ognuna racconta le donne attraverso occhi diversi, ipnotici, scanzonati, furiosi, dimessi, curiosi o disillusi, le racconta con wit. Umorismo, spirito, buon senso, sono tre dei significati italiani che si.
possono attribuire a questa parola inglese.
Umorismo, spirito e buon senso sono anche le caratteristiche che accomunano le vicende e le donne protagoniste di questa antologia, un viaggio per perlustrare quella che la stessa Charlotte Perkins Gilman avrebbe definito una terradilei: un’America di donne che la narrano, la scrutano, la subiscono, ma cercano di reagire agli stereotipi, agli obblighi, alle restrizioni.
Diciotto storie differenti per tema, ambientazione e stile, ma accomunate tutte da una cifra umoristica più o meno spiccata, da un’ironia più o meno velata, da uno spirito più o meno ribelle. Una costellazione, un racconto corale che speriamo faccia conoscere in Italia alcune autrici che qui non sono mai state pubblicate o alcuni racconti mai tradotti, per invogliare a non smettere mai di rispondere a quella domanda, la domanda che a volte sembra banale, ma mai lo è: e intanto le donne?
NOTA DI TRADUZIONE
di Amanda Rosso
Nell’indossare gli stivali alti e pestare sul terreno per scacciare i serpenti, ci siamo imbattute nelle parole. Nel loro imperfetto e intraducibile palpito, nella sintassi a volte nebulosa altre arzigogolata, ce ne siamo prese cura.
Anche se tradurre è per sua natura un lavoro imperfetto e mai univoco, setacciare il terriccio del linguaggio significa accettare, qualche volta, non solo i diamanti grezzi, ma anche qualche osso di pollo, un dente caduto, dell’argenteria o una rotula di gatto sepolto il secolo scorso.
Se è sempre vero che la traduzione “deve combinare la minuziosità di una formica e l’impeto di un cavallo” come ha scritto Natalia Ginzburg, lo è ancora di più con testi scritti da autrici ormai scomparse, con cui è impossibile confrontarsi, nei quali all’impeto si deve accompagnare non solo la minuziosità ma anche un’empatia attenta e rispettosa.
Di queste donne d’America abbiamo raccolto un’eredità senza testamento, solo la mappa incartapecorita di una nazione che non esiste più, con un tesoro sepolto sotto una X dove una volta passava la ferrovia e ora troneggia un altro Starbucks.
Abbiamo confezionato una coperta patchwork con l’ironia, la vulnerabilità e l’attualità che queste scrittrici hanno inciso nelle parole, rinegoziando il linguaggio di allora con la sensibilità del presente.
La traduzione, in questo caso, è stata anche un lavoro di mediazione non solo linguistica, ma culturale e sociale, un aperto confronto con le storie di chi è stata resa invisibile e ammutolita dalle maree della Storia.
Abbiamo quindi deciso, là dove l’identità del narratore non venisse chiaramente esplicitata, di assegnarvi il genere femminile, poiché è nell’ambiguità e nel maschile sovraesteso che le voci delle donne vengono erose impunemente. È una donna quindi che racconta le tragiche vicende del puddellatore Hugh Wolfe in Vita nelle ferriere e le baruffe del musicista Paul Watson in Il giorno delle nozze.
Nella loro ossessione per la bianchezza, gli statunitensi hanno creato un linguaggio ricco di identificatori razziali: colored, negro, black sono quelli che uomini e donne afroamericani hanno rivendicato nel corso della storia; spade, sambo, coon e il più tristemente noto nigger sono gli epiteti loro attribuiti da una società fortemente razzista, tutti pregni di connotazioni e sfumature differenti che possono essere rese in italiano solo attraverso l’uso di perifrasi.
Pur rivendicando l’intento di una fedeltà devota al testo originale, la traduzione contemporanea deve sia prendere atto del dibattito attorno al concetto di razza e alle rivendicazioni delle persone razzializzate, sia restare fedele alla struttura linguistica e alla collocazione sociale e cronologica del testo nella storia.
Nel racconto Il giorno delle nozze, per esempio, il protagonista viene definito “colored” dalla narratrice e “nigger” da un uomo bianco che lo infastidisce nel locale dove lavora. Viene anche chiamato amichevolmente “spade” – un termine che allora era considerato offensivo, ma molto meno di altri – da un avventore del locale. La scelta di traduzione principale è stata quella di sostituire il termine “colored” non con il più moderno – e ormai in disuso – “di colore”, ma con “nero”, e il termine “spade” con “muso nero”. Il termine offensivo “negro”, che per molti anni ha caratterizzato la traduzione italiana dell’inglese “negro”, è stato usato solo ed esclusivamente come traduzione di “nigger”, il corrispettivo più ingiurioso originatosi durante il periodo schiavista.
Allo stesso modo il termine dispregiativo “cracker” – alternativa al più noto “white trash” – è stato tradotto con “poveracci bianchi”, a sottolineare il pregiudizio del protagonista – e della società americana tout court – nei confronti dei bianchi poveri, specialmente gli abitanti delle zone rurali come gli Appalachi.
Una scelta analoga è stata quella di tradurre “indian” con “nativa” nel racconto I giorni di scuola di una giovane nativa americana dove l’autrice ha utilizzato il termine, purtroppo in voga allora, attribuito ai nativi americani da Cristoforo Colombo quando approdò nelle Americhe e pensava di aver raggiunto l’India. Ci è sembrato doveroso aggiornare la traduzione di un termine che, al di là della sua inesattezza – Indian sono le persone che provengono dall’India – è un termine considerato offensivo dalle popolazioni native degli Stati Uniti e del Canada.
Si è scelto di mantenere il termine “mulatto” – presente in Vita nelle ferriere – per rispettare la caratterizzazione socioculturale della narratrice diegetica, inserita nel contesto marcatamente razzista degli Stati Uniti del Sud di metà Ottocento.
Infine, una nota a margine deve essere dedicata alla traduzione di racconti quali La rivolta di “madre”, Mary Elizabeth, All’ospizio, Madre Catherine e Vita nelle ferriere, dove si è cercato di restituire la musicalità verace dei dialoghi più “vernacolari” senza ricadere nel macchiettistico e nel caricaturale, rielaborando la sintassi, utilizzando massicciamente l’indicativo al posto del congiuntivo, o attribuendo spiccati elementi del parlato ai personaggi di estrazione sociale più modesta. Si pensi al caso di Hugh e Deborah, immigrati gallesi analfabeti in Vita nelle ferriere, o alla Mary Elizabeth del racconto eponimo, che si esprime in un vernacolo impossibile da rendere appieno ma al quale abbiamo voluto restituire la dinamicità, il ritmo e la dignità di linguaggio, senza ricadere nell’errore comune di tradurlo semplicemente in un italiano sgrammaticato.
Tradurre non significa pacificare le brutture della storia ma, per parafrasare Umberto Eco, deve mirare a ritrovare “l’intenzione del testo, quello che il testo dice o suggerisce in rapporto alla lingua in cui è espresso e al contesto culturale in cui è nato”, a trovare un linguaggio che descriva le disuguaglianze sociali, politiche ed economiche senza attenuarle, ma con la consapevolezza di un dialogo continuo con il presente.
AMERICA THE BEAUTIFUL
O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain!
America! America!
God shed his grace on thee
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea!
O beautiful for pilgrim feet
Whose stern impassioned stress
A thoroughfare of freedom beat
Across the wilderness!
America! America!
God mend thine every flaw,
Confirm thy soul in self-control,
Thy liberty in law!
O beautiful for heroes proved
In liberating strife.
Who more than self their country loved
And mercy more than life!
America! America!
May God thy gold refine
Till all success be nobleness
And every gain divine!
O beautiful for patriot dream
That sees beyond the years
Thine alabaster cities gleam
Undimmed by human tears!
America! America!
God shed his grace on thee
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea!
Katharine Lee Bates, 1895
MADRE
Djuna Barnes
Una luce flebile sfarfallava nel negozio dei pegni sulla Ventinovesima. Di solito la padrona, Lydia Passova, sedeva nel retrobottega leggendo con quella luce: una lampada traballante con la comune copertura verde.
La testa lunga e pesante era divisa da una scriminatura di capelli lisci raccolti. Il busto lungo e compatto era reso ancora più lungo e ancora più compatto da corsetti tedeschi. Era eccessivamente alta e ciò era dovuto a gambe straordinariamente slanciate. Aveva occhi piccoli e non molto vispi. Il sinistro si era leggermente impigrito per l’uso prolungato di una lente d’ingrandimento.
Era di mezza età e molto lenta nei movimenti, anche se con un buon equilibrio. Indossava coralli alle orecchie, una collana di corallo e molti anelli di corallo. Nei suoi gioielli c’era un che della tragedia comune a tutti gli articoli che si trovavano in pegno, e si muoveva tra i vassoi come il guardiano di un cimitero che porti con sé un po’ del lugubre silenzio della terra su cui cammina.
Commerciava, perlopiù, in cammei, granati, moltissimi braccialetti intarsiati e gemelli. Tuttavia c’erano anche alcuni orologi, contenitori d’argento, equipaggiamento da pesca e pantofole scolorite; e quando di notte accendeva la lampada, questi oggetti e i vassoi di pietre preziose e semipreziose e il piccolo crocifisso d’avorio su entrambi i lati della vetrina, di colpo, sembravano condurre una vita furtiva indipendente, consapevoli della donna dal passo lento, nota nella via come Lydia Passova.
Indossava tweed e camminava con i piedi all’indentro, sembrava afflitto quando non parlava, rideva molto e lo si trovava sempre al caffè intorno alle quattro di pomeriggio.
Quando parlava lo faceva velocemente e a strappi. Aveva passato molto tempo in Europa, specialmente in posti vicino agli specchi d’acqua, e si diceva che fosse riuscito a finire nei guai a Saint-Moritz, con una famiglia influente.
Gli piaceva apparire un po’ eccentrico e gli veniva piuttosto facile in America. Non indossava un cappello e amava farsi trovare a leggere il London Times sotto un lampione nel parco alle tre di mattina.
Lydia Passova non fu mai vista con lui. Lasciava il negozio di rado, tuttavia era sempre contenta quando era lui a voler andare da qualche parte: “Vai,” gli diceva baciandogli la mano, “e quando sei stanco torna.”
Nessuno la conosceva, neanche il suo amante: un tipetto nervoso, un inglese con la parlantina marcata da un forte accento, un giovane dalla faccia rotonda con una profonda fossetta soffice nel mento su cui crescevano due ciuffi di peli gialli. Aveva gli occhi grandi e chiari, e i canini prominenti
Indossava tweed e camminava con i piedi all’indentro, sembrava afflitto quando non parlava, rideva molto e lo si trovava sempre al caffè intorno alle quattro di pomeriggio.
Quando parlava lo faceva velocemente e a strappi. Aveva passato molto tempo in Europa, specialmente in posti vicino agli specchi d’acqua, e si diceva che fosse riuscito a finire nei guai a Saint-Moritz, con una famiglia influente.
Gli piaceva apparire un po’ eccentrico e gli veniva piuttosto facile in America. Non indossava un cappello e amava farsi trovare a leggere il London Times sotto un lampione nel parco alle tre di mattina.
Lydia Passova non fu mai vista con lui. Lasciava il negozio di rado, tuttavia era sempre contenta quando era lui a voler andare da qualche parte: “Vai,” gli diceva baciandogli la mano, “e quando sei stanco torna.”
A volte lo faceva piangere. Voltandosi lo guardava un po’ sorpresa, con le palpebre abbassate, una leggera tensione nella bocca.
“Sì,” diceva lui, “lo so che sono sciocco… bene allora, ecco che vado, ti lascio, non ti disturbo più!” E sfrecciando verso la porta finiva in qualche modo a piangere con il viso nascosto nel suo grembo.
Lei diceva: “Su, su… perché sei così nervoso?” e lui rideva di nuovo: “Mio padre era un uomo nervoso e mia madre era irascibile, quanto a me…” e non concludeva.
A volte le parlava per ore, lei raramente rispondeva, occupata com’era con la lente d’ingrandimento e gli anelli, ma alla fine si assicurava di mandarlo fuori con un: “È proprio vero, non ho dubbi; ora esci per conto tuo e pensaci su,” e lui usciva, con una specie di sollievo, cingendole i larghi fianchi con le braccia piccole e forti…
AUTORI
Giulia Caminito
Giulia Caminito è nata a Roma nel 1988. Ha esordito con il romanzo La grande A (Giunti, 2016), vincitore del Premio Bagutta opera prima, Premio Berto e Premio Brancati giovani. Nel 2019, Bompiani ha pubblicato Un giorno verrà (Premio Fiesole Under 40), e nel 2021 L’acqua del lago non è mai dolce, finalista al Premio Strega e vincitore del Premio Campiello.
Paola Moretti
Paola Moretti è nata a Milano nel 1990. Ha esordito nel 2021 con il romanzo Bravissima edito da 66thand2nd. È autrice e ideatrice del podcast Phenomena – audiobiografie impossibili e i suoi racconti sono comparsi su riviste letterarie italiane e straniere.
Per acquistare il libro cliccate sul link in basso
«Questa raccolta nasce da una domanda: e intanto le donne? Dove erano, cosa facevano, chi erano, cosa scrivevano, per chi scrivevano, di chi scrivevano, dove scrivevano?».
Dov’erano le donne, mentre tutto il mondo leggeva Melville, Twain e Fitzgerald? Dov’erano le scrittrici, mentre la schiavitù veniva finalmente abolita? Dov’erano mentre Roosevelt veniva eletto tre volte? E durante gli anni del proibizionismo e quelli del Rinascimento di Harlem? Dov’erano le donne, mentre si scriveva la Storia?
Le donne ci sono sempre state. C’erano e scrivevano.
“Donne d’America”, a cura di Giulia Caminito e Paola Moretti, raccoglie i racconti, quasi tutti inediti, delle più importanti scrittrici americane del secolo scorso: da Willa Cather a Kate Chopin, da Edith Wharton a Susan Glaspell, da Alice Brown a Charlotte Perkins Gilman.