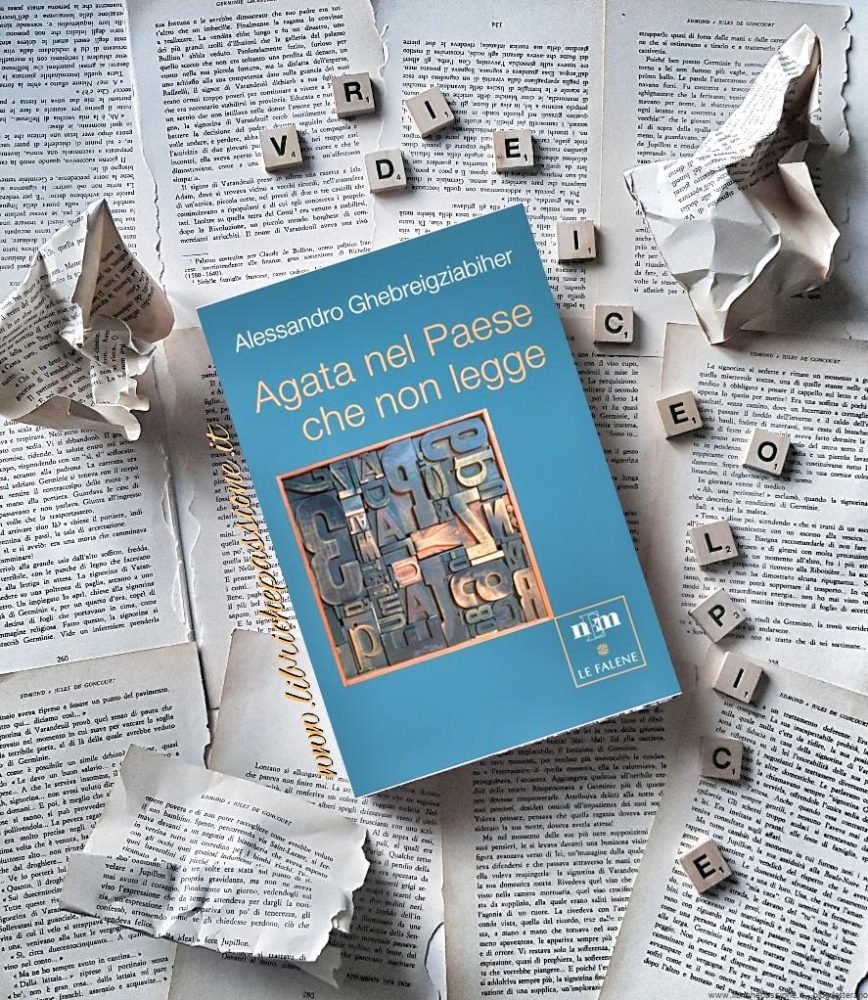«Sto per non essere carina. Sento che sta per succedere e che nessuno se lo aspetta da una sempre carina come me». Di quante vite è fatta la vita di una donna? Troppe, per perdersi ad assecondare il desiderio degli altri. Qui c’è una ragazza che avvita la caffettiera con la stessa forza con cui soffoca i sentimenti, una bambina che salta sul letto forsennata per disfare le trecce troppo strette, una donna con le scarpe sporche di calce che dirige gli operai nel cantiere della sua casa. E c’è una voce personalissima, ariosa, piena di accensioni, che sa raccontare i piccoli e grandi smottamenti, gli spigoli e i cambi di passo con la levità delle grandi scrittrici. L’esercizio più difficile è trovare la forza di dire semplicemente «questa sono io», mettere insieme i pezzi, e riconoscersi intera. Sembra una cosa ovvia, ma ogni ragazza sa che è una conquista. La bambina la cui prima parola è stata «betoniera», la studentessa che si appassiona ai numeri per amore di un surfista, la donna che scopre il desiderio di maternità dopo un incontro con le orche – sono tutte istantanee parziali, capaci di catturare l’essenza. La vita di una donna possiamo guardarla come un fiume che corre, o fermarla in corsa per saggiare ogni volta la trasformazione. È quello che fa Ester Armanino in questo libro curioso nella struttura, profondamente caldo. Un tassello dopo l’altro, il quadro si compone e il ritratto che ne viene fuori è tenacemente vivo, tridimensionale, fatto di attese, fughe, perdite, incontri, capacità di costruire, solitudine, fondamenta. E così, come in quel gioco delle sedie che si faceva da bambini, sottraendo un pezzo alla volta, il dolore può diventare una sfida alla pari, l’amore di sé – di tutte le donne che abbiamo dentro – un po’ screanzato e finalmente possibile.

stella lassú, mi vedi?
Forbicine
Sto per non essere carina. Sento che sta per succedere e che nessuno se lo aspetta da una sempre carina come me. Ma pur non essendo carina, non sarò sgarbata, e non sarò elusiva, e non sarò collerica.
Dacci un taglio con quei sorrisi carini, mi aveva suggerito il professore di greco interrogandomi molti anni fa. Poi aveva smesso di guardarmi. Fissava il registro aperto sulla cattedra aspettando una risposta, l’aoristo di quel verbo, finché con un sospiro aveva detto: vai a posto. Dal mio banco avevo sperato che mi guardasse negli occhi almeno un’ultima volta, ma niente; si era alzato con un libro in mano, aveva iniziato a spiegare Socrate, non mi aveva guardato piú. Vorrei che il mio professore fosse qui adesso.
No, rispondo.
La persona alla quale ho risposto di no vacilla nell’incredulità per un istante. Si aspettava che dicessi «sí», forse addirittura «sí volentieri», invece ho detto «no». «Sí» sarebbe stato carino, «no» è un duro colpo. Non ho nemmeno fatto seguire un «grazie» al «no», perché «no grazie» sarebbe stato appena piú carino.
Se il mio non essere carina avrà delle conseguenze, ne prenderò atto. Per adesso il mondo non è crollato e la persona alla quale ho risposto di no ha già cambiato discorso.
Sull’agenda mi sono appuntata una frase di Louise Bourgeois riferita a un disegno che aveva fatto: «Quelle forbicine che pendono da forbici piú grandi siamo io e mia madre. Mi dispiace essere cosí, ma questa sono io»
Ferramenta
Per breve tempo mi sono vista con un avvocato. Non un avvocato qualsiasi, ma uno che lavorava per il piú importante studio legale della città. Si presentava agli appuntamenti scusandosi di non essere riuscito a cambiarsi (veniva dal tribunale), io allora mi scusavo per le scarpe sporche di calce (venivo da un cantiere), ed eravamo abbastanza improbabili visti da fuori. Per questo motivo preferivo non portare ai nostri incontri anche la vera me; di sicuro qualcosa l’avrebbe irritata e io non mi sarei divertita, tutto il tempo a badare agli umori dell’una o dell’altro.
Con l’avvocato non facevamo che parlare, era sorprendente. Se ci vedevamo alle sei di sera per un aperitivo, finivamo i nostri discorsi alle due di notte sotto casa mia, e quando a un certo punto mi scappava uno sbadiglio, lui con premura diceva: devi essere stanca di parlare, non è cosí? Ed era proprio cosí. L’avvocato era capace di ascoltarmi come pochi avevano fatto prima, addirittura lo seccavano le interruzioni del cameriere che chiedeva se il signore e la signora gradissero il dessert. Tuttavia avevo sempre la sensazione di essere seduta al banco degli imputati e dovermi giustificare. Infatti poi siamo arrivati a un processo alle intenzioni perché le mie non si appaiavano alle sue. L’ultima cosa che l’avvocato mi ha detto è stata: voglio la vera te, un’altra versione non m’interessa.
Beh, ho pensato, tante grazie.
Riconosco le sue mani su un aereo pronto a decollare da Berlino, dopo che hanno allacciato la cintura e si sono posate sui miei jeans in attesa di un nuovo ordine. Le guardo con stupore, proprio come se le avessi ritrovate dopo averle perdute chissà quanto tempo fa.
Le mani della vera me sono minute, non riescono ad avvolgere nemmeno l’intera circonferenza del bicchiere del tè. È come se un giorno avessero smesso di crescere, come se avessero scelto di rimanere piú piccole per ragioni che solo loro conoscono. Per sempre misureranno diciassette per nove centimetri. Con queste mani che avevo da bambina mi tocca essere adulta.
Quando papà ci faceva le trecce e i nodi strattonavano il pettine, la vera me era quella che si riempiva di lacrime cercando una via di fuga mentre io tenevo duro, bocca serrata e testa dritta come un soldatino. Resistevo ai colpi di spazzola, alla riga in mezzo, alla divisione in sei ciocche, al compimento di ogni treccia con un nastro. Questo mio valoroso sforzo era vanificato dal piacere che la vera me provava nel disfare le trecce l’attimo dopo, saltando sul letto o pedalando sulla bicicletta in modo forsennato.
In un quaderno a quadretti di terza elementare ha ritratto tutte le croste che aveva sulle ginocchia, una specie di arcipelago della guarigione.
In una foto è seduta a leggere il suo libro preferito, Tasso asso del volo; in quei momenti non voleva essere disturbata e mia madre la difendeva dicendo: lasciatela stare, poi crescerà.
È andata proprio cosí. E non saprei dire se, crescendo, sia stata io a esiliare la vera me in quel regno ormai stretto o se piuttosto sia stata lei a perdere interesse per la mia vita in grande. Fatto sta che ritrovarla mi suscita sempre emozione. Come su quell’aereo. O come spesso accade dal ferramenta.
Stare dal ferramenta ad aspettare il proprio turno, con i clienti che dicono: ha mica qualcosa per avvitare una farfalla?, oppure: scusi, queste ruote non le avete un po’ piú quadrate?, o ancora: salve, vorrei un metro da cinque metri – questa è la piú grande passione della vera me.
A Genova abbiamo due negozi di ferramenta molto particolari.
«Fratelli Morchio», in piazza Banchi: l’unico ferramenta al mondo che fa da basamento a una chiesa. Assomiglia a una profonda cabina delle meraviglie e se entri con l’intenzione di comprare solo un appendino per gli strofinacci alla fine esci con un rotolo di carta adesiva per cassetti, una radiosveglia ad acqua, un avvitatore elettrico in offerta e una calamita potentissima.
«Pistone», in via Cairoli: le sue vetrine si alternano a quelle di un negozio di piante e cosí strumenti appuntiti e fiori si succedono in un insolito accostamento. La vetrina centrale è interamente dedicata al dio dei trapani: un arnese rosso fiammante conficcato in un blocco di cemento, circondato da ogni genere di punta, per legno, metallo e muro, potenza 850 watt, con mandrino autoserrante, azione a percussione, reversibile, fornito con 40 accessori piú borsa multiuso. Sembra un Cuore Sacro.
L’ultima volta che sono entrata da Pistone, la vera me era in coda al bancone rivestito di linoleum. Stava lí in ascolto del rumore dei chiodi sulla superficie plastificata quando ne fanno mucchietti e li incartano nelle pagine dei vecchi elenchi telefonici.
Il negoziante ha finito di servire un pensionato che doveva sverniciare una cassapanca e poi ha chiesto alla vera me di cosa avesse bisogno.
Devo svitare la paura, ha risposto lei.
Lui ha annuito con rispettosa serietà ed è sparito oltre la parete composta da centinaia di cassettini pieni di piccoli oggetti metallici e non. Dopo un po’ è tornato con una bomboletta. Le ha mostrato come inserire il beccuccio e le ha detto di fare gocciolare il liquido nella paura, di attendere qualche minuto, e poi svitare.
Il bello è che dal ferramenta ti prendono sempre sul serio.
La vera me se n’è andata soddisfatta con il suo pacchettino mentre io sono rimasta accucciata in un angolo, con quelle mani minute che accarezzavano la testa dei martelli, a riflettere sulle parole di quel saggio: colui che rinuncia a un regno conservando se stesso non rinuncia a niente.
Avevo un amico architetto, ci frequentavamo e lui mi piaceva. Un pomeriggio si è seduto nella mia cucina, è diventato improvvisamente serio e mi ha detto: sono innamorato di te.
In quel momento avrei voluto la vera me al mio posto. Perché se l’avesse detto a lei, forse saremmo andati dritti a sposarci nella chiesa sopra al ferramenta. Invece c’ero io – io che avvito le caffettiere con la stessa forza con cui soffoco i sentimenti e dopo non riesco piú ad aprirle.
Gli ho chiesto gentilmente una mano e lui ha aperto la caffettiera senza sforzo. Mentre aspettavamo che il caffè salisse mi si è avvicinato e mi ha abbracciato, come per consolarmi della delusione che ero stata per entrambi.
Un giorno, avrò avuto sedici anni, con mia madre abbiamo preso l’autobus e siamo scese alla fermata di via Fieschi, dove c’era ancora il negozio della Olivetti. Ha insistito per regalarmi una macchina da scrivere e io ne ho scelta una pesante che odorava di ferro e inchiostro, una Lettera 35. Ce la siamo portata a casa tenendo una maniglia della sporta ciascuna e la gente ci guardava provando a immaginare che cosa stessimo trasportando di cosí pesante.
In un biglietto di compleanno mia madre mi ha scritto che se avessi lasciato in pace la vera me in molti sarebbero stati felici, compresi i miei libri, Auguri! Ma’.
Ho pesato la macchina da scrivere. Ho fatto come a volte si fa per pesare i cani e i bambini piccoli: mi sono pesata io stessa, prima con l’Olivetti in braccio e poi senza. Cinque chili e mezzo di differenza. Quarantatre tasti, ottantasei segni. Manca il tasto del numero 1 che si fa con la «i» maiuscola.
Per ora accontentati, ho detto alla vera me. Lei faceva saltellare le dita sui tasti come giocosi capretti, non ho mai visto mani piú felici di cosí.


Ester Armanino è architetto e vive a Genova. Il suo primo romanzo Storia naturale di una famiglia (Einaudi 2011) ha vinto il Premio Kihlgren Opera Prima, il Premio Viadana Giovani, il Premio Zocca e il Premio per la Cultura Mediterranea – sezione Narrativa giovani.
Per acquistare il libro clicca sul link in basso