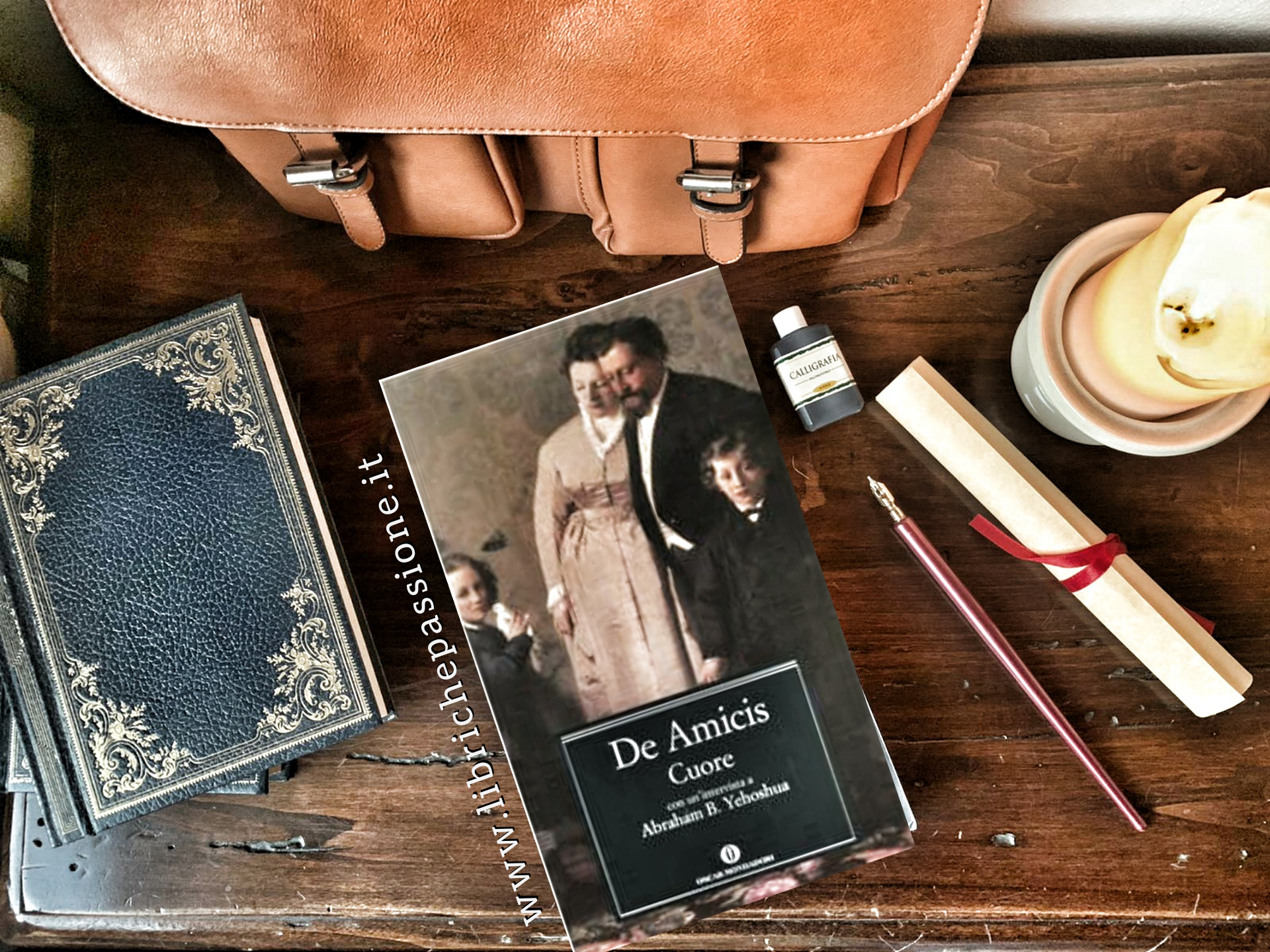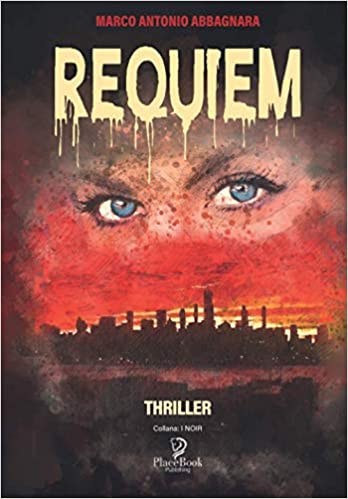Sinossi
Il ragazzo corre nella notte d’inverno, sotto la pioggia, scalzo, coperto di sangue non suo. Chiamiamolo L.B. e avviciniamoci a lui attraverso gli anni e gli eventi che conducono a quella notte. A guidarci è la voce di una giovane donna brusca, solitaria, appassionata di letteratura, e questo romanzo è memoria e cronaca del confronto con la scomparsa del padre, con ciò che è rimasto di un legame quasi felice nell’infanzia felice da figlia di genitori separati, poi fatalmente spinoso, e con la tardiva scoperta della vicenda giudiziaria che l’ha visto protagonista. Chi era quello sconosciuto, L.B., il giovane sempre dalla parte dei vinti, il medico operaio sempre alle prese con qualcuno da salvare, condannato al carcere per partecipazione a banda armata? E perché di quel tempo – anni prima della nascita dell’unica figlia – non ha mai voluto parlare? Testimonianze, archivi e faldoni, ricordi, rivelazioni lentamente compongono, come lastre mescolate di una lanterna magica, il ritratto di una persona complicata e contraddittoria che ha abitato un’epoca complicata e contraddittoria.Torino è il fondale della lotta politica quotidiana con le sue fatiche e le sue gioie, della rabbia, della speranza e del dolore, infine della violenza che dovrebbe assicurare la nascita di un avvenire radioso e invece fa implodere il sogno del mondo nuovo generando delusione e rovina. Il romanzo di un uomo, delle sue famiglie, delle sue appartenenze, la sua vita visitata con amore e pudore da una figlia per la quale il mondo si misura e si costruisce attraverso la parola letta e scritta.
Al ragazzo
“Di tutto l’uomo non resta che una parte del discorso. In genere, una parte. Parte del discorso.”
Iosif Brodskij
“Non basta rifiutare la Legion d’onore: bisogna inoltre non meritarla.”
Erik Satie
Martingala (s.f.): jouer à la –, giocare raddoppiando sempre la posta perduta nel colpo precedente.
I
LA PRIMA KITEŽ
Questa storia ha due inizi: almeno due, perché, come tutto quello che ha a che fare con la vita, è sempre difficile stabilire cosa cominci e quando, quale vertigine di casi fortuiti esista dietro ciò che sembra avvenire all’improvviso, o quale viso si è girato verso un altro in un momento del passato dando il via alla catena accidentale di eventi e di creature che ci ha portato a esistere. Innanzitutto – questo posso dirlo con discreta certezza – sono nata. Era marzo e nevicava, e l’anno era il 1987. I miei genitori si erano incontrati solo un paio di anni prima e si sarebbero separati definitivamente tre anni dopo.
Sono nata da una donna con un buco in testa. Mia madre aveva avuto un incidente tredici anni prima. Rimasi una settimana sotto osservazione perché ero in astinenza dagli antiepilettici che lei era ancora costretta a prendere. Dell’incidente, del coma, delle operazioni le è rimasto soltanto un lieve avvallamento nel punto in cui manca un frammento di cranio, sostituito da una rete di metallo coperta poi nel tempo dai suoi capelli fini, di piuma. Dorme sempre dall’altro lato, perché le fa ancora male la testa che non c’è.
Si può dire che da quel buco bene o male sono scaturita. La mia stessa esistenza dipende dalla ferita, porta aperta sul baratro delle possibilità. Quando mia madre è caduta da una motocicletta guidata da un altro, a ventitré anni, era in viaggio con lui per ritirare dei documenti che sarebbero serviti per il loro matrimonio. Non è andata poi così. Ed ecco che in un certo senso la traiettoria di mia madre non ancora tale, della giovinetta dal viso appuntito delle foto dell’epoca, del suo corpo scagliato sull’asfalto di una strada provinciale, ha tracciato una nuova traiettoria irreversibile da cui poi sarebbe emersa la mia.
Il secondo inizio della storia, anche se allora non ne avevo la minima idea, coincide con l’autunno dei miei ventisei anni, quando lasciai la casa e la città dove avevo passato tutta la vita e andai a vivere a Milano. Abitavo in un monolocale al terzo piano di un palazzo degli anni venti. Aveva il pavimento di legno e una piccola cucina bianca incastonata in un angolo ed era invaso dalla luce fino a sera – una cosa che più tardi avrei trovato opprimente, ma non in quel momento. Era il primo posto che fosse soltanto mio e mi era caro quasi come un affetto umano.
Durante la settimana ero sola. Uscivo la mattina presto e andavo in giro per la città senza una meta precisa. Erano i primi giorni di settembre, e dopo un’estate fredda e piovosa una canicola tardiva si riversava sui viali ancora silenziosi. Appena voltato l’angolo della mia via, in un’altra strada che portava il nome aereo del Beato Angelico, si sentiva talvolta da un balcone molto in alto un canarino che cantava nella quiete ronzante, e dallo scroscio di quel verso – quel verso inconfondibile che somiglia al suono della parola “i-r-r-o-r-a-r-e” ripetuto fino ad aprirsi in un acuto prolungato – sapevo ancora riconoscere che si trattava di un malinois (e per un attimo l’ombra tenera della voliera dove io e mio zio controllavamo i nidi quando ero bambina si allungava sul marciapiede, con il suo odore verde e profondo). Nell’aria immobile gli edifici deserti delle facoltà scientifiche nel quartiere dove abitavo sembravano abbandonati da millenni. Camminavo anche per tutto il giorno, inoltrandomi per le strade a caso, e solo di tanto in tanto prendevo il cellulare per controllare sulla mappa dove fossi finita. La città mi era completamente estranea e anche io lo ero a lei, e questo in un certo senso era rassicurante.
A volte l’aria si muoveva per un’improvvisa apertura di vento. Allora le chiazze delle nubi scorrevano sui frontespizi delle case isolando per un momento un dettaglio in una pozza di luce: un balcone di ferro battuto, una bocca urlante sul capitello di un abbaino. Il colore delle facciate cambiava, tremolava e poi si fermava di nuovo. Mi sedevo a leggere sulle panchine all’ombra. Nei giardini di Porta Venezia una giovane donna reggeva all’altezza del petto un bambino piccolo con un cappellino di cotone, voltato verso un albero. Il bambino, i piedi penzoloni, esaminava il tronco con interesse, le palme aperte appoggiate sulla corteccia. Lei sorrideva appena, un sopracciglio inarcato, come se conoscesse un segreto. Quando capitava che prendessi la metropolitana per tornare indietro da un appuntamento serale passavo da una via dove le grandi finestre ad arco dell’Istituto di studi chimici emanavano luce ambrata nel buio dietro le fronde scure e dense degli olmi. Una volta, in una viuzza dietro piazzale Loreto, passai davanti a una lavanderia automatica dove c’erano tre giovani marinai di aspetto slavo. Ci guardammo attraverso la vetrina con la stessa espressione stupita, come se la mia presenza fosse altrettanto inverosimile della loro. Marinai russi in una lavanderia automatica milanese! Scrollai le spalle – così è prescritto in questi casi – e ripresi a camminare.
Come raramente era successo prima di allora, poteva passare un’intera giornata senza che parlassi con qualcuno. In quel mutismo totale e prolungato, allo stesso modo di quei rumori notturni che nel silenzio appaiono più netti, le cose che guardavo acquistavano una strana nitidezza, ma restavano immagini sparse, scollegate tra di loro e prive di qualsiasi significato apparente che andasse al di là dell’interesse passeggero che mi avevano suscitato sfilandomi davanti agli occhi. Per quel breve bagliore, forse, una parte infinitesimale della mia testa percepiva che esse si producessero in me in una qualche misura; ma quella percezione di una percezione di una percezione era così pallida, così lieve, che subito svaniva, e le immagini rimanevano a fluttuare su un fondale indistinto, sempre più esangui. Non pensavo nemmeno che potesse esistere una relazione tra me e quelle cose, o di quale natura potesse essere.
Tutto in verità sembrava riguardarmi assai poco. Avevo un po’ di denaro a disposizione perché mi era arrivata una piccola eredità, il che mi permetteva di vivere ancora per qualche mese senza uno stipendio fisso, con le mie entrate minime e irregolari, in attesa che la situazione si sbloccasse. Perché doveva sbloccarsi, non poteva essere altrimenti. La crisi era un’entità astratta, fumosa, certo irritante ma che non poteva avere davvero un effetto a lungo termine sulla mia vita. Bastava aspettare. Così aspettavo. Di mestiere leggevo dattiloscritti in inglese e in francese per la narrativa straniera di una grande casa editrice. Dovevo valutarli per un’eventuale pubblicazione italiana. Era un lavoro quieto, e anch’io finalmente ero quieta.
La solitudine era una dimensione nuova; come una cattedrale completamente vuota in cui ogni passo aveva un’eco sproporzionata. Bisognava muoversi con cautela, e non prestare troppa attenzione a tutti quegli echi, all’amplificazione di ogni sussurro sotterraneo.
L’ autrice
Marta Barone è nata e vive a Torino. Traduttrice e consulente editoriale, ha pubblicato tre libri per ragazzi.