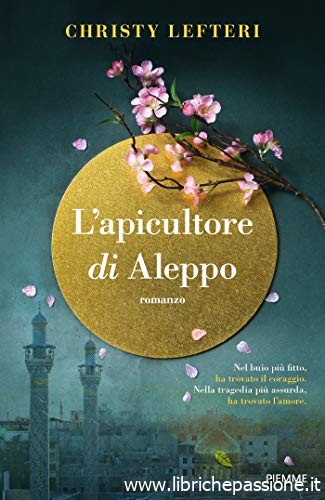Disponibile dal 14 Ottobre 2022


Ispirato a una toccante storia vera
1939. Quando i nazisti invadono la Polonia, la famiglia della piccola Danusha è costretta ad abbandonare la sua casa. La madre, Anna, cambia nome e si assicura un posto come governante nella villa di un medico tedesco a Cracovia: vicinissima al pericolo, spera di tenere la famiglia al sicuro. Il salotto al piano terra della grande casa, infatti, ospita cene e ricevimenti a cui partecipano gli ufficiali nazisti…
L’identità segreta dovrebbe proteggere Danusha e il fratellino, ma li costringe a una solitudine senza scampo. Anna, infatti, ha paura che la bambina prima o poi possa tradirsi e limita i suoi contatti con gli altri. Danusha non riesce a capire perché sua madre, in presenza di altre persone, faccia persino fatica a guardarla negli occhi. Solo con il passare degli anni, quando Anna si lascia andare ai ricordi di quel periodo così buio, Danusha capisce che sua madre ha nascosto dolore e apprensione dietro un’apparente freddezza. E che non ha mai smesso, neppure per un secondo, di vegliare su di lei…
Nemmeno quando proteggerla ha significato mettere a repentaglio la propria vita.
L’orrore della guerra visto attraverso gli occhi di una bambina ebrea
«Serve un grande coraggio per scrivere come Malka Adler: senza ammorbidire, senza abbellire, senza lasciare spazio all’immaginazione.»
Yehudith Rotem, Haaretz, Israel News
«Storie come questa devono essere raccontate. Si rimane catturati dal racconto della vita di Danusha, nel percorso che la porta finalmente a trovare la propria identità.»
«Un romanzo appassionante, che commuove perché è facile immedesimarsi nella piccola Danusha e nel suo desiderio di essere amata.»

Questo libro è dedicato a mio marito Dror,
che per me c’è sempre.
Prologo
La cosa più difficile fu quando i russi entrarono a Cracovia.
Accadde alla fine della guerra, dopo che il dottor Helmutt Sopp se n’era andato. Si era trasferito a vivere all’ospedale di Cracovia, dove lavorava. La mamma disse che era la cosa migliore per lui, e che ormai il nazismo era finito, proprio come un brutto film. Lei lo chiamava professore, anche se era un semplice medico. Era psichiatra e ufficiale nell’esercito di Hitler, ma non professore. Lo capii dalle lettere che spediva alla mamma a guerra finita, quando noi già vivevamo a Haifa. Sulle buste c’era scritto:
DOTT. HELMUTT SOPP
A parte il titolo, quando ancora abitavamo con lui ricordo che tutti lo chiamavano “Herr Doktor”. Per noi era stato il salvatore: era il direttore e il diretto responsabile della mamma a Cracovia. Ai miei occhi era alto, prestante, e una brava persona.
La mamma era stata governante a casa Sopp per due anni.
L’avevano assunta con dei documenti speciali procurati da Lydia, sorella maggiore di mamma. Aveva mantenuto il nome Anna, cambiando invece il cognome in Kwiatkowski, un nome polacco che poteva salvare gli ebrei dalla morte. Grazie ai documenti di Lydia e al lavoro della mamma in casa Sopp, avevamo ottenuto una stanzetta in cui stare senza temere la sorte atroce che poteva toccarci in qualsiasi momento, giorno dopo giorno, anno dopo anno.
Quando venimmo a sapere che i russi erano davvero vicini a Cracovia, nuove istruzioni cominciarono ad arrivare a casa Sopp, in città. Toni, la moglie di Helmutt, partì per la Germania assieme ai figli, Peter e Ammon. Noi rimanemmo in casa con Helmutt Sopp per un altro paio disettimane; poi, a causa della nuova situazione, come mi spiegò la mamma, anche Helmutt andò via e si stabilì all’ospedale.
Eravamo da soli nella grande e lussuosa casa, senza più i consueti ricevimenti e senza la protezione dei coniugi Sopp, e poi sentimmo alla radio che la guerra era finita.
Un giorno – era febbraio – arrivarono i padroni di casa polacchi. Accadde dopo la liberazione, con i russi già nelle strade di Cracovia, dove giravano ubriachi, oppure ballavano il loro kazachok come forsennati. Questi nuovi padroni dissero che la casa apparteneva a loro, che c’erano dei documenti a dimostrarlo. Ci permisero di rimanere fino a quando la mamma non avesse trovato un altro alloggio. Lei li ringraziò e ci comunicò con gli occhi di andare nella nostra stanza e di non fare rumore. I nuovi proprietari, marito e moglie, con una figlia più grande di me, si stabilirono nell’ala padronale. La mamma, io e mio fratello piccolo, che aveva poco più di un anno meno di me, scomparimmo nella stanza della servitù, adiacente alla cucina.
Io avevo otto anni, arrivavo all’altezza della maniglia della porta, ero alta ed esile. Yashu aveva quasi sette anni, la mamma ne aveva quaranta ed era bellissima.
Un giorno sentii la ragazzina polacca chiedere a suo padre: «Come si scrive tedesco, con la maiuscola o la minuscola?»
«Tutte le nazionalità si scrivono con la maiuscola, cara», le rispose, «tranne ebreo. Ebreo si scrive con la minuscola».
«Grazie, papà», replicò la ragazzina in tono educato, e riprese a scrivere sul quaderno.
Ricordo di aver capito in quel preciso momento che tutte le altre nazioni, nessuna esclusa, erano ostili, e che non aveva alcuna importanza se la guerra era finita, come dicevano dappertutto. Mi dissi, bene, Danusha, non vali niente, tanto per cambiare.
Mi resi conto poi che c’era un mondo fatto di tante nazioni, e che io ero dall’altra parte, dove era meglio stare nascosta. E, soprattutto, capii che io e la mia mamma avevamo la lettera minuscola e che non contavamo niente.
Ci rimasi molto male. Questa volta mi sentii inutile a livello universale, una sensazione che mi bruciava in gola e mi tappava il naso, sull’orlo del pianto. Nemmeno lo specchio che tanto mi piaceva servì a farmi sentire meglio. Ero una bambina molto tranquilla e educata, con gli occhi azzurri e i capelli biondo scuro; che carina, dicevano le persone per farmi un complimento. Mi sentivo a disagio con la nuova occupante della casa e non mi aiutava il fatto di saper leggere in due lingue a sei anni, e neppure che Frau von Dorf, l’insegnante di pianoforte di Bad Pyrmont, mi avesse detto che ero molto portata per la musica.
Ricordo che tutto iniziò nella nostra famigliola. Solo papà era stato felice della mia nascita, ma se n’era andato quando io avevo cinque anni, e se la mamma aveva deciso che una bambina era inutile, allora per noi contava solo questo.
Una buona madre sogna di avere un figlio maschio come primogenito, non una femmina. Era convinta che le sarebbe nato un maschietto e che avrebbe avuto l’aria e il portamento di un aristocratico ufficiale polacco, come altri nella sua famiglia, prima della guerra. Alle sorelle raccontava che il suo primogenito sarebbe stato molto alto e affascinante, non un Hassid, uno studioso, come era stato suo nonno. La mamma desiderava un figlio che avrebbe cavalcato un nobile destriero, come l’aveva visto in sogno, e di lui parlava a bassa voce nel tinello con le sue quattro sorelle. Aharon, il fratello più piccolo, era disperso in guerra. Ma qual era il sesso forte, a quei tempi? Gli uomini si nascondevano, o scomparivano nel fumo e nel vento, e le donne sopravvivevano. Chi poteva sconfiggere la mia mamma? Nessuno, e nemmeno le sue quattro sorelle, più forti della Rocca di Gibilterra.
Invece nacqui io, figlia primogenita di un padre che era un mercante della Galizia orientale, non un avvocato di Łódź come quello che aveva sposato la zia Franca, e nipote di nonna Rosa, che era molto più fiera dell’avvocato di Łódź. La nonna Rosa, infatti, non andava molto fiera di me. Avevo questa sensazione, quando andavamo a trovarla a Cracovia e giocavo con i miei cuginetti. Mi pareva che loro, i figli dell’avvocato di Łódź, fossero più fortunati e più ricchi di me.
Quando il nuovo proprietario polacco disse a sua figlia che solo żyd si scriveva con la minuscola, e che tutte le altre nazionalità si scrivevano con la loro bella maiuscola, mi resi subito conto che, per me, la guerra non sarebbe finita con l’entrata dei russi a Cracovia.
E questo è ciò che accadde.
Nella guerra non c’erano solo aspetti negativi.
Forse perché, quando tutto iniziò, io ero piccola, avevo appena due anni.
A tre anni, a quattro, cinque, e anche in seguito, c’erano stati bei momenti. La mamma, al mattino, cantava arie d’opera e altri brani, e io la pregavo, ancora, ancora. Non volevo mai che smettesse di cantare quelle melodie. Facevamo delle gite, incontravamo persone simpatiche, e c’era persino un giardino tirolese dipinto sui sofà nel salotto di quel mostro, Josef Wirt.
C’era l’aitante Helmutt Sopp, sua moglie Toni, sempre allegra, vestiti puliti e stirati da indossare, con nastri in tinta nei capelli. Nella grande casa della famiglia Sopp c’era buon cibo, spezie odorose in cucina, e molti complimenti: «Frau Anna, es schmeckt gut – è molto buono». C’erano dei ragazzi simpatici, Peter e Ammon, e un grammofono in salotto e una pila di dischi; c’erano i panini freschi, una torta sublime, e il gelato, proprio come al cinema. C’era il quotidiano, Die Zeitung. Imparai a leggere da sola e c’erano bei libri e ospiti di riguardo seduti a una tavola apparecchiata con eleganza. C’erano cose buone da bere e prelibatezze, e si rideva molto. C’era anche un liquore particolare, specialità della mamma, e gli uomini intonavano Oh, Wisła, Wisła. La mamma arrossiva. «Sapeva che il nome Kwiatkowski significa “fiori”?», dicevano, e lei allora era fiera del suo nuovo nome.
Nella stanzetta adiacente alla cucina c’era una finestra affacciata sul cortile, con un albero di lillà che a primavera era carico di fiori, e io me ne stavo a lungo alla finestra, a respirare quel profumo.

Malka Adler è nata in un piccolo villaggio vicino al Lago di Tiberiade, nel nord di Israele. È terapeuta familiare e di coppia e animatrice di diversi club di lettura. Ha iniziato a scrivere quando ha compiuto cinquant’anni e ha all’attivo sei libri, di cui quattro sull’Olocausto. La Newton Compton ha pubblicato I fratelli di Auschwitz, un grande successo di pubblico e di critica, e La valigia di famiglia.