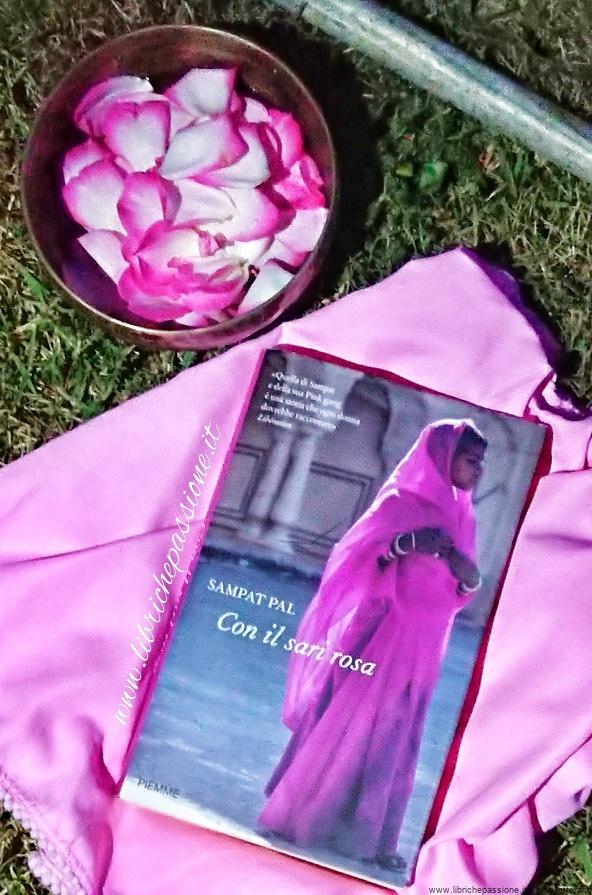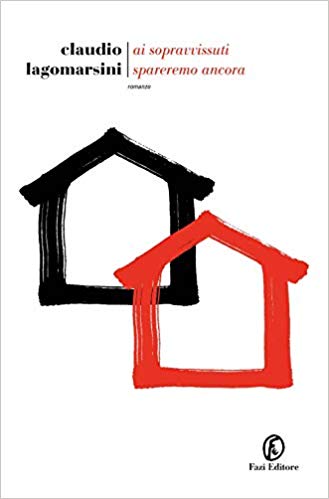
Trama
Una “tragedia della porta accanto” dai toni alti e trasfigurati. Il ritratto lucido e impietoso di un mondo al tramonto visto con gli occhi di un ragazzo, impotente di fronte alla realtà in cui si trova a vivere. Un giovane è costretto a tornare nel paese d’origine per vendere la casa di famiglia: è un ritorno doloroso così come lo è il ritrovamento di cinque quaderni scritti molti anni prima dal fratello maggiore Marcello. Leggendoli per la prima volta, il ragazzo, ormai uomo, ripensa all’estate del 2002 quando i due fratelli vivevano ancora insieme, con la madre e il compagno della donna, soprannominato Wayne. La loro casa era stretta tra quella della nonna materna e quella di un uomo, soprannominato il Tordo. Nei quaderni, Marcello racconta molte cose di quell’estate: le cene all’aperto, le discussioni furibonde tra il Tordo e Wayne, la relazione amorosa tra la nonna e il Tordo, il rapporto conflittuale tra la madre e la nonna. Fra i vari episodi riportati nel diario, uno in particolare sarà quello che scatenerà la serie di eventi che porteranno all’inaspettato e drammatico epilogo. Con uno stile calibrato e una lingua che mescola tratti eleganti a termini più colloquiali, Claudio Lagomarsini riesce a svelare il crepuscolo di un mondo patriarcale, sessista e arretrato, fotografando dall’interno una società destinata a sparire, eppure ancora così rappresentativa del nostro Paese. Tra cene in cortile, litigi per un orto e comportamenti retrogradi, “Ai sopravvissuti spareremo ancora” racconta la quotidianità di un ambiente provinciale piccolo e meschino e l’angoscia di chi con questa quotidianità non riesce più ad avere a che fare. L’attaccamento ai confini della proprietà privata e l’atmosfera oppressiva del nucleo abitato al centro della storia sono il cuore di questo romanzo d’esordio che affronta il dramma di un ragazzo che, pur dotato di un’acuta sensibilità, nulla potrà contro la grettezza e la distanza della famiglia che gli è toccata in sorte.
Estratto
Di tanti che eravamo siamo rimasti in pochi. È toccato a me, alla fine, prendere l’aereo, passare nove ore tra due sconosciuti e noleggiare un’auto da guidare stordito di sonno, per venire qui.
C’è da vendere la casa, e la ragazza dell’agenzia dice che il momento è propizio. Al giorno d’oggi chi ha liquidità compra il mattone e chi ha bisogno di liquidità lo vende.
Nessuno entra in casa da almeno un anno. Dopo la malattia di suo marito, mia madre si è trasferita con lui in un appartamento più piccolo. All’inizio passava dalla vecchia casa una o due volte a settimana per aprire le finestre, ritirare la posta e pulire a rotazione le stanze. Poi ha smesso, dice che non ce la fa più.
Al telefono, quando la sentivo, sembrava sempre più esaurita. È stata lei a insistere perché mi occupassi delle pratiche necessarie alla vendita. Non vuole saperne più di niente, neanche dei soldi. A vendita conclusa posso tenere quello che voglio e lasciarle quel che basta per la sopravvivenza, ha detto.
Tornare nella stradina che porta alla vecchia casa, oggi, mi ha dato un brivido sinistro. Sono passato davanti a un cancello che ricordavo di un altro colore e ho intravisto una ragazza che prendeva il sole in giardino. Era in topless, potrebbe essere la figlia piccola di Paolo, ma non ho saputo riconoscerla. Io me la ricordo che aveva sì e no tre anni, e quella che ho visto oggi ne avrà diciassette o diciotto.
Nello spiazzo davanti a casa l’erba è altissima, come anche in giardino. Bisognerà chiamare qualcuno, anche se non so a chi rivolgermi. Chiederò all’agenzia.
Mentre cercavo le chiavi giuste nel mazzo, ho guardato verso la casa di Carlo e poi verso quella in cui abitava mia nonna. Insieme alla nostra, formano un ferro di cavallo con al centro il parcheggio. Percorrendo un vialetto ci si immette in un reticolo di stradine. Le case sono tutte uguali: l’intonaco color pesca, la siepe di pitosfori, il ghiaino bianco, omogeneo, abbacinante.
Entrando in casa mi aspettavo di trovare un odore sgradevole. Quindi mi ha sorpreso riconoscere, mescolato all’odore di chiuso, anche un aroma di legno che mi è capitato di annusare in certe pievi di montagna e che non sentivo da moltissimo tempo. È bastato arieggiare le stanze per mezz’ora e l’odore è svanito.
La persona con cui ho parlato in agenzia, una ragazza del tipo peperino che mal sopporto, ha pensato a tutto. Quando sono passato da lei, ieri, mi ha dato un pennarello rosso e si è raccomandata di fare una croce sulle scatole da buttare. Su ogni scatola qualcuno ha scritto in stampatello quel che c’è dentro. Le diciture, molto generiche, parlano di asciugamani, bicchieri, libri o DVD. Non che sia rimasto molto, forse una ventina di scatole. La ragazza mi ha spiegato che quelle con la croce rossa verranno smaltite (ha usato lei quest’espressione). Se ne occuperanno direttamente i traslocatori: gli stessi, già contattati da lei, che provvederanno a portare le scatole non segnate all’indirizzo che indicherò. Il problema è che non ho nessun indirizzo da dare, mia madre non vuole nulla di ciò che si è lasciata alle spalle, e a me, un oceano più in là e un emisfero più in giù, non servono né i set di bicchieri né i vecchi asciugamani o i DVD.
Con la scusa di alcuni impegni di lavoro mi fermerò il meno possibile. Mi aggiro tra le scatole come un angelo della morte, sbuffando come un treno a vapore. L’insofferenza e il fastidio di essere qui prevalgono sulla nostalgia. Segno croci rosse senza misericordia, condanno allo smaltimento vasellame e soprammobili. Do un’occhiata solo ai libri, ma senza intenzione, come se fossi al banco di un robivecchi. In genere non compro niente neanche là, mi piace solo curiosare, far camminare le dita sul taglio di testa per scorrere titoli che in genere non conosco.
Ci sono più che altro vecchi manuali di scuola, libri di mia madre sulle pietre magiche (che a quanto vedo non le interessano più), poca narrativa di autori sconosciuti, direi scandinavi a giudicare dai nomi pieni di Å e Ø.
Tra le scatole ce ne sono diverse con la scritta «VARIE». Non avrei nessuna voglia di aprirle. Faccio le mie croci con rabbia. Ne apro una su cui si posa un moscone che è entrato quando ho spalancato le finestre. Mi capitano in mano una calcolatrice, un righello, l’adattatore di una presa elettrica per l’estero, residuo di una vacanza. Sul fondo ci sono alcuni piccoli quaderni Monocromo, ognuno di un colore diverso. Li conto, sono cinque.
Prendo in mano il primo, inizio a sfogliarlo ma fatico a leggere. Non riesco a decifrare quasi nessuna parola, è una grafia veloce che a una prima occhiata potrebbe essere arabo, tutta linee orizzontali e punti. Può mai essere che…
Mi ci è voluto qualche secondo. Quando riconosco la grafia piccola e nervosa di Marcello il cuore mi balza in gola. Impiego diversi minuti per imparare di nuovo a leggerla, capire che quella che sembra una l è in realtà una b, quella che leggevo come n dev’essere una doppia s, e la g è tracciata in quel modo stilizzato che la rende troppo simile a una q.
Sfogliando, scorrendo passaggi a caso, mi accorgo che dev’essere il manoscritto del suo romanzo. Me ne parlava spesso, quell’estate. Qualche pagina è stata strappata. Trovo un paio di brani interamente cassati con cancellature che, a seconda della pressione lasciata dalla penna, possono esprimere pudore o rabbia.
Del suo romanzo Marcello mi raccontava a voce alcune parti, senza mai lasciarmi leggere niente. A pensarci bene, non l’ho mai visto scrivere su questi quaderni. Tranne una volta che ricordo benissimo. E ricordo che mentre scriveva la penna faceva rumore sulla carta, e sembrava che lui avesse la febbre, e ogni tanto doveva cambiare penna perché la sfera si riscaldava e l’inchiostro lasciava grumi e sbavature.
Quell’estate, l’estate della mia terza superiore, stavo tutto il giorno al mare. Non ho ricordi precisi, distinti. Mi resta in mente, come in un video mandato al fast forward, una lunga sequenza di sbornie, scherzi, pallonate, gavettoni, uscite con gli amici, baci con troppa saliva e sigarette fumate dietro alle cabine del Bagno Universo.
Marcello non era come noi. Molti, a scuola, dicevano o lasciavano intendere che era strano, mio fratello: più inquieto e, allo stesso tempo, più posato di me. Stava a casa, preferiva rimanere bianchiccio, e leggeva, studiava, scriveva cose che non faceva vedere a nessuno. Distanziati di appena diciotto mesi, non andavamo d’accordo. Era l’età in cui i fratelli comunicano, più che altro, a cazzotti, calci e parolacce. Era difficile che facessimo qualcosa insieme e, se capitava, finivamo puntualmente per stuzzicarci e litigare.
Ma per qualche ragione, quando mi raccontava del suo romanzo, lo stavo ad ascoltare senza fare l’idiota. Forse mi rilassava, e allora gli restituivo opinioni che lui riceveva in silenzio, misurando accuratamente il peso di ognuna delle mie critiche.
Più che raccontarmi scene con uno svolgimento, mi spiegava come le scene stesse avrebbero dovuto essere: qui deve stare il ritratto grottesco di Tizio, diceva; poi segue un dialogo tra Caio e Sempronio, che però è via via interrotto, ma con naturalezza, da una descrizione molto vivida di questo e quest’altro, che finisce per prendere il sopravvento sul dialogo. Cose di questo tipo.
Di quello che lui chiamava il suo romanzo, quindi, conoscevo finora le speranze e le buone intenzioni: le note di regia.
Qualche volta diceva, per incentivarmi ad aiutarlo, che forse con il suo romanzo sarebbe diventato ricco e avrebbe comprato una villa a Forte dei Marmi. Se gli fosse avanzato qualcosa, avrebbe preso una villetta anche per me: più piccola, scherzava, a Marina di Massa, dove costano meno.
Leggendo un’altra pagina a caso riconosco, nei nomi mutati e nei nomignoli, nei caratteri esagerati e distorti, alcuni di noi. In un primo momento sento lievitare un’attesa venata di timore, che potrebbe tradursi in una domanda egocentrica: quale aspetto avrò sotto la penna di Marcello?
Anche se le righe scorrono e non mi trovo ancora, proseguo alla ricerca di qualcosa. Non mi interessa più riconoscermi, a questo punto. All’improvviso la motivazione che mi fa andare avanti prende i tratti della necessità: un’urgenza che si concretizza in un affanno. Perché finalmente mi rendo conto che dopo quindici anni mi è appena stata concessa l’occasione di ascoltare mio fratello come non l’avevo mai fatto.
Comincio a seguire una descrizione che via via lascia spazio al racconto e diventa una scena vera e propria. Leggo camminando per la stanza, respirando l’odore umido del quaderno. Finisco per riconoscere i fatti, per intravedere anche me stesso in un personaggio che lui chiama, non capisco perché, “il Salice”. Vado avanti, leggo un’altra pagina. Poi un’altra, e un’altra ancora. E un’altra.
La lingua italiana, la lingua di Marcello, che dopo molti anni mi viene restituita così, a tratti indecifrabile, ghirigoro nervoso in inchiostro blu, mi sembra spigolosa e refrattaria. Anche se è la mia lingua, ormai non la parlo quasi più. Mi capita qualche volta, è vero, di fare sogni in cui parlo o mi parlano in italiano. Sono sogni che rimandano a quell’epoca o a quando ero bambino.
Leggo alcune frasi con l’intonazione di Marcello. Ricordo come, parlando del più e del meno, rallentava ad arte per sorprenderci con un parolone che aveva imparato dai libri (sfogliando mi imbatto in «lallazione», che scandisco mentalmente come l’avrebbe pronunciata lui). Oppure, con quel modo un po’ antipatico che hanno i liceali, infilava nelle chiacchiere di tutti i giorni, spesso a sproposito, riferimenti a cose che aveva studiato: tragedie greche, poeti medievali, teorie di filosofi. Una cultura a tutto tondo che, nella vita di adulti affaccendati, non avrà più occasione di manifestarsi, sarà riassorbita in una distratta ignoranza di ritorno.
Mentre avanzo a salti nella lettura, tra scene all’apparenza staccate, ricostruisco brandelli di una storia più coerente. È il racconto ora realistico ora allucinato di ciò che è successo quell’estate a partire dalla rapina nella casa di Carlo, il nostro vicino. Tra le righe intravedo anche, in alcuni dettagli, una profezia sinistra. Ma è troppo facile interpretare in questo modo, tornare indietro per piegare il passato in funzione di un futuro che già conosciamo.
Dopo qualche pagina è più chiaro perché mia madre, incapace di gettare
via i quaderni, ha rifiutato di tenerli con sé: lei non ne esce bene. Ma non ne esce bene nessuno, mamma. E Marcello è impietoso soprattutto con se stesso.
Alzo il telo che copre il divano e mi aggiusto come posso sui cuscini sfondati, frastornato da una miscela di amarezza, angoscia e disincanto.
Faccio ordine tra i quaderni, li poso su quello che mia madre chiamava il tavolino da tè, anche se, come mi ha ricordato Marcello in una pagina che ho sfogliato, non le piaceva il tè e non invitava mai nessuno a berlo.
I quaderni portano un numero scritto a penna sulla copertina. Quando trovo il primo e lo apro, leggo una lista di titoli barrati. Ne rimane uno, più o meno al centro dell’elenco:
Banchetto d’estate
Gazebo
Per l’impero di Wayne
Ai sopravvissuti spareremo ancora
Epopea di un orto
Il maschio forte
QUADERNO 1
Non importa se è il 16 giugno 2002, perché questo non è un diario. Il mio professore di Italiano ha detto che i diari sono un passatempo che si può concedere a preadolescenti ebree assediate dai nazisti.
Stanotte c’è stata una rapina nella casa qui davanti: la casa del Tordo. Mamma e nonna sono in fibrillazione come se avessero rubato in casa loro.
Dalla finestra guardo il Tordo che parla con un carabiniere e si tocca il taschino del gilè da pescatore, quello beige che porta sempre. Quando si agita, se si arrabbia o si diverte, la bocca prende una piega innaturale, e la linea dei denti sembra andare in obliquo.
Il carabiniere scrive su un taccuino, mentre il Tordo continua a piegare i denti, a tormentarsi le cento tasche del gilè. Sempre più alterato comincia a tremare, all’inizio impercettibilmente, poi più forte.
E suda, suda sulla fronte e nello scollo della canottiera. Del resto sudo anch’io, dentro casa. E suda mamma, suda nonna. Più di tutti, però, suda il carabiniere, nella camicia azzurra di cotone pesante, nelle scarpe con il calzino lungo, nei pantaloni listati di rosso.
Esco dal cancello e mi avvicino. Sento nonna che si lamenta con il suo sussurro canonico, la voce assordita ma alta. Si comporta come quei personaggi teatrali che fanno gli “a parte”. Con il problema che, nel caso suo, gli altri personaggi la sentono benissimo e non sanno come regolarsi, se farle notare che si è sentito tutto o lasciar correre.
Il carabiniere preferisce far finta di niente mentre per la quarta volta lei grida-sussurra che viviamo in un bel paese di merda. All’inizio penso che lo dica per via della rapina, per i malviventi, sicuramente immigrati, e per i vigili che non vigilano, lo Stato che non c’è stato: le cose che sente a Studio Aperto e che ripete ossessivamente. Invece parla di un’altra questione: pare che il Tordo, prendendo confidenza con il carabiniere, lamentandosi con lui come se fosse non un pubblico ufficiale ma uno degli amici che lo raggiungono per bere un bianchino, si sia lasciato sfuggire che gli hanno rubato anche la Beretta nel comodino.
«Come nel comodino?», gli ha chiesto il carabiniere, tornando
a bomba alla ragion di Stato. «Secondo la legge le armi da fuoco vanno custodite sottochiave in luoghi a prova di scasso. Qui si rischia l’omessa custodia, c’è un anno di reclusione».
Allora il Tordo ha alzato la voce, di colpo ha deviato la discussione verso cose ben più importanti di una pistola custodita nel comodino, nella credenza, nel frigorifero o dove la legge vuol farcela ficcare. Tremava e sbuffava come una caffettiera dimenticata sul fuoco, e alla fine è esploso: «Quindicimila euro. Mi han rubato quindicimila euro, diocane!».
Il carabiniere scrive fitto fitto, e sarei curioso di sbirciare nel taccuino. Forse mette omississulla bestemmia e si annota la cifra. A quanto pare il Tordo teneva anche i soldi nel comodino, tutti in contanti. Nonna scuote la testa, io sgrano gli occhi.
«Quindicimila?».
Siamo ancora tutti confusi da questo fatto dell’euro, dobbiamo farci l’abitudine.
«Eh, trenta milioni», fa mamma, convertendo a spanne nella valuta che ci è più congeniale.
Il Tordo dice – lo sta gridando, in effetti, dopo che il carabiniere è tornato a incalzarlo sulla pistola – che lui delle banche non si fida. E se per caso deve partire all’improvviso, nel cuore della notte? Se si presentasse questa evenienza, lui vuole essere sicuro di avere tutti i soldi che gli servono, senza dover prendere la macchina e chiedere per favore i propri soldi a una banca, magari scusandosi per la cifra troppo alta. Tanto è vero, continua, che tiene sempre addosso quattrocento euro. Si tocca il taschino del gilè, come a promettere che può tirarli fuori, farli contare, pretendere che sia messo tutto a verbale, se gli gira.
Sulla Beretta (non può continuare a far finta di niente) ritratta spudoratamente, dice che prima si è sbagliato, nel comodino teneva solo le chiavi. La pistola stava là dove ha detto il carabiniere: in cassaforte. Nel comodino c’erano i quindicimila euro, prima si è solo confuso, fa un caldo boia. Vuole assaggiare, il carabiniere, un bianco frizzante che fa il contadino?
Il Tordo ha superato gli ottant’anni, ha passato gli ultimi sessanta nella stessa piccola città, e il carabiniere non si capacita − noi non ci capacitiamo − di dove una persona della sua età dovrebbe andarsene da un giorno all’altro, in piena notte, con quindicimila euro.
«In America», fa lui, spazientito. A far visita al suo amico Nedo, spiega, che gestisce una catena di casinò e che lui non vede da vent’anni. Ci sarebbe anche già andato, se non fosse per sua moglie. Il carabiniere non commenta, si limita ad annotare.
«Chi c’era in casa?», chiede poi, a bruciapelo. Il Tordo dice che c’era sua moglie. Sua moglie che è paralitica. Dormiva e non si è accorta di niente.
«Sospetti?». Il Tordo dice no, nessuno.
Nonna crede di essere in una puntata di Montalbano: è eccitata dalla rapina, dal carabiniere, dall’interrogatorio. Non si dà quiete, fa avanti e indietro, si rosicchia le unghie. A un certo punto grida-sussurra che di sicuro c’entra quella troia della rumena. Che son tutte bagasce, quella razza lì.
Parla della badante che aiuta il Tordo con la paralitica. Ieri, guarda caso, ha detto che oggi non sarebbe venuta perché doveva andare in ospedale per una visita specialistica. Bel modo per crearsi un alibi mentre i suoi amichetti ripulivano la casa. Proprio un bel modo.
Il Tordo ha affibbiato alla badante un nomignolo dei suoi, il Lattone, che nel nostro dialetto vorrebbe dire “grosso barile di latta”. Se gli chiedi perché la chiama così, lui gigioneggia e ti spiega che la rumena è perfettamente cilindrica, e l’unico modo per capire dove stanno il davanti e il dietro è guardare da che lato puntano le scarpe.
In tutta questa confusione, è una fortuna che al Tordo non sia scappato detto del Razzo. Chiama così un fucile che tiene, appeso in bella vista, nel ricovero attrezzi dietro casa. È un vecchio arnese da caccia che il Tordo evoca spesso, quando si parla di proprietà privata, criminalità, terrorismo o immigrazione. O anche nel periodo di Pasqua, se gli capita in mano un volantino che annuncia il giro del prete per le benedizioni delle case.
«Ma lei dov’era, ieri notte?».
Il Tordo esita, guarda il carabiniere, sbircia verso di noi. È una domanda banale, ma è sufficiente a spiazzarlo. A dire il vero non ci avevo pensato nemmeno io. È che non siamo preparati all’idea che la vittima debba rendere conto. Prima la Beretta, poi la fuga con i quindicimila euro, poi dov’eri ieri sera. Sembra che il ladro sia lui. È questo che nonna cercava di dire con la storia del paese di merda.
«Ero a casa della signora».
Il carabiniere si gira verso di noi. Il mento del Tordo ha puntato, a sorpresa, in direzione di nonna.
Guardo mamma, ne indovino l’imbarazzo. Senza fare una piega, nonna declina le sue generalità, che il carabiniere annota. Il Tordo si affretta a spiegare, dice che a volte lui e la signora, che poi sarebbe la sua vicina, guardano la TV per passare un po’ il tempo e scambiare due chiacchiere dopo cena. Capita che lui si addormenti sul divano, lei gli butta addosso una coperta e se ne va a dormire al piano di sopra. Lui si sveglia da sé la mattina presto, prima che arrivi la badante. A volte fa il caffè e ne lascia un po’ per nonna, che lo usa per macchiare il latte. A ottant’anni uno che cazzo deve fare.
A mamma non è mai andata giù la condotta disinvolta che nonna si è data in materia di uomini da quando, ormai trent’anni fa, ha divorziato. Mamma è per le relazioni lunghe, solide, serie. Dopo essersi separata, nel 1992, si è subito messa con Wayne, e mentre scrivo l’anno mi rendo conto che è già passato un sacco di tempo. All’epoca ero un bambino, e il Salice, mio fratello, era poco più che uno scricciolo.
Forse mamma ha scelto di rimanere con lui perché, a differenza di mio padre, di me, anche di lei, Wayne ha sempre le idee chiare su tutto.
Sulla rapina, ad esempio. Lui dice che i carabinieri sono dei passacarte, quasi sempre terroni, voglia di lavorare saltami addosso, messi lì per conoscenze o clientelismo politico, oppure infilati nei gangli del sistema dalla mafia stessa, che ha bisogno di pedine da controllare. Per tutti questi motivi i carabinieri non seguiranno mai la pista d’indagine che lui, invece, percorrerebbe. Sono così idioti che non ci arriverebbero nemmeno se lui facesse un bel dossier rilegato e lo mandasse in procura. Perché nella faccenda della rapina, ed è chiaro come il sole, sono coinvolti i Pretoriani, i vigilantes che, guarda caso, hanno monopolizzato il servizio di sicurezza notturna nella nostra zona. Sempre più spesso li vediamo ronzare nelle stradine qui intorno, con le loro torce e le loro macchine…

Jenny